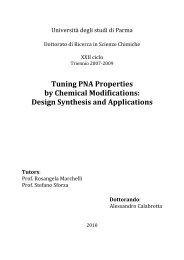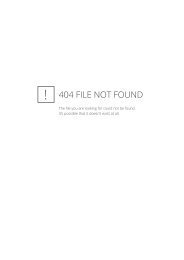Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Italo Calvino ha parlato, a proposito di Caproni, di una poesia senza idillio: 47 il rapporto<br />
tra il tempo, la natura e l’uomo procede verso una negatività <strong>che</strong> non lascia spazio alla<br />
speranza. 48 Se in Come un’allegoria gli uccelli si confondevano con le stelle, quasi a<br />
dirne la medesima sostanza naturale e divina («il sangue ferveva / di meraviglia, a<br />
vedere / ogni uccello mutarsi in stella nel cielo», Ricordo), nel Seme del piangere<br />
vengono sostituiti dalla «tenebra d’un apparecchio» (Due appunti 2. Maggio, 1) <strong>che</strong><br />
porta la guerra, e in Res amissa lo sfaldamento ne farà «dispersi brandelli» di una<br />
divinità negativa (Alzando gli occhi). Così, ad esempio, in Träumerei, (Il franco<br />
cacciatore) ai segni vitali delle «musi<strong>che</strong> trasparenti / tra i fiori» e agli «spiazzi<br />
dell’infanzia» si alternano «Le trombe militari», «Gli spari», «la notte dura / […]<br />
dell’ossidiana», e, nell’articolazione complessa della poesia, la memoria idilliaca di<br />
Alcina va a cozzare con Hiroshima, mentre altri luoghi della disumanità (Dachau,<br />
Piazza Fontana) vengono evocati. L’unico riparo dall’insopportabile «rumore / della<br />
storia» (Albàro) tornerà ad essere la natura, l’«antistoria» di Odor vestimentorum, sola<br />
voce e tuttavia inquietante, sola presenza nel buio deserto del post-umano: «Ero solo.<br />
Andavo. / Seguivo una buia viottola. / Mi batteva il cuore. Ascoltavo / (non c’era altra<br />
voce) la nottola» (La nottola). L’orrore non è solo quello della fine incombente, ma è<br />
an<strong>che</strong> la sensazione <strong>che</strong> tutt’intorno si stia diffondendo il vuoto, come in un muto<br />
assedio, cancellando qualunque presenza umana, come se la realtà fosse già invasa dalla<br />
morte.<br />
Al contrario le liri<strong>che</strong> di Penna<br />
sembrano […] tutte risolte nel bisogno impellente di dire nella sua<br />
immediatezza l’esistenza, di rendere immobili le immagini, di fermare sulla<br />
carta e concentrare il vissuto in un punto […]. Per questo nella sua<br />
immanenza e imminenza il presente è pronto a tradursi nel passato […] della<br />
memoria, di ciò <strong>che</strong> è già stato. 49<br />
47 Italo Calvino, Nel cielo dei pipistrelli, in «la Repubblica», 19 dicembre 1980. Poi col titolo Il taciturno<br />
ciarliero, in AA.VV., Genova a Giorgio Caproni, a cura di Giorgio Devoto e Stefano Verdino, Genova, S. Marco dei<br />
Giustiniani, 1982. Ora, col titolo Il taciturno ciarliero (per Giorgio Caproni), in Italo Calvino, Saggi, cit., p. 1025.<br />
48 Cfr. Fabio Moliterni, Poesia e pensiero nell’opera di Giorgio Caproni e di Vittorio Sereni, cit., p. 172: «in<br />
Caproni, come nelle frequenti liri<strong>che</strong> sereniane, l’interrogazione drammatica sul tempo dell’uomo è suscitata,<br />
generata dalle immagini (dalla presenza, dall’animarsi) della natura».<br />
49 Daniela Mar<strong>che</strong>schi, Sandro Penna. Corpo, tempo e narratività, Roma, Avagliano Editore, 2007, pp. 65-66.<br />
32