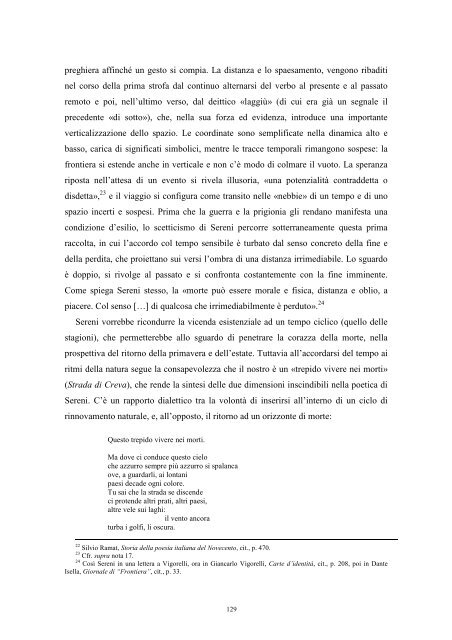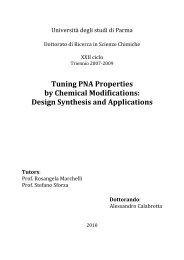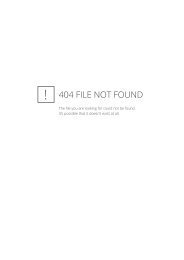Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
preghiera affinché un gesto si compia. La distanza e lo spaesamento, vengono ribaditi<br />
nel corso della prima strofa dal continuo alternarsi del verbo al presente e al passato<br />
remoto e poi, nell’ultimo verso, dal deittico «laggiù» (di cui era già un segnale il<br />
precedente «di sotto»), <strong>che</strong>, nella sua forza ed evidenza, introduce una importante<br />
verticalizzazione dello spazio. Le coordinate sono semplificate nella dinamica alto e<br />
basso, carica di significati simbolici, mentre le tracce temporali rimangono sospese: la<br />
frontiera si estende an<strong>che</strong> in verticale e non c’è modo di colmare il vuoto. La speranza<br />
riposta nell’attesa di un evento si rivela illusoria, «una potenzialità contraddetta o<br />
disdetta», 23 e il viaggio si configura come transito nelle «nebbie» di un tempo e di uno<br />
spazio incerti e sospesi. Prima <strong>che</strong> la guerra e la prigionia gli rendano manifesta una<br />
condizione d’esilio, lo scetticismo di Sereni percorre sotterraneamente questa prima<br />
raccolta, in cui l’accordo col tempo sensibile è turbato dal senso concreto della fine e<br />
della perdita, <strong>che</strong> proiettano sui versi l’ombra di una distanza irrimediabile. Lo sguardo<br />
è doppio, si rivolge al passato e si confronta costantemente con la fine imminente.<br />
Come spiega Sereni stesso, la «morte può essere morale e fisica, distanza e oblio, a<br />
piacere. Col senso […] di qualcosa <strong>che</strong> irrimediabilmente è perduto». 24<br />
Sereni vorrebbe ricondurre la vicenda esistenziale ad un tempo ciclico (quello delle<br />
stagioni), <strong>che</strong> permetterebbe allo sguardo di penetrare la corazza della morte, nella<br />
prospettiva del ritorno della primavera e dell’estate. Tuttavia all’accordarsi del tempo ai<br />
ritmi della natura segue la consapevolezza <strong>che</strong> il nostro è un «trepido vivere nei morti»<br />
(Strada di Creva), <strong>che</strong> rende la sintesi delle due dimensioni inscindibili nella poetica di<br />
Sereni. C’è un rapporto dialettico tra la volontà di inserirsi all’interno di un ciclo di<br />
rinnovamento naturale, e, all’opposto, il ritorno ad un orizzonte di morte:<br />
Questo trepido vivere nei morti.<br />
Ma dove ci conduce questo cielo<br />
<strong>che</strong> azzurro sempre più azzurro si spalanca<br />
ove, a guardarli, ai lontani<br />
paesi decade ogni colore.<br />
Tu sai <strong>che</strong> la strada se discende<br />
ci protende altri prati, altri paesi,<br />
altre vele sui laghi:<br />
il vento ancora<br />
turba i golfi, li oscura.<br />
22<br />
Silvio Ramat, Storia della poesia italiana del Novecento, cit., p. 470.<br />
23<br />
Cfr. supra nota 17.<br />
24<br />
Così Sereni in una lettera a Vigorelli, ora in Giancarlo Vigorelli, Carte d’identità, cit., p. 208, poi in Dante<br />
Isella, Giornale di “Frontiera”, cit., p. 33.<br />
129