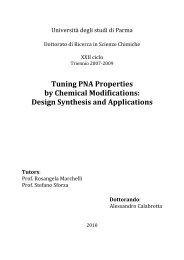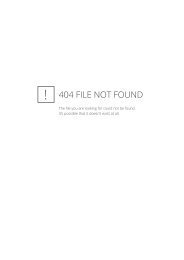Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Benjamin nelle sue Tesi di filosofia della storia, emerge dalla «continuità della storia» 91<br />
per realizzare compiutamente il passaggio dalla recensione della realtà alla sua<br />
interpretazione. 92<br />
Da questi flash, <strong>che</strong> rileggono l’esperienza soggettiva nel suo reagire all’interno della<br />
forma poetica, nasce una particolare visione delle cose («io veggente di colpo» scrive In<br />
una casa vuota, e poi «adesso vedo» in Sarà la noia): una visione <strong>che</strong> sembra<br />
realizzarsi attraverso un cannocchiale rovesciato, <strong>che</strong> tutto distanzia. Il passato,<br />
emergendo nel presente, inevitabilmente crea una distanza, anziché colmarla. 93 Il poeta<br />
guarda lontano, ma guarda soprattutto da lontano («là» è il deittico spaziale <strong>che</strong> marca<br />
la distanza). La visione entra nel turbine delle affermazioni e negazioni <strong>che</strong> determinano<br />
un approccio instabile col reale, <strong>che</strong> si confonde col sogno e con l’ossessione («nuove<br />
ombre mi inquietano <strong>che</strong> intravedendo non vedo», Lavori in corso, I). Se la poesia è il<br />
luogo dell’apocalisse, della rivelazione, lo è all’interno di una fenomenologia del<br />
negativo, <strong>che</strong> mette in discussione le cose e la struttura stessa del testo, il soggetto e<br />
l’oggetto. Si arriva a minare i fondamenti stessi dell’essere e del tempo:<br />
Non vorrai dirmi <strong>che</strong> tu<br />
sei tu o <strong>che</strong> io sono io.<br />
Siamo passati come passano gli anni.<br />
Altro di noi non c’è qui <strong>che</strong> lo specimen<br />
anzi l’imago perpetuantesi<br />
a vuoto –<br />
e acque ci contemplano e vetrate,<br />
ci pensano al futuro: capofitti nel poi,<br />
postille sempre più fio<strong>che</strong><br />
91 Ivi, p. 83. Si legga a questo proposito an<strong>che</strong> Laura Barile, Il passato <strong>che</strong> non passa. Le «poeti<strong>che</strong> provvisorie»<br />
di Vittorio Sereni, Firenze, Le Lettere, 2004, pp. 191-200.<br />
92 Cfr. Walter Benjamin, Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, cit., p. 28: «un evento vissuto è<br />
finito, o perlomeno è chiuso nella sola sfera dell’esperienza vissuta, mentre un evento ricordato è senza limiti, poiché<br />
è solo la chiave per tutto ciò <strong>che</strong> è avvenuto prima e dopo di esso».<br />
93 Si legga quanto scrive Franco Rella, Dall’esilio. La creazione artistica come testimonianza, Milano, Feltrinelli,<br />
2004, p. 94: «Non si può ricomporre il passato infranto in un ordine. […] Il problema non è ricomporre il passato, ma<br />
redimerlo. Tale redenzione secondo Benjamin è possibile solo nell’istante, nell’ora, in cui un frammento di ciò <strong>che</strong><br />
viviamo si intrama con un frammento del passato, e nella tensione <strong>che</strong> si apre tra loro, nella loro differenza, si<br />
sprigiona il senso dell’ora e dell’allora. L’attimo si carica così di tempo fino a scoppiare, e diventa storia. Benjamin<br />
chiama questo attimo l’ora della conoscibilità. Ma noi sappiamo <strong>che</strong> proprio dell’attimo non è possibile fare storia».<br />
Gli attimi di Sereni non sono emblemi di riscatto e salvezza e quando in Un posto di vacanza IV scrive <strong>che</strong> è<br />
«custode non di anni ma di attimi», indica l’impossibilità di leggere e interpretare la vita come una totalità omogenea<br />
cronologicamente e razionalmente interpretabile, ma piuttosto come un succedersi di eventi, <strong>che</strong> hanno abitato in noi,<br />
ma <strong>che</strong> ora sono già altrove. Non c’è ordine, ma discontinuità e contraddizione. Da Nietzs<strong>che</strong> in poi i tentativi di<br />
percepire il senso della discontinuità della storia sono numerosi, e si potrebbero citare Benjamin stesso, o Foucault, e<br />
Sereni percepisce il senso doloroso di questa vita <strong>che</strong> non è più storicizzabile, non è più possibile raccontarla, ma<br />
soltanto scriverla: «Non scriverò questa storia – mi ripeto, se mai / una storia c’era da raccontare» (Un posto di<br />
vacanza II): «Avendo scritto: non scriverò questa storia debbo essermi illuso di avere una storia da raccontare.<br />
Invece era un modo per dire <strong>che</strong> avevo una poesia da scrivere e <strong>che</strong>, potendo, avrei continuato a scriverla. Il<br />
corrispondente dell’altra riva doveva essersi offeso, non mi esortava più alle storie. […] Ho detto: è la fine di tutte le<br />
storie, forse della storia stessa» (Vittorio Sereni, Poesie, cit., pp. 742-743).<br />
151