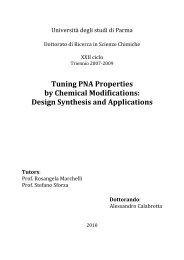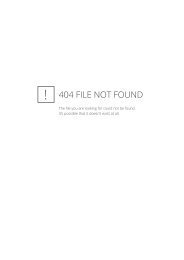Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ma già presenti in noi e nelle cose. 47 Il poeta non inventa niente, non si abbandona ad<br />
una fantasia <strong>che</strong> allontani dalla realtà. 48 Non è la poesia <strong>che</strong> conferisce senso al mondo,<br />
creandone uno fittizio, perché l’atto poetico non è anteriore alla percezione, esso è,<br />
invece, «percezione di realtà <strong>che</strong> fermenta e prolifera», 49 mezzo attraverso cui la<br />
percezione del mondo ci porta alla comprensione: 50<br />
Ci sono momenti della nostra esistenza <strong>che</strong> non danno pace fino a quando<br />
restano informi e an<strong>che</strong> in questo, almeno in parte, è per me il significato<br />
dello scrivere versi. 51<br />
Esistono cose <strong>che</strong> mi hanno impressionato in un senso o nell’altro e<br />
dunque tutte, possibilmente, vanno scritte. Non ho una cosa da affermare in<br />
assoluto, una mia «verità» da trasmettere. Ho dei conti da saldare con<br />
l’esperienza. 52<br />
Sono uno scrittore <strong>che</strong> parte da una base autobiografica. In generale, se io<br />
ho visto, ascoltato, vissuto per esperienza diretta una cosa, ci sono probabilità<br />
<strong>che</strong> questo dia dei frutti di poesia, diciamo così. Se questa cosa io non l’ho<br />
vissuta nella sua origine diretta, immediata, sul suo spunto autobiografico,<br />
per averla constatata, percepita attraverso i sensi e l’emotività, è<br />
difficilissimo <strong>che</strong> io ci possa scrivere qual<strong>che</strong> cosa sopra. 53<br />
47 Così Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 51: «[…] proprio perché percepiamo un<br />
insieme come cosa, l’atteggiamento analitico può in seguito discernervi somiglianze o contiguità. Ciò non significa<br />
solo <strong>che</strong>, senza la percezione del tutto, noi non penseremmo a notare la somiglianza o la contiguità dei suoi elementi,<br />
ma letteralmente <strong>che</strong> questi non farebbero parte del medesimo mondo e <strong>che</strong> quelle non esisterebbero affatto».<br />
48 Egli arriva per questa via a percorrere lo spazio di un disagio <strong>che</strong> da individuale si fa esistenziale, ovvero<br />
collettivo: «[L’esperienza] non consiste tanto di singoli eventi esattamente fissati nel ricordo quanto di dati<br />
accumulati, spesso inconsapevoli, <strong>che</strong> confluiscono nella memoria. […] Dove c’è esperienza nel senso proprio del<br />
termine, determinati contenuti del passato individuale entrano in congiunzione, nella memoria, con quelli del passato<br />
collettivo» (Walter Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi,<br />
1962, pp. 91, 93).<br />
49 Vittorio Sereni, Dovuto a Montale, in Gli immediati dintorni, ora in La tentazione della prosa, cit., p. 149.<br />
50 Si veda Pier Vincenzo Mengaldo, La tradizione del Novecento. Seconda serie, cit., pp. 316-317: «Seppure in<br />
senso diverso da Montale, an<strong>che</strong> Sereni avrebbe potuto dire di sé <strong>che</strong> non inventava nulla. La sua poesia nasceva a<br />
stretto contatto coi fatti e fenomeni, esterni e più spesso interni, incessanti, incessantemente ruminati […]. Ciò vuol<br />
dire, contro la moderna superbia della poesia […] <strong>che</strong> i fatti e dunque la vita, avevano un valore e una dignità in sé<br />
<strong>che</strong> si trasferivano per riverbero e impregnazione su quelli della poesia, e non viceversa. Sereni era l’antitesi del poeta<br />
orfico; era un poeta esistenziale».<br />
51 Vittorio Sereni, Poesie, cit., pp. 585-586.<br />
52 Vittorio Sereni, <strong>Una</strong> vicenda amicale: lettere di Vittorio Sereni, a cura di Giancarlo Buzzi, «Concertino», a. 1,<br />
n. 1, giugno 1992, p. 43. Si legga an<strong>che</strong> Un posto di vacanza, V: «“Ho un lungo conto aperto” gli rispondo. / “Un<br />
conto aperto? di parole?”. “Spero non di sole parole”».<br />
53 Vittorio Sereni, dichiarazione a Gian Carlo Ferretti, «Rinascita», a. 30, n. 15, 13 aprile 1973, p. 32 ora in Gian<br />
Carlo Ferretti, Poeta e di poeti funzionario. Il lavoro editoriale di Vittorio Sereni, cit., p. 132. Ma si legga an<strong>che</strong><br />
quanto scrive Vittorio Sereni in Un tacito mistero. Il carteggio Vittorio Sereni-Alessandro Parronchi (1941-1982),<br />
cit., lettera 24, p. 65: «Per il resto, oggi, non c’è più niente, né Luino, né l’Africa, né la guerra. Il <strong>che</strong> vuol dire <strong>che</strong> ho<br />
sempre avuto bisogno – e questo è male – di cercare la poesia fuori di me»; lettera 27, p. 74: «Scrivo sempre a<br />
distanza di anni senza mai prescindere da una lunga memoria»; e an<strong>che</strong> Vittorio Sereni nell’intervista a Anna Del Bo<br />
Boffino, Il terzo occhio del poeta, «Amica», 28 settembre 1982, p. 156, ora in Vittorio Sereni, Poesie, cit., p. 582: «In<br />
senso positivo ciò significa necessità di maturazione di un motivo; in senso negativo, lentezza, pigrizia, impotenza,<br />
remora psicologica, paura. In ogni caso quell’aspetto dell’“impegno” per cui la poesia o lo scrivere hanno un peso<br />
nella misura in cui concorrono al formarsi della storia mi è totalmente estraneo».<br />
138