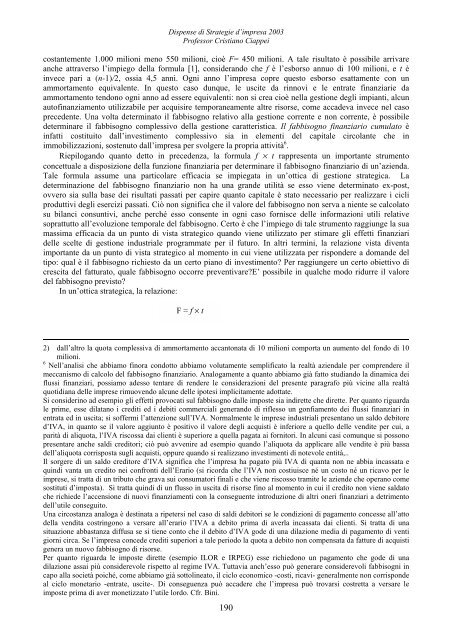DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dispense di Strategie d’impresa 2003Professor Cristiano Ciappeicostantemente 1.000 milioni meno 550 milioni, cioè F= 450 milioni. A tale risultato è possibile arrivareanche attraverso l’impiego della formula [1], considerando che f è l’esborso annuo di 100 milioni, e t èinvece pari a (n-1)/2, ossia 4,5 anni. Ogni anno l’impresa copre questo esborso esattamente con unammortamento equivalente. In questo caso dunque, le uscite da rinnovi e le entrate finanziarie daammortamento tendono ogni anno ad essere equivalenti: non si crea cioè nella gestione degli impianti, alcunautofinanziamento utilizzabile per acquisire temporaneamente altre risorse, come accadeva invece nel casoprecedente. Una volta determinato il fabbisogno relativo alla gestione corrente e non corrente, è possibiledeterminare il fabbisogno complessivo della gestione caratteristica. Il fabbisogno finanziario cumulato èinfatti costituito dall’investimento complessivo sia in elementi del capitale circolante che inimmobilizzazioni, sostenuto dall’impresa per svolgere la propria attività 6 .Riepilogando quanto detto in precedenza, la formula f × t rappresenta un importante strumentoconcettuale a disposizione della funzione finanziaria per determinare il fabbisogno finanziario di un’azienda.Tale formula assume una particolare efficacia se impiegata in un’ottica di gestione strategica. Ladeterminazione del fabbisogno finanziario non ha una grande utilità se esso viene determinato ex-post,ovvero sia sulla base dei risultati passati per capire quanto capitale è stato necessario per realizzare i cicliproduttivi degli esercizi passati. Ciò non significa che il valore del fabbisogno non serva a niente se calcolatosu bilanci consuntivi, anche perché esso consente in ogni caso fornisce delle informazioni utili relativesoprattutto all’evoluzione temporale del fabbisogno. Certo è che l’impiego di tale strumento raggiunge la suamassima efficacia da un punto di vista strategico quando viene utilizzato per stimare gli effetti finanziaridelle scelte di gestione industriale programmate per il futuro. In altri termini, la relazione vista diventaimportante da un punto di vista strategico al momento in cui viene utilizzata per rispondere a domande deltipo: qual è il fabbisogno richiesto da un certo piano di investimento? Per raggiungere un certo obiettivo dicrescita del fatturato, quale fabbisogno occorre preventivare?E’ possibile in qualche modo ridurre il valoredel fabbisogno previsto?In un’ottica strategica, la relazione:F = f × t2) dall’altro la quota complessiva di ammortamento accantonata di 10 milioni comporta un aumento del fondo di 10milioni.6 Nell’analisi che abbiamo finora condotto abbiamo volutamente semplificato la realtà aziendale per comprendere ilmeccanismo di calcolo del fabbisogno finanziario. Analogamente a quanto abbiamo già fatto studiando la dinamica deiflussi finanziari, possiamo adesso tentare di rendere le considerazioni del presente paragrafo più vicine alla realtàquotidiana delle imprese rimuovendo alcune delle ipotesi implicitamente adottate.Si considerino ad esempio gli effetti provocati sul fabbisogno dalle imposte sia indirette che dirette. Per quanto riguardale prime, esse dilatano i crediti ed i debiti commerciali generando di riflesso un gonfiamento dei flussi finanziari inentrata ed in uscita; si soffermi l’attenzione sull’IVA. Normalmente le imprese industriali presentano un saldo debitored’IVA, in quanto se il valore aggiunto è positivo il valore degli acquisti è inferiore a quello delle vendite per cui, aparità di aliquota, l’IVA riscossa dai clienti è superiore a quella pagata ai fornitori. In alcuni casi comunque si possonopresentare anche saldi creditori; ciò può avvenire ad esempio quando l’aliquota da applicare alle vendite è più bassadell’aliquota corrisposta sugli acquisti, oppure quando si realizzano investimenti di notevole entità,..Il sorgere di un saldo creditore d’IVA significa che l’impresa ha pagato più IVA di quanta non ne abbia incassata equindi vanta un credito nei confronti dell’Erario (si ricorda che l’IVA non costiuisce né un costo né un ricavo per leimprese, si tratta di un tributo che grava sui consumatori finali e che viene riscosso tramite le aziende che operano comesostituti d’imposta). Si tratta quindi di un flusso in uscita di risorse fino al momento in cui il credito non viene saldatoche richiede l’accensione di nuovi finanziamenti con la conseguente introduzione di altri oneri finanziari a detrimentodell’utile conseguito.Una circostanza analoga è destinata a ripetersi nel caso di saldi debitori se le condizioni di pagamento concesse all’attodella vendita costringono a versare all’erario l’IVA a debito prima di averla incassata dai clienti. Si tratta di unasituazione abbastanza diffusa se si tiene conto che il debito d’IVA gode di una dilazione media di pagamento di ventigiorni circa. Se l’impresa concede crediti superiori a tale periodo la quota a debito non compensata da fatture di acquistigenera un <strong>nuovo</strong> fabbisogno di risorse.Per quanto riguarda le imposte dirette (esempio ILOR e IRPEG) esse richiedono un pagamento che gode di unadilazione assai più considerevole rispetto al regime IVA. Tuttavia anch’esso può generare considerevoli fabbisogni incapo alla società poiché, come abbiamo già sottolineato, il ciclo economico -costi, ricavi- generalmente non corrispondeal ciclo monetario -entrate, uscite-. Di conseguenza può accadere che l’impresa può trovarsi costretta a versare leimposte prima di aver monetizzato l’utile lordo. Cfr. Bini.190