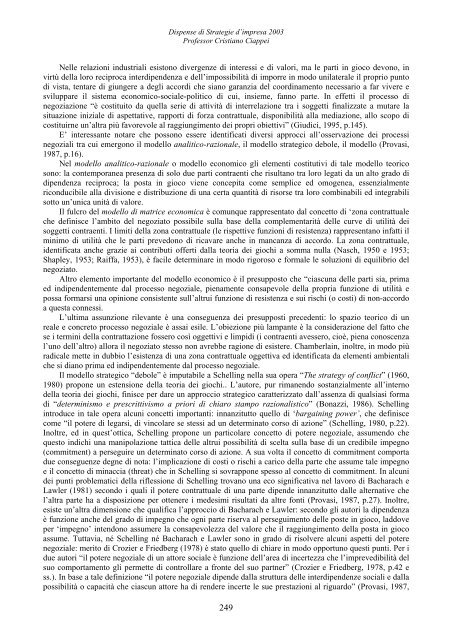DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
DISPENSE DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II (nuovo ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dispense di Strategie d’impresa 2003Professor Cristiano CiappeiNelle relazioni industriali esistono divergenze di interessi e di valori, ma le parti in gioco devono, invirtù della loro reciproca interdipendenza e dell’impossibilità di imporre in modo unilaterale il proprio puntodi vista, tentare di giungere a degli accordi che siano garanzia del coordinamento necessario a far vivere esviluppare il sistema economico-sociale-politico di cui, insieme, fanno parte. In effetti il processo dinegoziazione “è costituito da quella serie di attività di interrelazione tra i soggetti finalizzate a mutare lasituazione iniziale di aspettative, rapporti di forza contrattuale, disponibilità alla mediazione, allo scopo dicostituirne un’altra più favorevole al raggiungimento dei propri obiettivi” (Giudici, 1995, p.145).E’ interessante notare che possono essere identificati diversi approcci all’osservazione dei processinegoziali tra cui emergono il modello analitico-razionale, il modello strategico debole, il modello (Provasi,1987, p.16).Nel modello analitico-razionale o modello economico gli elementi costitutivi di tale modello teoricosono: la contemporanea presenza di solo due parti contraenti che risultano tra loro legati da un alto grado didipendenza reciproca; la posta in gioco viene concepita come semplice ed omogenea, essenzialmentericonducibile alla divisione e distribuzione di una certa quantità di risorse tra loro combinabili ed integrabilisotto un’unica unità di valore.Il fulcro del modello di matrice economica è comunque rappresentato dal concetto di ‘zona contrattualeche definisce l’ambito del negoziato possibile sulla base della complementarità delle curve di utilità deisoggetti contraenti. I limiti della zona contrattuale (le rispettive funzioni di resistenza) rappresentano infatti ilminimo di utilità che le parti prevedono di ricavare anche in mancanza di accordo. La zona contrattuale,identificata anche grazie ai contributi offerti dalla teoria dei giochi a somma nulla (Nasch, 1950 e 1953;Shapley, 1953; Raiffa, 1953), è facile determinare in modo rigoroso e formale le soluzioni di equilibrio delnegoziato.Altro elemento importante del modello economico è il presupposto che “ciascuna delle parti sia, primaed indipendentemente dal processo negoziale, pienamente consapevole della propria funzione di utilità epossa formarsi una opinione consistente sull’altrui funzione di resistenza e sui rischi (o costi) di non-accordoa questa connessi.L’ultima assunzione rilevante è una conseguenza dei presupposti precedenti: lo spazio teorico di unreale e concreto processo negoziale è assai esile. L’obiezione più lampante è la considerazione del fatto chese i termini della contrattazione fossero così oggettivi e limpidi (i contraenti avessero, cioè, piena conoscenzal’uno dell’altro) allora il negoziato stesso non avrebbe ragione di esistere. Chamberlain, inoltre, in modo piùradicale mette in dubbio l’esistenza di una zona contrattuale oggettiva ed identificata da elementi ambientaliche si diano prima ed indipendentemente dal processo negoziale.Il modello strategico “debole” è imputabile a Schelling nella sua opera “The strategy of conflict” (1960,1980) propone un estensione della teoria dei giochi.. L’autore, pur rimanendo sostanzialmente all’internodella teoria dei giochi, finisce per dare un approccio strategico caratterizzato dall’assenza di qualsiasi formadi “determinismo e prescrittivismo a priori di chiaro stampo razionalistico” (Bonazzi, 1986). Schellingintroduce in tale opera alcuni concetti importanti: innanzitutto quello di ‘bargaining power’, che definiscecome “il potere di legarsi, di vincolare se stessi ad un determinato corso di azione” (Schelling, 1980, p.22).Inoltre, ed in quest’ottica, Schelling propone un particolare concetto di potere negoziale, assumendo chequesto indichi una manipolazione tattica delle altrui possibilità di scelta sulla base di un credibile impegno(commitment) a perseguire un determinato corso di azione. A sua volta il concetto di commitment comportadue conseguenze degne di nota: l’implicazione di costi o rischi a carico della parte che assume tale impegnoe il concetto di minaccia (threat) che in Schelling si sovrappone spesso al concetto di commitment. In alcunidei punti problematici della riflessione di Schelling trovano una eco significativa nel lavoro di Bacharach eLawler (1981) secondo i quali il potere contrattuale di una parte dipende innanzitutto dalle alternative chel’altra parte ha a disposizione per ottenere i medesimi risultati da altre fonti (Provasi, 1987, p.27). Inoltre,esiste un’altra dimensione che qualifica l’approccio di Bacharach e Lawler: secondo gli autori la dipendenzaè funzione anche del grado di impegno che ogni parte riserva al perseguimento delle poste in gioco, laddoveper ‘impegno’ intendono assumere la consapevolezza del valore che il raggiungimento della posta in giocoassume. Tuttavia, né Schelling né Bacharach e Lawler sono in grado di risolvere alcuni aspetti del poterenegoziale: merito di Crozier e Friedberg (1978) è stato quello di chiare in modo opportuno questi punti. Per idue autori “il potere negoziale di un attore sociale è funzione dell’area di incertezza che l’imprevedibilità delsuo comportamento gli permette di controllare a fronte del suo partner” (Crozier e Friedberg, 1978, p.42 ess.). In base a tale definizione “il potere negoziale dipende dalla struttura delle interdipendenze sociali e dallapossibilità o capacità che ciascun attore ha di rendere incerte le sue prestazioni al riguardo” (Provasi, 1987,249