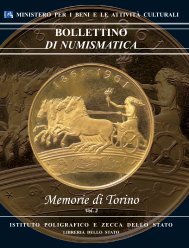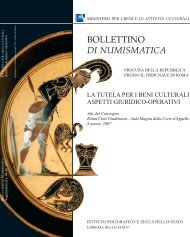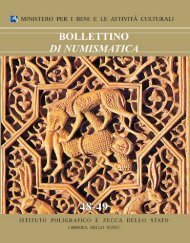Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Francesco Panvini Rosati<br />
Il tipo del ritratto sulla moneta viene ripreso per un breve periodo da Carlo I d’Angiò sui re<strong>al</strong>i della<br />
zecca <strong>di</strong> Barletta coniati tra il 1266 e il 1278. Il busto ci appare con una corona <strong>di</strong> gigli; i capelli non<br />
sono trattati come sull’august<strong>al</strong>e ma seguono l’acconciatura dell’epoca qu<strong>al</strong>e la troviamo nella statua del<br />
p<strong>al</strong>azzo dei Conservatori a Roma; la veste segue invece, sebbene con minor eleganza, il modello<br />
dell’august<strong>al</strong>e. Anche sul re<strong>al</strong>e <strong>di</strong> Barletta però mancano <strong>al</strong>l’effigie riprodotta quei tratti in<strong>di</strong>vidu<strong>al</strong>i che<br />
caratterizzano il ritratto.<br />
Ancora più lontani da ogni somiglianza fisionomica i busti mitrati dei Vescovi sui denari <strong>di</strong> Trento<br />
e <strong>di</strong> Aquileia, più simbolo del vescovo che ritratto in<strong>di</strong>vidu<strong>al</strong>e, e le rozze effigi <strong>di</strong> papi che appaiono<br />
sugli antiquiores <strong>di</strong> Adriano I (772-795) e su denari posteriori delle zecche <strong>di</strong> Bologna, <strong>di</strong> Roma o <strong>di</strong><br />
Ponte della Sorga durante il XIV secolo.<br />
I precursori dei ritratti monet<strong>al</strong>i mi sembra che occorra cercarli non tanto nelle monete quanto piuttosto<br />
sulle prime medaglie: su quelle dei De Carrara con i ritratti <strong>di</strong> Francesco I e Francesco <strong>II</strong> Novello<br />
della fine del XIV secolo, che precorrono l’inizio della grande arte medaglistica, e soprattutto sulle<br />
prime medaglie del Pisanello, iniziate nel 1438 con la medaglia per Giovanni V<strong>II</strong>I P<strong>al</strong>eologo.<br />
Solo sulla medaglia, emissione non uffici<strong>al</strong>e e <strong>di</strong> carattere commemorativo, nella qu<strong>al</strong>e il maggior<br />
modulo e la possibilità tecnica <strong>di</strong> <strong>al</strong>to rilievo offrivano <strong>al</strong>l’artista una maggior libertà <strong>di</strong> rappresentazione,<br />
poteva sorgere il ritratto, espressione <strong>di</strong> una nuova concezione della vita e <strong>di</strong> un nuovo costume.<br />
L’esempio <strong>di</strong> Francesco Sforza fu presto seguito da quasi tutti i Signori it<strong>al</strong>iani, primo tra tutti<br />
Borso d’Este a Ferrara che, dopo un breve periodo con monete <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zion<strong>al</strong>e, conia un raro ducato<br />
con ritratto. Seguono a breve <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tempo Fer<strong>di</strong>nando I d’Aragona a Napoli (1458-1494) e Ludovico<br />
<strong>II</strong> Gonzaga (1444-1478) a Mantova, <strong>di</strong> cui conosciamo un ducato con la sua effigie della più <strong>al</strong>ta<br />
rarità, appartenente <strong>al</strong>l’ultimo periodo del suo regno (ca. 1460-1478). Si iniziano così le serie delle<br />
monete d’oro e d’argento con ritratto degli Estensi nelle loro zecche <strong>di</strong> Ferrara, Modena e Reggio, dei<br />
Gonzaga a Mantova, degli Aragonesi a Napoli. Più tar<strong>di</strong>, nell’ultimo quarto <strong>di</strong> secolo, abbiamo monete<br />
con ritratto <strong>di</strong> Ludovico <strong>II</strong> <strong>di</strong> S<strong>al</strong>uzzo a Carmagnola, <strong>di</strong> Ludovico d’Orleans ad Asti negli ultimi anni <strong>di</strong><br />
governo, <strong>di</strong> Giovanni <strong>II</strong> Bentivoglio probabilmente a Bologna, <strong>di</strong> Guglielmo <strong>II</strong> P<strong>al</strong>eologo a Cas<strong>al</strong>e, <strong>di</strong><br />
Guidob<strong>al</strong>do I da Montefeltro a Urbino. Sul finire del secolo batte moneta con la sua effigie Gian Francesco<br />
Pico signore <strong>di</strong> Mirandola. Con Sisto IV (1471-1484) sui doppi grossi e sui grossi appare il primo<br />
ritratto <strong>di</strong> un papa sulle monete e l’unico nel secolo XV, eccetto un rarissimo pezzo da tre ducati <strong>di</strong> Alessandro<br />
VI, del IV anno <strong>di</strong> pontificato che reca l’effigie pap<strong>al</strong>e. Con Carlo I (1482-1490) ha inizio la<br />
serie dei ritratti sulle monete dei Savoia. Nei primi decenni del secolo successivo cominciano le ultime<br />
serie, quelle della zecca <strong>di</strong> Desana con Ludovico <strong>II</strong> Tizzone (1510-1525), <strong>di</strong> Messerano con Ludovico <strong>II</strong><br />
Fieschi (15281532), <strong>di</strong> Camerino con Giovanni Maria da Varano (1511-1527).<br />
Da questo quadro, in cui si è esposta rapidamente la successione della monetazione it<strong>al</strong>iana con<br />
ritratto, risulta che quasi tutti gli stati it<strong>al</strong>iani gran<strong>di</strong> e piccoli, tra la fine del XV secolo e gli inizi del<br />
XVI, coniavano moneta con l’effigie del signore: uniche eccezioni gli Stati economicamente più importanti,<br />
Genova, Venezia, Firenze.<br />
Si può <strong>di</strong>re che le monetazioni che avevano il maggior peso nell’economia it<strong>al</strong>iana del XV secolo e<br />
che più erano <strong>di</strong>ffuse in tutta Europa, rimangono estranee <strong>al</strong>le correnti innovatrici della moneta it<strong>al</strong>iana:<br />
la stessa Firenze, che è pur centro del rinascimento artistico in It<strong>al</strong>ia, non muta i suoi tipi monet<strong>al</strong>i che<br />
non subiscono <strong>al</strong>terazioni <strong>di</strong> sorta. Non mi sembra però che le ragioni <strong>di</strong> questo conservatorismo debba<br />
164<br />
http://www.numismaticadellostato.it