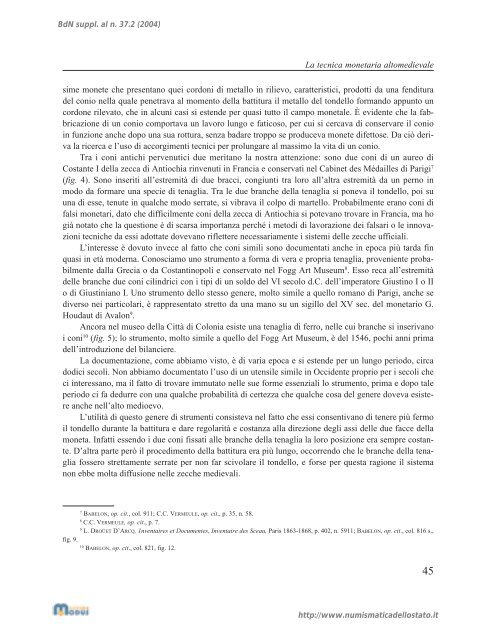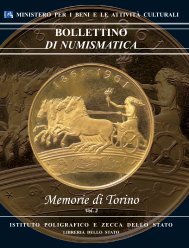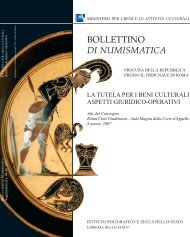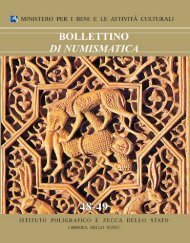Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
La tecnica monetaria <strong>al</strong>tome<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>e<br />
sime monete che presentano quei cordoni <strong>di</strong> met<strong>al</strong>lo in rilievo, caratteristici, prodotti da una fen<strong>di</strong>tura<br />
del conio nella qu<strong>al</strong>e penetrava <strong>al</strong> momento della battitura il met<strong>al</strong>lo del tondello formando appunto un<br />
cordone rilevato, che in <strong>al</strong>cuni casi si estende per quasi tutto il campo monet<strong>al</strong>e. È evidente che la fabbricazione<br />
<strong>di</strong> un conio comportava un lavoro lungo e faticoso, per cui si cercava <strong>di</strong> conservare il conio<br />
in funzione anche dopo una sua rottura, senza badare troppo se produceva monete <strong>di</strong>fettose. Da ciò deriva<br />
la ricerca e l’uso <strong>di</strong> accorgimenti tecnici per prolungare <strong>al</strong> massimo la vita <strong>di</strong> un conio.<br />
Tra i coni antichi pervenutici due meritano la nostra attenzione: sono due coni <strong>di</strong> un aureo <strong>di</strong><br />
Costante I della zecca <strong>di</strong> Antiochia rinvenuti in Francia e conservati nel Cabinet des Médailles <strong>di</strong> Parigi 7<br />
(fig. 4). Sono inseriti <strong>al</strong>l’estremità <strong>di</strong> due bracci, congiunti tra loro <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tra estremità da un perno in<br />
modo da formare una specie <strong>di</strong> tenaglia. Tra le due branche della tenaglia si poneva il tondello, poi su<br />
una <strong>di</strong> esse, tenute in qu<strong>al</strong>che modo serrate, si vibrava il colpo <strong>di</strong> martello. Probabilmente erano coni <strong>di</strong><br />
f<strong>al</strong>si monetari, dato che <strong>di</strong>fficilmente coni della zecca <strong>di</strong> Antiochia si potevano trovare in Francia, ma ho<br />
già notato che la questione è <strong>di</strong> scarsa importanza perché i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> lavorazione dei f<strong>al</strong>sari o le innovazioni<br />
tecniche da essi adottate dovevano riflettere necessariamente i sistemi delle zecche uffici<strong>al</strong>i.<br />
L’interesse è dovuto invece <strong>al</strong> fatto che coni simili sono documentati anche in epoca più tarda fin<br />
quasi in età moderna. Conosciamo uno strumento a forma <strong>di</strong> vera e propria tenaglia, proveniente probabilmente<br />
d<strong>al</strong>la Grecia o da Costantinopoli e conservato nel Fogg Art Museum 8 . Esso reca <strong>al</strong>l’estremità<br />
delle branche due coni cilindrici con i tipi <strong>di</strong> un soldo del VI secolo d.C. dell’imperatore Giustino I o <strong>II</strong><br />
o <strong>di</strong> Giustiniano I. Uno strumento dello stesso genere, molto simile a quello romano <strong>di</strong> Parigi, anche se<br />
<strong>di</strong>verso nei particolari, è rappresentato stretto da una mano su un sigillo del XV sec. del monetario G.<br />
Houdaut <strong>di</strong> Av<strong>al</strong>on 9 .<br />
Ancora nel museo della Città <strong>di</strong> Colonia esiste una tenaglia <strong>di</strong> ferro, nelle cui branche si inserivano<br />
i coni 10 (fig. 5); lo strumento, molto simile a quello del Fogg Art Museum, è del 1546, pochi anni prima<br />
dell’introduzione del bilanciere.<br />
La documentazione, come abbiamo visto, è <strong>di</strong> varia epoca e si estende per un lungo periodo, circa<br />
do<strong>di</strong>ci secoli. Non abbiamo documentato l’uso <strong>di</strong> un utensile simile in Occidente proprio per i secoli che<br />
ci interessano, ma il fatto <strong>di</strong> trovare immutato nelle sue forme essenzi<strong>al</strong>i lo strumento, prima e dopo t<strong>al</strong>e<br />
periodo ci fa dedurre con una qu<strong>al</strong>che probabilità <strong>di</strong> certezza che qu<strong>al</strong>che cosa del genere doveva esistere<br />
anche nell’<strong>al</strong>to me<strong>di</strong>oevo.<br />
L’utilità <strong>di</strong> questo genere <strong>di</strong> strumenti consisteva nel fatto che essi consentivano <strong>di</strong> tenere più fermo<br />
il tondello durante la battitura e dare regolarità e costanza <strong>al</strong>la <strong>di</strong>rezione degli assi delle due facce della<br />
moneta. Infatti essendo i due coni fissati <strong>al</strong>le branche della tenaglia la loro posizione era sempre costante.<br />
D’<strong>al</strong>tra parte però il proce<strong>di</strong>mento della battitura era più lungo, occorrendo che le branche della tenaglia<br />
fossero strettamente serrate per non far sci<strong>vol</strong>are il tondello, e forse per questa ragione il sistema<br />
non ebbe molta <strong>di</strong>ffusione nelle zecche me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>i.<br />
7<br />
BABELON, op. cit., col. 911; C.C. VERMEULE, op. cit., p. 35, n. 58.<br />
8<br />
C.C. VERMEULE, op. cit., p. 7.<br />
9<br />
L. DROÜET D’ARCQ, 1nventaires et Documentes, Inventaire des Sceau, Paris 1863-1868, p. 402, n. 5911; BABELON, op. cit., col. 816 s.,<br />
fig. 9.<br />
10<br />
BABELON, op. cit., col. 821, fig. 12.<br />
45<br />
http://www.numismaticadellostato.it