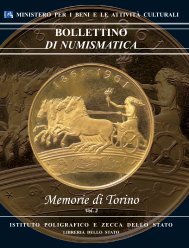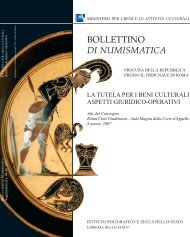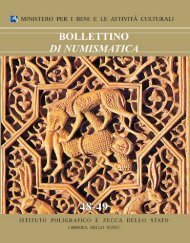Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Francesco Panvini Rosati<br />
D<strong>al</strong>la metà del secolo X<strong>II</strong>I, invece, le città che iniziano a coniare pongono gener<strong>al</strong>mente sulla<br />
moneta solo il loro nome e quello del Santo protettore. Anche <strong>al</strong>cuni comuni che coniavano già in epoca<br />
precedente, dopo il 1250 tolgono il nome dell’imperatore d<strong>al</strong>le loro monete: così Brescia e Parma e, più<br />
tar<strong>di</strong>, Alessandria, Lucca, Cremona 10 .<br />
Pertanto la monetazione comun<strong>al</strong>e si può <strong>di</strong>videre in due perio<strong>di</strong>: uno anteriore <strong>al</strong>la metà del X<strong>II</strong>I secolo<br />
e uno posteriore, in cui anche form<strong>al</strong>mente i comuni hanno raggiunto la piena autonomia monetaria. Non<br />
vi è dubbio infatti che la presenza del nome dell’imperatore sulle monete in<strong>di</strong>cava, a prescindere d<strong>al</strong>la situazione<br />
<strong>di</strong> fatto, un riconoscimento sia pure form<strong>al</strong>e dell’autorità imperi<strong>al</strong>e da parte della città che coniava.<br />
D<strong>al</strong> punto <strong>di</strong> vista tipologico questa autonomia si manifesta anche con l’introduzione del nuovo<br />
tipo del Santo protettore della città, stante o seduto, mitrato con il pastor<strong>al</strong>e e bene<strong>di</strong>cente.<br />
I precedenti della raffigurazione del Santo protettore possiamo trovarli sulle monete <strong>di</strong> <strong>al</strong>cune città della<br />
Lombar<strong>di</strong>a e del Piemonte tra la fine dell’XI secolo e la metà del X<strong>II</strong>: sulle monete <strong>di</strong> Novara, Alessandria,<br />
Lo<strong>di</strong> ve<strong>di</strong>amo nel campo o nella leggenda circolare le lettere SCSG o SP o SCSB, abbreviazioni rispettivamente<br />
<strong>di</strong> Sanctus Gaudentius per Novara, Sanctus Petrus per Alessandria, Sanctus Bassianus per Lo<strong>di</strong>.<br />
Nella nuova fase della monetazione la figura del Santo <strong>di</strong>venta comune, soprattutto sul grosso: così<br />
troviamo S. Siro a Pavia, SS. Protasio e Gervasio e S. Ambrogio a Milano, S. Imerio seduto a Cremona,<br />
S. Faustino e S. Giovita a Brescia, S. Gaudenzio a Rimini, S. Giusto a Volterra, S. Ciriaco ad Ancona, S.<br />
Emi<strong>di</strong>o ad Ascoli, S. Ansuino a Camerino, e inoltre i busti <strong>di</strong> S. Donato ad Arezzo e <strong>di</strong> S. Ercolano a<br />
Perugia, S. Pietro con le chiavi e il vescovo mitrato con pastor<strong>al</strong>e a Mantova.<br />
T<strong>al</strong>e abbondanza <strong>di</strong> tipi figurati si contrappone <strong>al</strong>l’uniformità dei tipi epigrafici e delle croci, caratteristica<br />
della monetazione del primo periodo, uniformità appena interrotta da poche eccezioni, qu<strong>al</strong>i il<br />
castello a Genova e a Parma, l’e<strong>di</strong>ficio a cupola tra le due torri a Bergamo, il busto imperi<strong>al</strong>e a Bergamo<br />
e a Como (ma Bergamo inizia solo nel 1236 le sue emissioni), il giglio fiorito a Reggio Emilia, l’aquila<br />
imperi<strong>al</strong>e sugli aquilini <strong>di</strong> Ivrea e <strong>di</strong> Vicenza. Tuttavia anche queste eccezioni rappresentano una novità<br />
della monetazione comun<strong>al</strong>e rispetto <strong>al</strong>la fissità tipologica che si riscontra durante il periodo precedente<br />
nella produzione delle zecche imperi<strong>al</strong>i legate <strong>al</strong> tipo semplicemente epigrafico o a quello della christiana<br />
religio. In particolare sono da notare l’e<strong>di</strong>ficio a cupola con due torri sulle monete <strong>di</strong> Bergamo, che si<br />
ripete con numerose varianti <strong>di</strong> conio, il castello sulle monete <strong>di</strong> Genova e in speci<strong>al</strong> modo i due busti<br />
rappresentati sul dritto dei denari <strong>di</strong> Bergamo sopra ricordati e sui grossi <strong>di</strong> Como: il primo un busto<br />
drappeggiato e laureato, e il secondo un busto drappeggiato e coronato, con scettro gigliato sulla sp<strong>al</strong>la e<br />
un fiore o un globo nella mano. Entrambi vogliono riprodurre l’effigie <strong>di</strong> Federico <strong>II</strong>, anche se sono ben<br />
lontani d<strong>al</strong> rappresentare un ritratto vero e proprio con le sue caratteristiche fisionomiche.<br />
Sono questi, insieme <strong>al</strong>l’august<strong>al</strong>e (1231), <strong>di</strong> cui il busto sui denari <strong>di</strong> Bergamo costituisce un’imitazione<br />
più fiacca, i primi tentativi <strong>di</strong> ritratto sulla moneta it<strong>al</strong>iana, che si susseguono nel giro <strong>di</strong> pochi<br />
decenni, seguiti a breve <strong>di</strong>stanza d<strong>al</strong>l’effigie <strong>di</strong> Carlo I d’Angiò sui re<strong>al</strong>i d’oro della zecca <strong>di</strong> Barletta<br />
coniati tra il 1266 e il 1278.<br />
10<br />
Fanno eccezione a questa regola Pavia che, anche dopo il 1250, conia moneta con S. Siro <strong>al</strong> rovescio e la leggenda IMPERATOR sul<br />
dritto, Ivrea e Vercelli che pongono entrambe il nome <strong>di</strong> Federico sul dritto delle loro monete. Per Pavia si può supporre che abbia influito sulla<br />
sua monetazione autonoma la lunga tra<strong>di</strong>zione delle emissioni battute a nome dell’imperatore. Per Ivrea e Vercelli, invece, è più <strong>di</strong>fficile trovare<br />
una spiegazione: nel caso particolare <strong>di</strong> Ivrea, ha forse influito sulla leggenda il tipo della moneta, che è quello così detto del tirolino con<br />
l’aquila imperi<strong>al</strong>e sul dritto, tipo caratteristico delle città che avevano stretti rapporti con l’imperatore.<br />
68<br />
http://www.numismaticadellostato.it