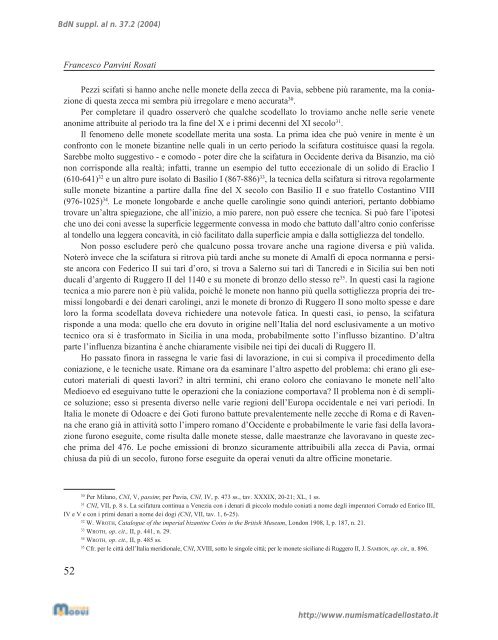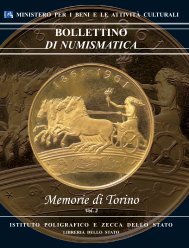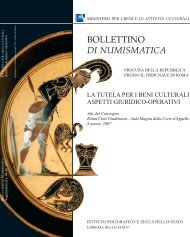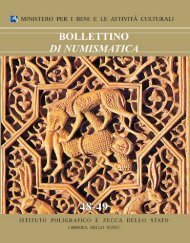Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Francesco Panvini Rosati<br />
Pezzi scifati si hanno anche nelle monete della zecca <strong>di</strong> Pavia, sebbene più raramente, ma la coniazione<br />
<strong>di</strong> questa zecca mi sembra più irregolare e meno accurata 30 .<br />
Per completare il quadro osserverò che qu<strong>al</strong>che scodellato lo troviamo anche nelle serie venete<br />
anonime attribuite <strong>al</strong> periodo tra la fine del X e i primi decenni del XI secolo 31 .<br />
Il fenomeno delle monete scodellate merita una sosta. La prima idea che può venire in mente è un<br />
confronto con le monete bizantine nelle qu<strong>al</strong>i in un certo periodo la scifatura costituisce quasi la regola.<br />
Sarebbe molto suggestivo - e comodo - poter <strong>di</strong>re che la scifatura in Occidente deriva da Bisanzio, ma ciò<br />
non corrisponde <strong>al</strong>la re<strong>al</strong>tà; infatti, tranne un esempio del tutto eccezion<strong>al</strong>e <strong>di</strong> un solido <strong>di</strong> Eraclio I<br />
(610-641) 32 e un <strong>al</strong>tro pure isolato <strong>di</strong> Basilio I (867-886) 33 , la tecnica della scifatura si ritrova regolarmente<br />
sulle monete bizantine a partire d<strong>al</strong>la fine del X secolo con Basilio <strong>II</strong> e suo fratello Costantino V<strong>II</strong>I<br />
(976-1025) 34 . Le monete longobarde e anche quelle carolingie sono quin<strong>di</strong> anteriori, pertanto dobbiamo<br />
trovare un’<strong>al</strong>tra spiegazione, che <strong>al</strong>l’inizio, a mio parere, non può essere che tecnica. Si può fare l’ipotesi<br />
che uno dei coni avesse la superficie leggermente convessa in modo che battuto d<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tro conio conferisse<br />
<strong>al</strong> tondello una leggera concavità, in ciò facilitato d<strong>al</strong>la superficie ampia e d<strong>al</strong>la sottigliezza del tondello.<br />
Non posso escludere però che qu<strong>al</strong>cuno possa trovare anche una ragione <strong>di</strong>versa e più v<strong>al</strong>ida.<br />
Noterò invece che la scifatura si ritrova più tar<strong>di</strong> anche su monete <strong>di</strong> Am<strong>al</strong>fi <strong>di</strong> epoca normanna e persiste<br />
ancora con Federico <strong>II</strong> sui tarì d’oro, si trova a S<strong>al</strong>erno sui tarì <strong>di</strong> Tancre<strong>di</strong> e in Sicilia sui ben noti<br />
duc<strong>al</strong>i d’argento <strong>di</strong> Ruggero <strong>II</strong> del 1140 e su monete <strong>di</strong> bronzo dello stesso re 35 . In questi casi la ragione<br />
tecnica a mio parere non è più v<strong>al</strong>ida, poiché le monete non hanno più quella sottigliezza propria dei tremissi<br />
longobar<strong>di</strong> e dei denari carolingi, anzi le monete <strong>di</strong> bronzo <strong>di</strong> Ruggero <strong>II</strong> sono molto spesse e dare<br />
loro la forma scodellata doveva richiedere una note<strong>vol</strong>e fatica. In questi casi, io penso, la scifatura<br />
risponde a una moda: quello che era dovuto in origine nell’It<strong>al</strong>ia del nord esclusivamente a un motivo<br />
tecnico ora si è trasformato in Sicilia in una moda, probabilmente sotto l’influsso bizantino. D’<strong>al</strong>tra<br />
parte l’influenza bizantina è anche chiaramente visibile nei tipi dei duc<strong>al</strong>i <strong>di</strong> Ruggero <strong>II</strong>.<br />
Ho passato finora in rassegna le varie fasi <strong>di</strong> lavorazione, in cui si compiva il proce<strong>di</strong>mento della<br />
coniazione, e le tecniche usate. Rimane ora da esaminare l’<strong>al</strong>tro aspetto del problema: chi erano gli esecutori<br />
materi<strong>al</strong>i <strong>di</strong> questi lavori in <strong>al</strong>tri termini, chi erano coloro che coniavano le monete nell’<strong>al</strong>to<br />
Me<strong>di</strong>oevo ed eseguivano tutte le operazioni che la coniazione comportava Il problema non è <strong>di</strong> semplice<br />
soluzione; esso si presenta <strong>di</strong>verso nelle varie regioni dell’Europa occident<strong>al</strong>e e nei vari perio<strong>di</strong>. In<br />
It<strong>al</strong>ia le monete <strong>di</strong> Odoacre e dei Goti furono battute prev<strong>al</strong>entemente nelle zecche <strong>di</strong> Roma e <strong>di</strong> Ravenna<br />
che erano già in attività sotto l’impero romano d’Occidente e probabilmente le varie fasi della lavorazione<br />
furono eseguite, come risulta d<strong>al</strong>le monete stesse, d<strong>al</strong>le maestranze che lavoravano in queste zecche<br />
prima del 476. Le poche emissioni <strong>di</strong> bronzo sicuramente attribuibili <strong>al</strong>la zecca <strong>di</strong> Pavia, ormai<br />
chiusa da più <strong>di</strong> un secolo, furono forse eseguite da operai venuti da <strong>al</strong>tre officine monetarie.<br />
30<br />
Per Milano, CNI, V, passim; per Pavia, CNI, IV, p. 473 ss., tav. XXXIX, 20-21; XL, 1 ss.<br />
31<br />
CNI, V<strong>II</strong>, p. 8 s. La scifatura continua a Venezia con i denari <strong>di</strong> piccolo modulo coniati a nome degli imperatori Corrado ed Enrico <strong>II</strong>I,<br />
IV e V e con i primi denari a nome dei dogi (CNI, V<strong>II</strong>, tav. 1, 6-25).<br />
32<br />
W. WROTH, Cat<strong>al</strong>ogue of the imperi<strong>al</strong> bizantine Coins in the British Museum, London 1908, I, p. 187, n. 21.<br />
33<br />
WROTH, op. cit., <strong>II</strong>, p. 441, n. 29.<br />
34<br />
WROTH, op. cit., <strong>II</strong>, p. 485 ss.<br />
35<br />
Cfr. per le città dell’It<strong>al</strong>ia meri<strong>di</strong>on<strong>al</strong>e, CNI, XV<strong>II</strong>I, sotto le singole città; per le monete siciliane <strong>di</strong> Ruggero <strong>II</strong>, J. SAMBON, op. cit., n. 896.<br />
52<br />
http://www.numismaticadellostato.it