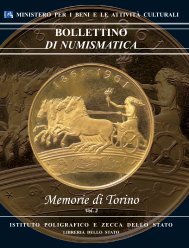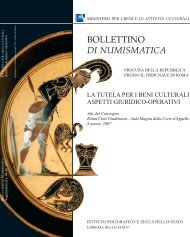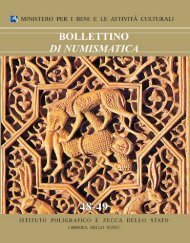Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Francesco Panvini Rosati<br />
riprese da monete imperi<strong>al</strong>i romane; il tempio è copiato esattamente dai sesterzi <strong>di</strong> Nerone con la leggenda<br />
pace terra marique parta ianum clusit (fig. 22) 26 , dai qu<strong>al</strong>i deriva anche la leggenda della medaglia.<br />
Non deve sorprendere questa familiarità degli artisti con le monete romane. La conoscenza delle<br />
monete antiche non era venuta mai meno completamente durante il Me<strong>di</strong>oevo: lo provano, fra l’<strong>al</strong>tro, le<br />
numerose imitazioni <strong>di</strong> tipi monet<strong>al</strong>i romani sulle monete me<strong>di</strong>oev<strong>al</strong>i in It<strong>al</strong>ia e fuori d’It<strong>al</strong>ia 27 . Basta un<br />
esempio per tutti, il più noto: gli august<strong>al</strong>i <strong>di</strong> Federico <strong>II</strong>, coniati d<strong>al</strong> 1231 d<strong>al</strong>le zecche <strong>di</strong> Messina e<br />
Brin<strong>di</strong>si che raffigurano <strong>al</strong> dritto il ritratto dell’imperatore secondo il tipo dei ritratti sulle monete imperi<strong>al</strong>i<br />
tarde e <strong>al</strong> rovescio recano l’aquila imperi<strong>al</strong>e secondo lo schema dell’aquila sulle monete dell’età <strong>di</strong><br />
Traiano 28 . Ma non solo le monete romane erano conosciute ed imitate nei tipi monet<strong>al</strong>i, ma già nel ‘300<br />
esse vengono considerate come fonte per la conoscenza storica ed utilizzate come documento.<br />
A parte l’esempio <strong>di</strong> Giovanni de Matociis <strong>di</strong> Verona, che si limita a <strong>di</strong>segnare nel manoscritto<br />
della sua Historia Imperi<strong>al</strong>is i dritti delle monete dei vari imperatori cui i passi della sua narrazione storica<br />
si riferiscono, è ben noto quanta importanza attribuisse <strong>al</strong>le monete il Petrarca come mezzo <strong>di</strong> conoscenza<br />
per l’antichità. Non solo ma la moneta costituiva per lui oltre che una fonte storica anche mezzo<br />
<strong>di</strong> ammonimento mor<strong>al</strong>e tanto da donare nel 1354 <strong>al</strong>l’imperatore Carlo IV una piccola raccolta <strong>di</strong><br />
monete imperi<strong>al</strong>i per esortarlo a seguire l’esempio degli antichi imperatori.<br />
In questo risveglio <strong>di</strong> interesse per le monete antiche si formano le prime collezioni. Per citare gli<br />
esempi più significativi: la collezione Me<strong>di</strong>ci iniziata a Firenze da Cosimo il Vecchio, continuata d<strong>al</strong><br />
figlio Piero e poi da Lorenzo il Magnifico e la raccolta del card. Pietro Barbo, poi Paolo <strong>II</strong>, <strong>di</strong> cui è conservato<br />
anche l’inventario e che si può considerare la più grande raccolta <strong>di</strong> monete romane del 1400,<br />
con 97 monete d’oro e un migliaio <strong>di</strong> monete d’argento 29 .<br />
Da tutto quanto esposto cerchiamo <strong>di</strong> trarre qu<strong>al</strong>che conclusione.<br />
La prima osservazione che si presenta con carattere <strong>di</strong> evidenza è che i massimi esponenti della<br />
medaglia nel ‘400 qu<strong>al</strong>i Pisanello e Matteo dei Pasti non si ispirino nelle raffigurazioni delle loro medaglie<br />
ai modelli antichi. Se a un primo esame delle loro opere si avverte una qu<strong>al</strong>che affinità con modelli<br />
classici (come nella medaglia pisanelliana <strong>di</strong> Niccolò Piccinino) si tratta <strong>di</strong> fatti margin<strong>al</strong>i che non intaccano<br />
la sostanza dell’origin<strong>al</strong>ità dei tipi 30 .<br />
26<br />
Per la Pace che brucia le armi ve<strong>di</strong> il sesterzio <strong>di</strong> Vespasiano, H. MATTINGLY, op. cit., <strong>II</strong>, tav. 21,4; per il tempio <strong>di</strong> Giano i sesterzi <strong>di</strong><br />
Nerone, MATTINGLY, op. cit., I, tav. 41 ss.<br />
27<br />
Per la conoscenza delle monete romane nel Me<strong>di</strong>oevo e nel Rinascimento e in genere per il fiorire degli stu<strong>di</strong> numismatici dopo il<br />
Petrarca, ve<strong>di</strong> R. WEISS, The Renaissance <strong>di</strong>scovery of Classic<strong>al</strong> Antiquity, Oxford 1969, cap. X<strong>II</strong>, p. 167 ss.; IDEM, The Study of ancient Numismatics<br />
during tbe Renaissance (1313-1517), in NC 1968, p. 177 ss.; IDEM, nota <strong>al</strong>la ristampa della Illustrium Imagines <strong>di</strong> Andrea Fulvio, curata<br />
da Roberto Peliti, Roma 1967.<br />
28<br />
Ve<strong>di</strong> l’aureo <strong>al</strong> nome della Diva Marciana, H. MATTINGLY, op. cit., <strong>II</strong>I, tav. 21,2.<br />
29<br />
Sulle prime collezioni <strong>di</strong> monete e in particolare su quelle dei Me<strong>di</strong>ci e <strong>di</strong> Paolo <strong>II</strong>, oltre le opere <strong>di</strong> R. WEISS sopra citate, ve<strong>di</strong> E.<br />
MUNTZ, Les arts à la cour des Papes pendant le XV et le XVI siècle, <strong>II</strong>, in Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, 9, Paris<br />
1879, p. 141 ss., p. 265 ss.; IDEM, Les collections des Me<strong>di</strong>cis au XV siècle, Paris-London 1888; IDEM, Precursori e propugnatori del Rinascimento,<br />
Firenze 1902; R. WEISS, Un umanista veneziano, Paolo <strong>II</strong> Barbo, Venezia-Roma 1957, p. 27 ss. Un quadro riassuntivo degli stu<strong>di</strong> umanistici<br />
a Firenze è dato da F. PANVINI ROSATI, La numismatica a Firenze: collezioni, collezionisti e numismatici tra il Me<strong>di</strong>oevo e l’età<br />
moderna, in BN V<strong>II</strong>, n. 6, 1970, p. 4 ss.<br />
30<br />
Qu<strong>al</strong>che <strong>di</strong>segno pisanelliano riproduce effigi <strong>di</strong> imperatori romani sicuramente derivate da monete [M. FOSSI TODOROW, I <strong>di</strong>segni del<br />
Pisanello e della sua cerchia, Firenze 1966, tav. CXV, 223 r (Aureliano), CXV, 224 (forse Traiano Decio), CXXI, 279 r (Augusto)], ma la loro<br />
attribuzione a Pisanello è messa in dubbio dai critici. In ogni modo una accertata paternità pisanelliana <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>segni <strong>di</strong>mostrerebbe soltanto<br />
che l’artista conosceva le monete romane, il che è perfettamente natur<strong>al</strong>e.<br />
206<br />
http://www.numismaticadellostato.it