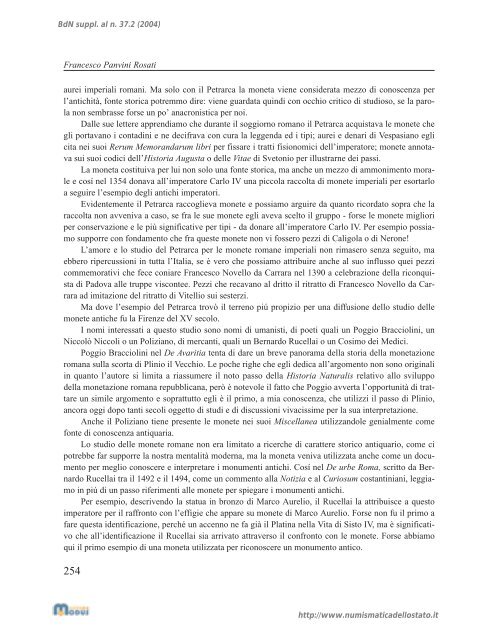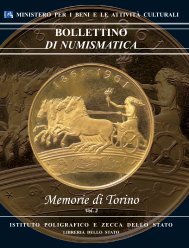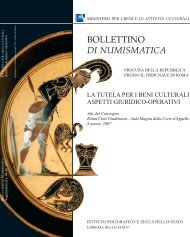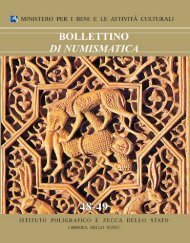Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Francesco Panvini Rosati<br />
aurei imperi<strong>al</strong>i romani. Ma solo con il Petrarca la moneta viene considerata mezzo <strong>di</strong> conoscenza per<br />
l’antichità, fonte storica potremmo <strong>di</strong>re: viene guardata quin<strong>di</strong> con occhio critico <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>oso, se la parola<br />
non sembrasse forse un po’ anacronistica per noi.<br />
D<strong>al</strong>le sue lettere appren<strong>di</strong>amo che durante il soggiorno romano il Petrarca acquistava le monete che<br />
gli portavano i conta<strong>di</strong>ni e ne decifrava con cura la leggenda ed i tipi; aurei e denari <strong>di</strong> Vespasiano egli<br />
cita nei suoi Rerum Memorandarum libri per fissare i tratti fisionomici dell’imperatore; monete annotava<br />
sui suoi co<strong>di</strong>ci dell’Historia Augusta o delle Vitae <strong>di</strong> Svetonio per illustrarne dei passi.<br />
La moneta costituiva per lui non solo una fonte storica, ma anche un mezzo <strong>di</strong> ammonimento mor<strong>al</strong>e<br />
e cosí nel 1354 donava <strong>al</strong>l’imperatore Carlo IV una piccola raccolta <strong>di</strong> monete imperi<strong>al</strong>i per esortarlo<br />
a seguire l’esempio degli antichi imperatori.<br />
Evidentemente il Petrarca raccoglieva monete e possiamo arguire da quanto ricordato sopra che la<br />
raccolta non avveniva a caso, se fra le sue monete egli aveva scelto il gruppo - forse le monete migliori<br />
per conservazione e le più significative per tipi - da donare <strong>al</strong>l’imperatore Carlo IV. Per esempio possiamo<br />
supporre con fondamento che fra queste monete non vi fossero pezzi <strong>di</strong> C<strong>al</strong>igola o <strong>di</strong> Nerone!<br />
L’amore e lo stu<strong>di</strong>o del Petrarca per le monete romane imperi<strong>al</strong>i non rimasero senza seguito, ma<br />
ebbero ripercussioni in tutta l’It<strong>al</strong>ia, se è vero che possiamo attribuire anche <strong>al</strong> suo influsso quei pezzi<br />
commemorativi che fece coniare Francesco Novello da Carrara nel 1390 a celebrazione della riconquista<br />
<strong>di</strong> Padova <strong>al</strong>le truppe viscontee. Pezzi che recavano <strong>al</strong> dritto il ritratto <strong>di</strong> Francesco Novello da Carrara<br />
ad imitazione del ritratto <strong>di</strong> Vitellio sui sesterzi.<br />
Ma dove l’esempio del Petrarca trovò il terreno piú propizio per una <strong>di</strong>ffusione dello stu<strong>di</strong>o delle<br />
monete antiche fu la Firenze del XV secolo.<br />
I nomi interessati a questo stu<strong>di</strong>o sono nomi <strong>di</strong> umanisti, <strong>di</strong> poeti qu<strong>al</strong>i un Poggio Bracciolini, un<br />
Niccolò Niccoli o un Poliziano, <strong>di</strong> mercanti, qu<strong>al</strong>i un Bernardo Rucellai o un Cosimo dei Me<strong>di</strong>ci.<br />
Poggio Bracciolini nel De Avaritia tenta <strong>di</strong> dare un breve panorama della storia della monetazione<br />
romana sulla scorta <strong>di</strong> Plinio il Vecchio. Le poche righe che egli de<strong>di</strong>ca <strong>al</strong>l’argomento non sono origin<strong>al</strong>i<br />
in quanto l’autore si limita a riassumere il noto passo della Historia Natur<strong>al</strong>is relativo <strong>al</strong>lo sviluppo<br />
della monetazione romana repubblicana, però è note<strong>vol</strong>e il fatto che Poggio avverta l’opportunità <strong>di</strong> trattare<br />
un simile argomento e soprattutto egli è il primo, a mia conoscenza, che utilizzi il passo <strong>di</strong> Plinio,<br />
ancora oggi dopo tanti secoli oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> e <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussioni vivacissime per la sua interpretazione.<br />
Anche il Poliziano tiene presente le monete nei suoi Miscellanea utilizzandole geni<strong>al</strong>mente come<br />
fonte <strong>di</strong> conoscenza antiquaria.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o delle monete romane non era limitato a ricerche <strong>di</strong> carattere storico antiquario, come ci<br />
potrebbe far supporre la nostra ment<strong>al</strong>ità moderna, ma la moneta veniva utilizzata anche come un documento<br />
per meglio conoscere e interpretare i monumenti antichi. Cosí nel De urbe Roma, scritto da Bernardo<br />
Rucellai tra il 1492 e il 1494, come un commento <strong>al</strong>la Notizia e <strong>al</strong> Curiosum costantiniani, leggiamo<br />
in piú <strong>di</strong> un passo riferimenti <strong>al</strong>le monete per spiegare i monumenti antichi.<br />
Per esempio, descrivendo la statua in bronzo <strong>di</strong> Marco Aurelio, il Rucellai la attribuisce a questo<br />
imperatore per il raffronto con l’effigie che appare su monete <strong>di</strong> Marco Aurelio. Forse non fu il primo a<br />
fare questa identificazione, perché un accenno ne fa già il Platina nella Vita <strong>di</strong> Sisto IV, ma è significativo<br />
che <strong>al</strong>l’identificazione il Rucellai sia arrivato attraverso il confronto con le monete. Forse abbiamo<br />
qui il primo esempio <strong>di</strong> una moneta utilizzata per riconoscere un monumento antico.<br />
254<br />
http://www.numismaticadellostato.it