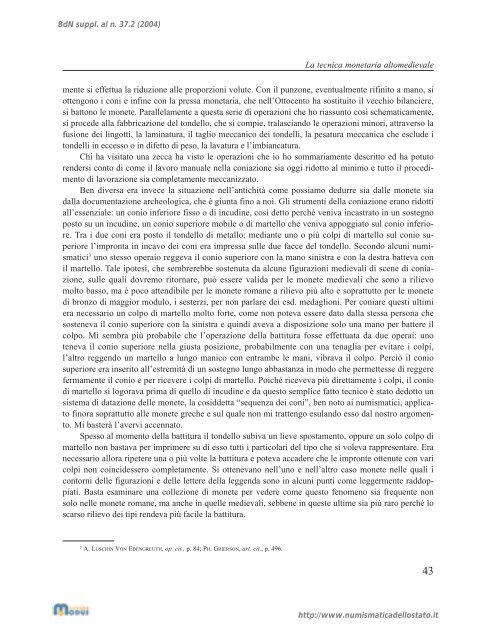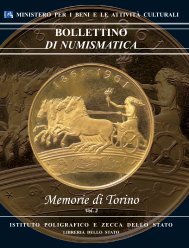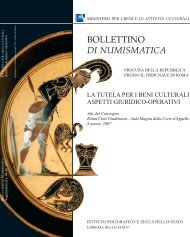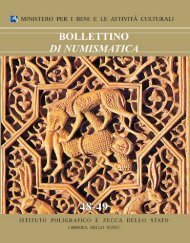Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
La tecnica monetaria <strong>al</strong>tome<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>e<br />
mente si effettua la riduzione <strong>al</strong>le proporzioni <strong>vol</strong>ute. Con il punzone, eventu<strong>al</strong>mente rifinito a mano, si<br />
ottengono i coni e infine con la pressa monetaria, che nell’Ottocento ha sostituito il vecchio bilanciere,<br />
si battono le monete. Par<strong>al</strong>lelamente a questa serie <strong>di</strong> operazioni che ho riassunto così schematicamente,<br />
si procede <strong>al</strong>la fabbricazione del tondello, che si compie, tr<strong>al</strong>asciando le operazioni minori, attraverso la<br />
fusione dei lingotti, la laminatura, il taglio meccanico dei tondelli, la pesatura meccanica che esclude i<br />
tondelli in eccesso o in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> peso, la lavatura e l’imbiancatura.<br />
Chi ha visitato una zecca ha visto le operazioni che io ho sommariamente descritto ed ha potuto<br />
rendersi conto <strong>di</strong> come il lavoro manu<strong>al</strong>e nella coniazione sia oggi ridotto <strong>al</strong> minimo e tutto il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> lavorazione sia completamente meccanizzato.<br />
Ben <strong>di</strong>versa era invece la situazione nell’antichità come possiamo dedurre sia d<strong>al</strong>le monete sia<br />
d<strong>al</strong>la documentazione archeologica, che è giunta fino a noi. Gli strumenti della coniazione erano ridotti<br />
<strong>al</strong>l’essenzi<strong>al</strong>e: un conio inferiore fisso o <strong>di</strong> incu<strong>di</strong>ne, così detto perché veniva incastrato in un sostegno<br />
posto su un incu<strong>di</strong>ne, un conio superiore mobile o <strong>di</strong> martello che veniva appoggiato sul conio inferiore.<br />
Tra i due coni era posto il tondello <strong>di</strong> met<strong>al</strong>lo: me<strong>di</strong>ante uno o più colpi <strong>di</strong> martello sul conio superiore<br />
l’impronta in incavo dei coni era impressa sulle due facce del tondello. Secondo <strong>al</strong>cuni numismatici<br />
3 uno stesso operaio reggeva il conio superiore con la mano sinistra e con la destra batteva con<br />
il martello. T<strong>al</strong>e ipotesi, che sembrerebbe sostenuta da <strong>al</strong>cune figurazioni me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>i <strong>di</strong> scene <strong>di</strong> coniazione,<br />
sulle qu<strong>al</strong>i dovremo ritornare, può essere v<strong>al</strong>ida per le monete me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>i che sono a rilievo<br />
molto basso, ma è poco atten<strong>di</strong>bile per le monete romane a rilievo più <strong>al</strong>to e soprattutto per le monete<br />
<strong>di</strong> bronzo <strong>di</strong> maggior modulo, i sesterzi, per non parlare dei csd. medaglioni. Per coniare questi ultimi<br />
era necessario un colpo <strong>di</strong> martello molto forte, come non poteva essere dato d<strong>al</strong>la stessa persona che<br />
sosteneva il conio superiore con la sinistra e quin<strong>di</strong> aveva a <strong>di</strong>sposizione solo una mano per battere il<br />
colpo. Mi sembra più probabile che l’operazione della battitura fosse effettuata da due operai: uno<br />
teneva il conio superiore nella giusta posizione, probabilmente con una tenaglia per evitare i colpi,<br />
l’<strong>al</strong>tro reggendo un martello a lungo manico con entrambe le mani, vibrava il colpo. Perciò il conio<br />
superiore era inserito <strong>al</strong>l’estremità <strong>di</strong> un sostegno lungo abbastanza in modo che permettesse <strong>di</strong> reggere<br />
fermamente il conio e per ricevere i colpi <strong>di</strong> martello. Poiché riceveva più <strong>di</strong>rettamente i colpi, il conio<br />
<strong>di</strong> martello si logorava prima <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> incu<strong>di</strong>ne e da questo semplice fatto tecnico è stato dedotto un<br />
sistema <strong>di</strong> datazione delle monete, la cosiddetta “sequenza dei coni”, ben noto ai numismatici, applicato<br />
finora soprattutto <strong>al</strong>le monete greche e sul qu<strong>al</strong>e non mi trattengo esulando esso d<strong>al</strong> nostro argomento.<br />
Mi basterà l’avervi accennato.<br />
Spesso <strong>al</strong> momento della battitura il tondello subiva un lieve spostamento, oppure un solo colpo <strong>di</strong><br />
martello non bastava per imprimere su <strong>di</strong> esso tutti i particolari del tipo che si <strong>vol</strong>eva rappresentare. Era<br />
necessario <strong>al</strong>lora ripetere una o più <strong>vol</strong>te la battitura e poteva accadere che le impronte ottenute con vari<br />
colpi non coincidessero completamente. Si ottenevano nell’uno e nell’<strong>al</strong>tro caso monete nelle qu<strong>al</strong>i i<br />
contorni delle figurazioni e delle lettere della leggenda sono in <strong>al</strong>cuni punti come leggermente raddoppiati.<br />
Basta esaminare una collezione <strong>di</strong> monete per vedere come questo fenomeno sia frequente non<br />
solo nelle monete romane, ma anche in quelle me<strong>di</strong>ev<strong>al</strong>i, sebbene in queste ultime sia più raro perché lo<br />
scarso rilievo dei tipi rendeva più facile la battitura.<br />
3<br />
A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, op. cit., p. 84; PH. GRIERSON, art. cit., p. 496.<br />
43<br />
http://www.numismaticadellostato.it