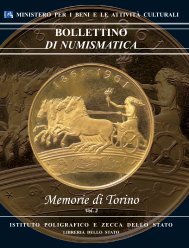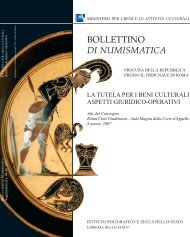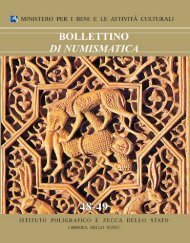Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Monete it<strong>al</strong>iane del Rinascimento<br />
Insieme <strong>al</strong> testone d’argento si <strong>di</strong>ffonde il doppio ducato d’oro che però, rispetto <strong>al</strong> testone, col suo<br />
peso inferiore (7 gr. ca.) offre minori possibilità <strong>di</strong> un rilievo accentuato. L’introduzione <strong>di</strong> questi nomin<strong>al</strong>i,<br />
sopratutto del testone, è il fatto nuovo importante che offre <strong>al</strong>l’artista la possibilità <strong>di</strong> re<strong>al</strong>izzare<br />
figurazioni più complesse e più gran<strong>di</strong>ose. Quando nel secondo quarto del XVI secolo vengono introdotti<br />
anche in It<strong>al</strong>ia i nomin<strong>al</strong>i d’argento più pesanti, gli scu<strong>di</strong>, sull’esempio dei t<strong>al</strong>leri coniati in Germania<br />
dopo l’apertura delle miniere d’argento della Boemia, un campo ancora più vasto e nuove possibilità<br />
si offrono agli incisori. Siamo ormai però <strong>al</strong>la fine del nostro periodo e si preannuncia già una nuova<br />
fase dell’arte monetaria. Infatti nel primo quarto del XVI secolo la vena dell’ispirazione degli artisti<br />
incomincia ad inari<strong>di</strong>rsi; si attenuano la freschezza delle prime creazioni e la loro forza espressiva. Tra il<br />
1530 e il 1540 sorge una nuova moneta d’oro per sostituire il vecchio ducato, lo scudo d’oro del Sole,<br />
cosiddetto da un piccolo sole posto <strong>al</strong> dritto prima della leggenda e sul qu<strong>al</strong>e il ritratto viene sostituito<br />
d<strong>al</strong>lo stemma. Rimangono però <strong>al</strong>cune forti person<strong>al</strong>ità <strong>di</strong> artisti e <strong>al</strong>cune serie sono ancora del più <strong>al</strong>to<br />
interesse artistico e numismatico, come le monete <strong>di</strong> Carlo V delle zecche <strong>di</strong> Milano e <strong>di</strong> Napoli e quelle<br />
<strong>di</strong> Paolo <strong>II</strong>I della zecca <strong>di</strong> Roma, legate in parte tra loro d<strong>al</strong>l’opera dell’incisore Leone Leoni, che lavorò<br />
a Roma e a Milano.<br />
I princip<strong>al</strong>i centri per le monete it<strong>al</strong>iane del Rinascimento furono fin d<strong>al</strong>l’inizio Milano, Mantova e<br />
Ferrara, ai qu<strong>al</strong>i si aggiunse in seguito Roma, e t<strong>al</strong>i rimasero per tutto il periodo. Anche Napoli ebbe una<br />
coniazione abbondante ma non fu sempre <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tezza delle città su in<strong>di</strong>cate. Ciò non esclude che anche in<br />
zecche minori, limitate nel tempo e d<strong>al</strong>la produzione ristretta, siano nate opere <strong>di</strong> <strong>al</strong>tissimo livello artistico,<br />
come i doppi ducati <strong>di</strong> Ludovico <strong>II</strong> <strong>di</strong> S<strong>al</strong>uzzo della zecca <strong>di</strong> Carmagnola, dove anche l’aquila del rovescio<br />
si <strong>di</strong>stingue per vivacità ed imme<strong>di</strong>atezza <strong>di</strong> rappresentazione, o i doppi ducati <strong>di</strong> Gian Francesco Pico<br />
della Mirandola, gli uni e gli <strong>al</strong>tri tra i maggiori prodotti dell’arte monetaria it<strong>al</strong>iana del Rinascimento.<br />
Non posso terminare questa breve introduzione senza accennare agli incisori, <strong>al</strong>cuni dei qu<strong>al</strong>i gran<strong>di</strong><br />
artisti, che hanno lavorato i coni delle monete del Rinascimento. Purtroppo solo pochi i nomi conosciuti<br />
e neppure <strong>di</strong> tutti è completamente nota l’attività. Mancano stu<strong>di</strong> particolari sugli incisori, stu<strong>di</strong><br />
che non potrebbero non essere accompagnati da un attento spoglio degli archivi. Solo <strong>di</strong> coloro che sono<br />
stati anche medaglisti o che si sono <strong>di</strong>stinti in <strong>al</strong>tri campi abbiamo più <strong>di</strong>ffuse notizie. Eppure ritengo<br />
che un esame approfon<strong>di</strong>to delle nostre monete del Rinascimento sotto questo punto <strong>di</strong> vista potrebbe<br />
offrire note<strong>vol</strong>i risultati non solo per il numismatico ma anche per lo storico dell’arte, così come in <strong>al</strong>tro<br />
campo, molto lontano cronologicamente da quello in esame, parlo delle monete greche della Sicilia<br />
della seconda metà del V secolo a.C., le ricerche degli stu<strong>di</strong>osi hanno fatto conoscere le person<strong>al</strong>ità <strong>di</strong><br />
un Kimon, <strong>di</strong> un Euainetos, <strong>di</strong> un Eukleidas etc. Per le monete del Rinascimento le <strong>di</strong>fficoltà sono maggiori<br />
perché purtroppo le monete non sono firmate, tuttavia un t<strong>al</strong>e stu<strong>di</strong>o meriterebbe ugu<strong>al</strong>mente <strong>di</strong><br />
essere affrontato.<br />
Tra i nomi conosciuti spiccano quelli <strong>di</strong> Francesco Raibolini detto il Francia, autore dei coni per<br />
Giulio <strong>II</strong> nella zecca <strong>di</strong> Bologna e probabilmente anche <strong>di</strong> quelli per Giovanni <strong>II</strong> Bentivoglio, <strong>di</strong> Cristoforo<br />
Foppa, il Caradosso, incisore secondo <strong>al</strong>cuni delle monete <strong>di</strong> Ludovico il Moro a Milano (<strong>al</strong>tri,<br />
come il Bernareggi ne dubitano), <strong>di</strong> Benvenuto Cellini, che lavorò a Roma per Paolo <strong>II</strong>I e a Milano per<br />
Carlo V. Altri minori, spesso per fama non per v<strong>al</strong>enzia, sono ricordati nelle note del cat<strong>al</strong>ogo come Bartolomeo<br />
Melioli a Mantova, Gian Francesco da Parma detto l’Enzola e Giovanni Antonio da Foligno a<br />
Ferrara, Emiliano Piermattei Orfini da Foligno, Pier Maria Serb<strong>al</strong><strong>di</strong> da Pescia detto il Tagliacarne e Vittore<br />
Camelio da Venezia a Roma.<br />
167<br />
http://www.numismaticadellostato.it