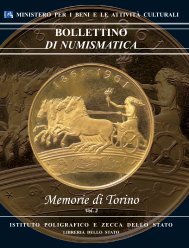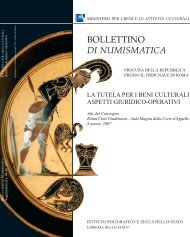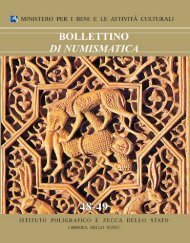Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Supplemento al n. 37 vol. II - MONETE E MEDAGLIE. Scritti di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BdN suppl. <strong>al</strong> n. <strong>37</strong>.2 (2004)<br />
Medaglie e placchette it<strong>al</strong>iane d<strong>al</strong> Rinascimento <strong>al</strong> XV<strong>II</strong>I Secolo<br />
Iniziata, come si è detto, nel 1438 con la medaglia <strong>di</strong> Giovanni V<strong>II</strong>I P<strong>al</strong>eologo, l’attività <strong>di</strong> Pisanello<br />
continua ininterrotta per circa trenta anni in varie città d’It<strong>al</strong>ia. Incerta è la data della sua morte, come<br />
incerta è l’attività degli ultimi anni della sua vita, ma tra il 1438 e il 1450 egli fu più <strong>vol</strong>te a Mantova,<br />
Rimini, Milano, Ferrara, Napoli e ritrasse sulle medaglie principi e condottieri, uomini politici e letterati<br />
tra i più famosi dei suoi tempi. Le sue medaglie sono quasi tutte presenti nella mostra e riman<strong>di</strong>amo <strong>al</strong><br />
cat<strong>al</strong>ogo per la loro descrizione.<br />
Il Pisanello fu un ritrattista insigne, come testimoniano anche i suoi <strong>di</strong>segni, tra i qu<strong>al</strong>i quelli per il<br />
ritratto dell’imperatore Sigismondo (fig. 1), e i ritratti <strong>di</strong> Lionello d’Este del Louvre e <strong>di</strong> una principessa<br />
(Margherita Gonzaga o una principessa estense) nell’accademia Carrara <strong>di</strong> Bergamo. Curò molto anche<br />
i rovesci delle medaglie, nei qu<strong>al</strong>i spesso appaiono figure <strong>di</strong> anim<strong>al</strong>i <strong>di</strong>segnati in ar<strong>di</strong>ti scorci.<br />
L’uso <strong>di</strong> farsi ritrarre su una medaglia raggiunse presto grande popolarità e <strong>di</strong>ffusione: molti artisti<br />
si de<strong>di</strong>carono a questa forma <strong>di</strong> arte sull’esempio <strong>di</strong> Pisanello, anche se questi non creò una vera e propria<br />
scuola. Ancora vivente il Pisanello, iniziò la sua attività Matteo dei Pasti, tra i migliori medaglisti<br />
it<strong>al</strong>iani del ‘400, attivo prima a Ferrara, ove fuse la medaglia <strong>di</strong> Guarino Veronese, forse la sua opera<br />
migliore, e poi, dopo il 1446, a Rimini, ove lavorò per molti anni <strong>al</strong> servizio <strong>di</strong> Sigismondo Pandolfo<br />
M<strong>al</strong>atesta, che Matteo ritrasse in numerose medaglie con <strong>di</strong>versi rovesci, tra i qu<strong>al</strong>i è da ricordare<br />
soprattutto quello che riproduce la rocca M<strong>al</strong>atestiana <strong>di</strong> Rimini. Accanto <strong>al</strong>le medaglie <strong>di</strong> Sigismondo,<br />
Matteo dei Pasti ne fuse numerose anche per Isotta degli Atti. Pur dovendosi considerare il maggiore dei<br />
medaglisti dopo il Pisanello resta a lui inferiore sia nei ritratti sia nelle composizioni del rovescio.<br />
A Ferrara, contemporaneo a Pisanello, fonde una medaglia per Lionello d’Este Ama<strong>di</strong>o da Milano,<br />
orafo <strong>al</strong>la corte estense.<br />
A Mantova, che era stata con Ferrara uno dei centri dell’attività del Pisanello, lavorò Speran<strong>di</strong>o<br />
Savelli, la cui opera si esplicò anche a Ferrara, Bologna e Venezia. Lo Speran<strong>di</strong>o fu uno dei più fecon<strong>di</strong><br />
tra i medaglisti it<strong>al</strong>iani del ‘400: i suoi ritratti mostrano una vigoria, una forza incisiva, cui non fa<br />
riscontro però <strong>al</strong>trettanta abilità tecnica nella composizione dei rovesci, dove prev<strong>al</strong>gono scene fredde<br />
prive d’ispirazione lirica (fig. 2).<br />
Mantova, tra gli ultimi decenni del ‘400 e i primi anni del ‘500 costituì per merito della famiglia Gonzaga,<br />
<strong>al</strong>la cui corte lavorarono molti medaglisti, uno dei centri più fecon<strong>di</strong> nella produzione medaglistica. Vi<br />
furono attivi Bartolomeo T<strong>al</strong>pa, Pier Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico, noto anche come bronzista,<br />
Bartolomeo Melioli, Gian Cristoforo Romano (che lavorò però anche a Milano e per il papa a Roma).<br />
A Milano troviamo Gian Francesco Enzola parmense, orafo, attivo anche a Ferrara e, nell’età <strong>di</strong><br />
Lodovico il Moro, Cristoforo Foppa detto il Caradosso, scultore e orafo, che si trasferì a Roma dopo la<br />
caduta <strong>di</strong> Lodovico.<br />
A Mantova, però, come a Milano, assistiamo a una lenta trasformazione dell’arte medaglistica: la<br />
medaglia <strong>di</strong>venta ora una speci<strong>al</strong>ità <strong>di</strong> orafi che vi portano un’eleganza ed una ricchezza <strong>di</strong> decorazione<br />
prima ignorate e che contrastano con la sobrietà e l’essenzi<strong>al</strong>ità del Pisanello. Contemporaneamente e<br />
forse sotto l’influsso dell’arte monetaria, si passa d<strong>al</strong>la vecchia tecnica della fusione a quella della<br />
coniazione, soprattutto ad opera dell’Enzola e del Caradosso, autori tra i primi <strong>di</strong> medaglie coniate ed<br />
entrambi incisori <strong>di</strong> coni monetari per la zecca <strong>di</strong> Milano.<br />
Ma l’influsso tra la moneta e la medaglia è reciproco: subito dopo il 1450 appaiono proprio a Milano<br />
i primi ritratti <strong>di</strong> Signori sulle monete con i ducati d’oro <strong>di</strong> Francesco I Sforza, seguiti a breve <strong>di</strong>stanza<br />
da quelli <strong>di</strong> Borso d’Este a Ferrara e <strong>di</strong> Ludovico <strong>II</strong> Gonzaga a Mantova.<br />
175<br />
http://www.numismaticadellostato.it