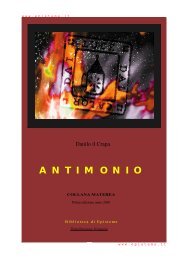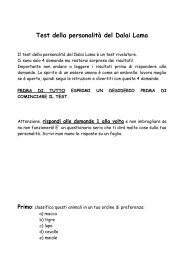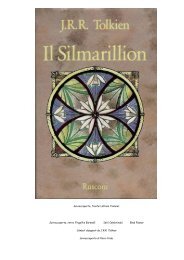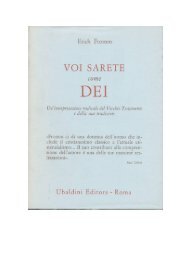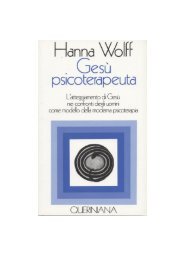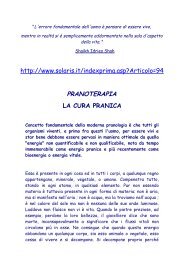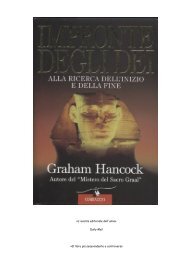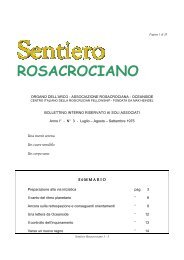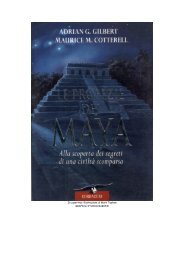N. 3 - 21 aprile 2001 - Giano Bifronte
N. 3 - 21 aprile 2001 - Giano Bifronte
N. 3 - 21 aprile 2001 - Giano Bifronte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. Un secondo Tentamen<br />
Come si evince dallo studio dei manoscritti leibniziani del periodo,<br />
appare palese che si occupò molto di queste questioni, ma soprattutto di<br />
dare una struttura coerente a tutta la sua cosmologia. Riprese ed ampliò<br />
il suo Tentamen con nuove e più ampie dimostrazioni, ma anche con<br />
nuove ipotesi riguardo alla struttura del vortice solare. Nel tentativo di<br />
risolvere la difficoltà prima citata ipotizzò che: "... appare chiaro che<br />
debba essere altra la materia fluida da quel fluido che dicemmo fare la<br />
gravità e che è spinto lontano dal centro: appare essere molto più sottile<br />
e non seguente la direzione della materia, ma è esercitante suoi propri<br />
moti ...". Che cosa vuole dire Leibniz con questa frase? Semplicemente<br />
che il gravitare dei pianeti verso il Sole e il e il gravitare dei corpi<br />
terrestri sono provveduti da due fluidi diversi, di diversa sottigliezza e<br />
non interagenti. Il primo, molto più grossolano, circola attorno al Sole<br />
in modo armonico, e fa in modo che i pianeti osservino la seconda legge<br />
di Keplero, mentre il secondo, più sottile, da al pianeta la sua 'facoltà' di<br />
attrarre tutti i corpi verso di sé da tutte le direzioni, seguendo la legge<br />
dell'inverso del quadrato delle distanze dal centro, allo stesso modo di<br />
quanto avviene a livello degli orbi planetari. Complessivamente<br />
dunque, il primo fluido fa la gravità nel Sistema Solare secondo la legge<br />
newtoniana ed obbliga i pianeti ad orbitare seguendo le due prime leggi<br />
di Keplero, mentre il secondo fluido fa la gravità nei pianeti, sempre<br />
secondo la legge newtoniana. Si realizzava così una armonizzazione di<br />
tutti i fenomeni conosciuti, ma restava aperta un'altra questione molto<br />
importante: come poteva la terza legge di Keplero conciliarsi con<br />
questo costrutto apparentemente molto elegante? Leibniz lasciò la<br />
questione aperta, e vedremo poi come tentò di risolverla, ma per ora è<br />
interessante vedere come arrivò a determinare che il fluido facente la<br />
gravità terrestre esercitasse la sua azione proprio secondo una<br />
proporzione inversa al quadrato della distanza dal Sole. L'azione<br />
gravitazionale che l'etere trasmetteva, doveva essere proporzionale alla<br />
quantità dello stesso che si trovava ad interagire con un grave qualsiasi.<br />
Ora, se si prende in considerazione un angolo solido qualsiasi, la<br />
materia eterea emessa dall'astro in quel determinato angolo solido non<br />
poteva variare, e quindi, una volta emessa la 'radiazione', questa doveva<br />
conservarsi immutata per tutto il suo allontanarsi dal centro di<br />
emissione. A questo punto, in analogia alla radiazione luminosa, la<br />
'densità eterea' doveva diminuire in maniera direttamente proporzionale<br />
alla superficie intercettata dall'angolo solido di partenza su sfere<br />
159