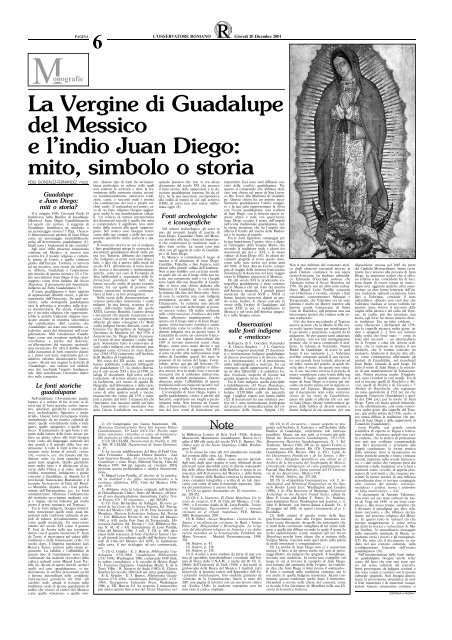You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.<br />
PAGINA<br />
Monografie<br />
6 .<br />
<strong>L'OSSERVATORE</strong> <strong>ROMANO</strong> Giovedì 20 Dicembre 2001<br />
La Vergine di Guadalupe<br />
del Messico<br />
e l'indio Juan Diego:<br />
mito, simbolo o storia<br />
FIDEL GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ, mccj<br />
Guadalupe<br />
e Juan Diego:<br />
miti o storia?<br />
Il 6 maggio 1990, Giovanni Paolo II<br />
beatificava nella Basilica di Guadalupe<br />
(Messico) Juan Diego Cuauhtlatoatzin<br />
(«L’aquila che parla»), il veggente di<br />
Guadalupe: beatificava un «simbolo» o<br />
un personaggio storico? I Papi, i Vescovi<br />
latinoamericani parlano di Juan Diego<br />
come un personaggio inscindibilmente<br />
unito all’Avvenimento guadalupano (1).<br />
Quali sono i fondamentiditale storicità?<br />
Agli inizi della presenza missionaria<br />
cristiana nel Messico, si osserva uno<br />
scontro fra il mondo religioso e culturale<br />
prima di Cortés e quello cristiano<br />
giunto dall’Europa. Tuttavia, si arriverà<br />
ad un incontro, non esente da sofferenze.<br />
Ebbene, Guadalupe è l’espressione<br />
più riuscita di questo incontro (2) e l’indio<br />
neocristiano Juan Diego il suo «messaggero»<br />
come viene definito dal Nican<br />
Mopohua, il documento più importante<br />
indigeno sul Fatto Guadalupano (3).<br />
Il tema guadalupano è stato oggetto<br />
di appassionati dibattiti storici, a partire<br />
soprattutto dall’Ottocento. Da quel momento,<br />
nella storiografia guadalupana<br />
sarà la polemica a prevalere sulla ricerca<br />
documentaria. Per alcuni, «Guadalupe»<br />
è un mito religioso che rappresenterebbe<br />
le antiche tradizioni religiose messicane<br />
assunte in maniera sincretistica<br />
dal cattolicesimo. Altri credono che<br />
«Guadalupe» sia stato uno strumento catechetico<br />
usato dai missionari nell’evangelizzazione.<br />
Altri considerano «Guadalupe»<br />
come una creazione simbolica del<br />
«creolismo» a partire dal Seicento,<br />
un’affermazione del nascente nazionalismo<br />
messicano. Per altri il dubbio nasce<br />
dalla mancanza di fonti esaustive durante<br />
i primi vent’anni; soprattutto dal cosiddetto<br />
«silenzio documentario francescano».<br />
Alcuni non negano la storicità di<br />
«Guadalupe», ma vedono nel simbolismo<br />
che racchiude l’aspetto fondamentale.<br />
Altri sottolineano l’elemento dialettico<br />
nella conquista.<br />
Le fonti storiche<br />
guadalupane<br />
Nell’analizzare l’Avvenimento guadalupano<br />
si è tentato di far ricorso ai diversi<br />
tipi di fonti storiche scritte (narrative,<br />
epistolari, giuridiche e amministrative),<br />
archeologiche, figurative e «industriali».<br />
Queste fonti provengono fondamentalmente<br />
da tre matrici culturali distinte:<br />
quelle «strettamente indie e indigene»,<br />
quelle «spagnole», e quelle «meticce».<br />
Il trattamento di ogni fonte è imposto<br />
dalla natura della fonte stessa: per<br />
dare un giusto valore alle fonti bisogna<br />
tener conto del linguaggio culturale dei<br />
due mondi e il metodo della loro trasmissione.<br />
A volte le fonti scritte si presentano<br />
sotto forma di annali, cronache,<br />
«cantari», ecc. che fissano una tradizione<br />
orale. Le fonti epistolari sono<br />
quasi tutte spagnole. Quelle giuridiche<br />
sono molto varie e si riferiscono al governo<br />
della Chiesa o al culto: lasciti di<br />
eredità, testamenti, indulgenze e grazie<br />
concesse a Guadalupe, la disputa fra il<br />
provinciale francescano Bustamante e il<br />
secondo Arcivescovo di Città del Messico<br />
Montúfar, dispute con i frati gerolamitani<br />
dell’Estremadura, ecc. Le fonti<br />
amministrative riflettono l’ordinamento<br />
del territorio novo-ispano mediante censi<br />
e mappe (alcuni indicano già molto<br />
presto il primo santuario sul Tepeyac).<br />
Tra le fonti indigene, bisogna innanzitutto<br />
menzionare quelle orali, assai importanti<br />
nella tradizione culturale di popoli<br />
di cultura prevalentemente orale,<br />
come quelli messicani. Un osservatore<br />
attento del secolo XVI come il gesuita<br />
P. José de Acosta nella sua corrispondenza<br />
con il gesuita messicano P. Juan<br />
de Tovar, si interrogava sul valore delle<br />
tradizioni e della trasmissione orale. Un<br />
secolo dopo, il linguista messicano Luis<br />
Becerra Tanco, tornava sullo stesso argomento.<br />
La validità e l’affidabilità di<br />
questo tipo di trasmissione sono state<br />
confermate dai moderni ricercatori della<br />
cultura nahuatl come Miguel León Portilla<br />
(4). Alcuni di questi antichi «archivi<br />
orali», nel caso «guadalupano», si trasformarono<br />
in archivi processuali scritti<br />
e furono autentificati nelle cosiddette<br />
Informazioni giuridiche del 1666. Gli<br />
«archivi orali» attuali si trovano nella<br />
tradizione orale di alcune popolazioni di<br />
indios che vivono al centro del Messico<br />
come quella «totonaca» o quella «oto-<br />
mí». Questo tipo di fonti ha un’importanza<br />
particolare in culture nelle quali<br />
non esisteva la scrittura e dove la trasmissione<br />
della memoria storica avveniva<br />
fondamentalmente attraverso tradizioni,<br />
canti, e racconti orali e poetici<br />
che costituiscono dei veri e propri «archivi<br />
orali». E trattandosi nel nostro caso<br />
di un fatto religioso bisogna aggiungere<br />
anche le sue manifestazioni cultuali.<br />
Un criterio di lettura interpretativa<br />
dei documenti raccolti è quello che mira<br />
a comprendere il significato loro attribuito<br />
dalla società alla quale appartengono.<br />
Nel nostro caso bisogna tenere<br />
conto delle sue varianti e delle sue componenti<br />
specifiche: india, meticcia e spagnola.<br />
Il momento storico in cui si svolgono<br />
i fatti guadalupani spiega la scarsezza di<br />
documenti guadalupani diretti della prima<br />
ora. Tuttavia, abbiamo dei rapporti<br />
che risalgono ai primi vent’anni dopo i<br />
fatti, o altri che a partire dalla metà del<br />
secolo XVI, affrontarono il tema facendo<br />
ricorso a documenti o testimonianze<br />
antiche, come nel caso di Fernando de<br />
Alva Ixtlilxóchitl e, soprattutto delle Informazioni<br />
giuridiche del 1666, che<br />
hanno raccolto molte di queste testimonianze,<br />
fra cui quelle di persone che<br />
hanno conosciuto testimoni contemporanei<br />
ai fatti e ai loro protagonisti.<br />
Nella storia della documentazione rivestono<br />
particolare importanza i codici<br />
indigeni. In una lettera, scoperta di recente,<br />
dell’erudito italiano del secolo<br />
XVIII, Lorenzo Boturini, l’autore elenca<br />
i documenti che intende recuperare e ricerca<br />
l’intervento di persone competenti<br />
affinché gli siano consegnati (5). Molti<br />
codici indigeni furono distrutti, come affermano<br />
fra’ Bernardino de Sahagún e<br />
Gerónimo de Mendieta (6). Nel 1578, il<br />
domenicano fra’ Diego Durán riconosceva<br />
l’errore di aver distrutto i codici indigeni.<br />
Nonostante tutto si conservano alcuni<br />
codici indigeni con riferimenti guadalupani<br />
come «Crónica de Juan Bautista»<br />
(1563-1574) conservato nell’Archivio<br />
della Basilica di Guadalupe.<br />
Nel corso del XX secolo, vari autori<br />
hanno pubblicato collezioni bibliografiche<br />
guadalupane (7). Lo storico Burrus,<br />
per il solo secolo XVI e fino al 1590, cataloga<br />
25 documenti. Egli scrive nell’introduzione:<br />
«Il lettore attento si accorgerà<br />
facilmente, per mezzo di questa Bibliografia,<br />
dell’abbondanza e della varietà<br />
degli scritti guadalupani prodotti nel<br />
corso di oltre quattro secoli e mezzo:<br />
manoscritti che vanno dal 1531 e stampati<br />
a partire dal 1610. I manoscritti che<br />
riportiamo non lasciano dubbi sul fatto<br />
che l’eminente storico messicano Joaquín<br />
García Icazbalceta era in errore<br />
1) Cfr Congregatio pro Causis Sanctorum, 184,<br />
Mexicana Canonizationis Servi Dei Ioannis Didaci<br />
Cuauhtlatoazin, Vir Laici (1474-154). Positio super<br />
fama sanctitatis, virtutibus et cultu ab immemorabili<br />
praestito ex officio concinata, Romae 1989.<br />
2) Cfr III CELAM, Documentos de Puebla, n. 282;<br />
n. 446; IV CELAM, Documentos de Santo Domingo,<br />
n. 15.<br />
3) La recente pubblicazione del libro di Fidel González<br />
Fernández - Eduardo Chávez Sánchez - José<br />
Luis Guerrero Rosado, El encuentro de la Virgen de<br />
Guadalupe y Juan Diego, Editorial Porrúa, Città del<br />
Messico 1999, 564 pp. [quarta ed. riveduta: 2001]<br />
presenta questa problematica e relativa documentazione.<br />
4) Miguel León Portilla, El destino de la palabra.<br />
De la oralidad y los glifos mesoamericanos a la<br />
escritura alfabética, FCE, Città del Messico 1996,<br />
pp. 19-71.<br />
5) Abbiamo visto la lettera originale nell’Archivio<br />
di Chimalhuacán Chalco, Stato del Messico, all’interno<br />
di una documentazione denominata Códice Teresa<br />
Franco. Cfr : El encuentro... , pp. 283-284.<br />
6) Cfr Fray Bernardino de Sahagún, Historia general<br />
de las Cosas de la Nueva España, Ed. Porrúa,<br />
Città del Messico 1982, pp. 18-19; Fray Geronimo de<br />
Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Ed. Porrúa<br />
(= Col. Biblioteca Porrúa N. 46), Città del Messico<br />
1980, p. 630; anche Fray Juan de Torquemada, Monarquía<br />
Indiana, Ed. Porrúa (= Col. Biblioteca Porrúa<br />
N. 41, 42 e 43). Introduzione di León Portilla,<br />
Città del Messico 1986, 3 voll., T. III, p. 449; altre<br />
cause della scarsezza di fonti d’archivio furono i furti,<br />
gli incendi (ricordiamo quello dell’Archivio Comunale<br />
di Città del Messico del 1692), la legislazione<br />
sulla carta, il suo riciclaggio ad uso commerciale,<br />
ecc.<br />
7) Cfr G. Grijales - E. J. Burrus, Bibliografia Guadalupana<br />
(1531-1984). Guadalupan Bibliography<br />
(1531-1984), Washington 1986; comprende 1049 titoli,<br />
in ordine cronologico; e le raccolte di Héctor Rogel<br />
H.- Francisco Organista - Guadalupe Marín; E. de la<br />
Torre Villar - R. Navarro de Anda (1982); E. Chávez<br />
Sánchezharaccolto2206titolisul tema guadalupano.<br />
8) G. Grijales - E. J. Burrus, Bibliografia Guadalupana<br />
(1531-1984). Guadalupan Bibliography (1531-<br />
1984), Georgetown University Press, Washington<br />
1986, p. VII. Burrus S.J. ha scoperto il manoscritto<br />
più antico giunto fino a noi del Nican Mopohua nel-<br />
quando pensava che non vi era alcun<br />
documento del secolo XVI che provava<br />
il fatto storico delle apparizioni e la devozione<br />
guadalupana espressa fin da allora.<br />
Se la sua asserzione corrispondeva<br />
alla realtà al tempo in cui egli scriveva<br />
(1888), di certo non può essere riaffermata<br />
oggi» (8).<br />
Fonti archeologiche<br />
e iconografiche<br />
Nel settore archeologico, gli scavi in<br />
uno dei presunti luoghi di nascita di<br />
Juan Diego, Cuautitlán (Stato del Messico)<br />
portano alla luce elementi importanti<br />
che confermano la tradizione orale e<br />
altre fonti scritte. La stessa cosa può<br />
dirsi con gli oggetti di culto di Guadalupe<br />
e di Juan Diego.<br />
In Messico si contendono il luogo di<br />
nascita o di abitazione di Juan Diego:<br />
Cuatitlán, Tulpetlac e San Juanico, tutti<br />
situati nella grande vallata dell’Anahuac.<br />
Non si può stabilire con certezza assoluta<br />
quale dei tre sia il luogo della sua nascita,<br />
ma certamente tutti e tre i luoghi<br />
sono legati alla sua biografia. A Cuautitlán<br />
si trova una chiesa dedicata alla<br />
Madonna di Guadalupe; la costruzione<br />
fu iniziata alla fine del Settecento. Sotto<br />
di essa fu scoperta una casa indigena<br />
preispanica; accanto ad essa, già nel<br />
Cinquecento, fu costruita una piccola<br />
cappella i cui resti archeologici si possono<br />
ancora vedere. Gli indios testimoni<br />
nelle «Informaciones Jurídicas» del 1666<br />
hanno affermato unanimemente che<br />
questo era il luogo nativo di Juan Diego;<br />
queste «Informaciones Jurídicas» vanno<br />
rivalorizzate come la verifica di una tradizione<br />
indigena viva su questo tema. A<br />
Cuautitlán fu eretto un convento francescano<br />
nei cui registri parrocchiali dal<br />
1587 si trovano numerosi nomi «Juan<br />
Diego», nome poco usato altrove e qui<br />
ripetuto in onore al veggente. Nel 1853<br />
si sono raccolte altre testimonianze degli<br />
indios di Cuatitlán; questi Atti sono in<br />
possesso di un notaio del luogo, Covarrubias,<br />
attivo qui già dal Seicento (9).<br />
La tradizione orale a Cuatitlán si dimostra<br />
ancora viva in molte feste e mercati<br />
(tianguis) che si celebrano ininterrottamente<br />
dal periodo preispanico. Questo<br />
dimostra anche l’affidabilità di queste<br />
tradizionioraliconfrequentiriscontri nell’archeologia<br />
e nella letteratura scritta.<br />
L’iconografia di Juan Diego, legata a<br />
quella guadalupana, cresce a partire dal<br />
Seicento, soprattutto nei luoghi a predominanza<br />
india. Non lontano da Cuautitlán,<br />
a Tepozotlán, i Gesuiti costruirono<br />
uno dei loro centri di formazione più<br />
Note<br />
importanti. Essi sono stati diffusori convinti<br />
della traditio guadalupana. Per<br />
questo si comprende che abbiano dedicato<br />
una chiesa nel paese di San Lorenzo<br />
Río Tenco alla Madonna di Guadalupe.<br />
Questa chiesa ha un aspetto peculiarmente<br />
guadalupano: l’altare maggiore<br />
e la sua pala rappresentano la tilma<br />
con l’icona guadalupana; una scultura<br />
di Juan Diego, con le braccia aperte sostiene<br />
altare e pala con quest’icona;<br />
Juan Diego occupa il posto dell’angelo<br />
nell’icona tradizionale guadalupana, nella<br />
stessa posizione che ha l’angelo che<br />
afferra il lembo del manto della Madonna<br />
e lo mostra al popolo.<br />
Fra le fonti figurative campeggia per<br />
la sua importanza l’«ayate» dove è dipinta<br />
l’immagine della Vergine Maria, che<br />
secondo la tradizione orale e alcuni dei<br />
documenti già del s. XVI, è la stessa<br />
«tilma» di Juan Diego (10). In alcuni documenti<br />
spagnoli si trova questo dato,<br />
come nelle note scritte nei primi anni<br />
del 1600, di Suor Ana de Cristo, compagna<br />
di viaggio della monaca francescana<br />
JerónimadelaAsunción,nel loro viaggio<br />
verso le Filippine attraverso il Messico.<br />
Fin dal secolo XVI la produzione iconografica<br />
guadalupana è stata costante<br />
sia in Messico che nel resto dei domini<br />
dell’America spagnola. I grandi pittori<br />
messicani dei secoli XVII e XVIII ci<br />
hanno lasciato numerosi dipinti su questo<br />
tema. Inoltre, le chiese costruite in<br />
onore della Vergine di Guadalupe, dal<br />
secolo XVII in poi, si moltiplicano in<br />
Messico e nel resto dell’America spagnola<br />
e nella Spagna stessa.<br />
Osservazioni<br />
sulle fonti indigene<br />
e «meticce»<br />
Nell’opera di F. González Fernández<br />
— E. Chávez Sánchez — J. L. Guerrero<br />
Rosado vengono presentati 27 documenti<br />
o testimonianze indigene guadalupane<br />
di diversa provenienza e di diverso valore<br />
e interpretazione, e 8 di provenienza<br />
mista india-spagnola o meticcia, fra cui<br />
emergono quelli appartenenti a Fernando<br />
de Alva Itlilxóchitl e il cosiddetto Codice<br />
Escalada, scoperto di recente dal<br />
gesuita spagnolo Javier Escalada (11).<br />
Tra le fonti indigene, quella principale<br />
è indubbiamente «El Nican Mopohua»,<br />
attribuita allo scrittore indio Antonio Valeriano<br />
(1520-1606) sulla cui paternità<br />
oggi, i migliori esperti non hanno dubbi<br />
(12). Il documento ha una struttura poetica<br />
ed è «una testimonianza privilegiata<br />
del processo di transculturazione del cristianesimo<br />
della Nuova Spagna (13).<br />
la Biblioteca Lennox di New York (USA), Sezione<br />
Manoscritti, Monumento Guadalupano. Burrus fa risalire<br />
il MS alla metà del secolo XVI: E. Burrus, The<br />
Oldest copy of the Nican Mopohua, CARA, Washington<br />
1981.<br />
9) Io stesso ho visto tali Atti attualmente custoditi<br />
dal cronista della città, Lic. Fragoso.<br />
10) Gli studi sulla «tilma» sono ancora parziali.<br />
Agli inizi degli anni ottanta si sono effettuati alcuni<br />
interventi assai discutibili sotto la diretta responsabilità<br />
delle allora Autorità della Basilica e senza la conoscenza<br />
dell’Arcivescovo del Messico e della Santa<br />
Sede. Il museo della Basilica conserva la documentazione<br />
completa fotografica e scritta di un tale intervento<br />
così come di tutto il materiale asportato. Questa<br />
documentazione è ancora inedita.<br />
11) Cfr su questo documento en: El encuentro... ,<br />
pp. 329-352.<br />
12) Cfr J. L. Guerrero, El Nican Mopohua. Un intento<br />
de exégesis, U.P. di Città del Messico, 2 voll.,<br />
1998.; e il recente studio di M. León-Portilla, Tonantzin<br />
Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje<br />
cristiano en el «Nican mopohua», FCE, México<br />
2000. Reimpresión: 2001.<br />
13) R. Nebel, «Nican Mopohua». Cosmovisión indígena<br />
e inculturación cristiana, in Hans - Jurgen<br />
Prien (ed), Religiosidad e Historiografía. La irrupción<br />
del pluralismo religioso en América y su elaboración<br />
metódica en la historiografía, Frankfurt am<br />
Main: Vervuert, - Madrid: Iberoamericana, 1998,<br />
238.<br />
14) Ibidem, p. 47.<br />
15) Ibidem, p. 236.<br />
16) Ibidem, p. 238.<br />
17) Il «Codice è stato studiato da parte di una ventina<br />
di specialisti interdisciplinari coordinati dall’Istituto<br />
di Fisica della U.N.A.M., e anche dal Dr Ch. E.<br />
Dibble dell’Università di Utah (USA) e dai periti in<br />
grafoscopia della Banca del Messico. I risultati, tutti<br />
favorevoli, si possono vedere nell’Appendice dell’Enciclopedia<br />
Gudalaupana. Uno studente graduato de<br />
«Ciencias de la Comunicación» lanciò a metà del<br />
2001 una pagina di internet con un suo lavoro critico<br />
sul «Códice 1548»; lo studente sopradetto non ha<br />
mai visto il codice originale.<br />
Non si può dubitare del contenuto storico<br />
degli elementi essenziali attorno ai<br />
quali l’Autore costruisce la sua opera<br />
storico-letteraria. Lo studioso nahuatliaco<br />
Edmundo O’Gorman sostiene che<br />
Valeriano scrisse il Nican Mopohua nel<br />
1556. Da parte sua un altro noto nahuatliaco<br />
Miguel León Portilla concorda<br />
con O’Gorman e ricorda, citando i frati<br />
missionari contemporanei Sahagún e<br />
Torquemada, che Valeriano era un noto<br />
latinista e anche un illustre maestro alla<br />
famosa scuola francescana di Santa<br />
Cruz de Tlatelolco; egli propone una sua<br />
interessante ipotesi che citiamo nella nostra<br />
traduzione:<br />
«Ciò che stava succedendo al Tepeyac<br />
pareva provare che la Madre di Dio aveva<br />
scelto questo luogo per manifestare lì<br />
il suo amore e protezione a quanti da lei<br />
andassero. Se per questo tanti andavano<br />
al Tepeyac, non era una immaginazione<br />
pensare che si stava compiendo il desiderio,<br />
la volontà di Tonantzin, Nostra<br />
Madre de Guadalupe, di avere in quel<br />
luogo il suo santuario [...]. Valeriano<br />
avrebbe composto quindi il suo racconto,<br />
con grande forza teatrale, attorno ad<br />
un indio, uomo del popolo, al quale dovette<br />
dare il nome. Se questo non esisteva,<br />
il suo racconto correva il pericolo di<br />
essere considerato come frutto della sua<br />
fantasia. È logico quindi pensare che il<br />
nome di Juan Diego si trovava già vincolato<br />
da molto prima con la signora venerata<br />
nel Tepeyac. Bisogna ricordare<br />
qui il documento noto come «informaciones<br />
de los viejos de Cuauhtitlán»,<br />
paese del quale si afferma che era nativo<br />
Juan Diego. Queste testimonianze apprese<br />
dalle labbra di diversi uomini e<br />
donne indigeni di età avanzata, per una<br />
18) Cfr in El encuentro...; nuove scoperte in proposito<br />
nell’Archivio S. Vaticano e nell’Archivio della<br />
Basilica di Guadalupe, confermano tale interesse<br />
pontificio. Alcuni, ma non tutti, si trovano già pubblicati<br />
da: Documentario Guadalupano, 1531-1768.<br />
Monumenta Historica Guadalupanensia, N. 3. Ed.<br />
Tradición, México 1980, 299 ps. In questo Centro si<br />
trovano raccaolti diversi Ms (Cfr Comemoración<br />
Guadalupana 450, México 1984, p. 451). Copia de<br />
los Documentos Pontificios y de los Exmos. y Revmos.<br />
Sres. Delegados Apostólicos que obran en el<br />
Archivo de la Secretaría del Arzobispado de México,<br />
Concediendo indulgencias al culto guadalupano, en<br />
Pascual Díaz Barreto, Carta pastoral del IV Centenario<br />
de las Apariciones, México 1931.<br />
19) Nebel, Ibidem, pp. 237-238.<br />
20) Cfr in «Columbian Consequences», vol. 2, Archeological<br />
and Historical Perspectives on the Spanish<br />
Border Lands East, Washington and London<br />
(1990), e in «The Recovery of Meaning», Historical<br />
Archeology in the Eastern United States, edited by<br />
Marc P. Leone and Parker V. Potter, Jr., Smithsonian<br />
Institution Press, Washington and London, s. d.<br />
John S. Belmont, con lettera datata a Kanab, Ut., il<br />
25 maggio del 2000, su questi ritrovamenti al p. J.<br />
Escalada.<br />
21) Sulle origini di questo nome della Spagna/Estremadura,<br />
dato alla Vergine messicana esistono<br />
teorie divergenti: da quelle che sostengono che<br />
si tratti della corruzione castigliana di un nome indigeno<br />
a quella più diffusa secondo la quale il nome fu<br />
scelto esplicitamente (come compare già nel Nican<br />
Mopohua) perché fosse chiaro che si trattava della<br />
Vergine Maria, venerata sotto quel titolo nella patria<br />
di molti missionari e conquistadores.<br />
22) La tomba di Juan Diego non ci è conosciuta<br />
ancora; il fatto si da spesso anche nel caso di personaggi<br />
illustri, sia indigeni che spagnoli. A Guadalupe,<br />
secondo una tradizione, fu eretta una «cappella» sul<br />
luogo in cui si trovava la casupola di Juan Diego,<br />
non lontano dal santuario della Vergine. La tradizione<br />
dice che Juan Diego si ritirò presso il «santuario».<br />
Il fatto è normale nella tradizione cristiana, ma lo<br />
era anche in quella indigena messicana. Alcuni continuano<br />
questa tradizione anche dopo il battesimo,<br />
ritirandosi a servire nelle chiese dei conventi, come<br />
ci ricorda il fra Gerónimo de Mendieta nella sua Historia<br />
Eclesiástica Indiana.<br />
disposizione emessa nel 1665 da parte<br />
del Capitolo Metropolitano, fanno certamente<br />
luce attorno alla persona di Juan<br />
Diego. Le numerose notizie che ci offrono<br />
relative a lui, coincidenti fra di loro,<br />
sono degne di essere tenute in conto».<br />
Dopo aver aggiunta qualche altra osservazione<br />
su altre forme letterarie dell’antica<br />
tradizione nahuatl certamente familiari<br />
a Valeriano, conclude il noto<br />
nahautliaco: «Questo non vuol dire che<br />
Valeriano tradisca se stesso volendo far<br />
passare come storico il racconto delle<br />
origini della pittura e del culto nel Tepeyac.<br />
In realtà, più che inventare una<br />
storia, egli forse ha messo insieme diverse<br />
tradizioni. Era un fatto evidente —<br />
come riferiscono i dichiaranti del 1556che<br />
la cappella attraeva molta gente, indios<br />
e spagnoli [...] Non era lontano<br />
dalla verità che fosse stato — come in<br />
tanti altri racconti — un intermediario<br />
fra la Vergine e colui che doveva ordinare,<br />
che si mettesse in pratica il suo<br />
desiderio, che le venisse costruito un<br />
santuario. Qualcosa si dovette dire allora,<br />
come continuarono affermando gli<br />
anziani di Cuauhtitlán, sul macehuatl<br />
Juan Diego, oriundo di quel luogo. Di<br />
fatto il nome di Juan Diego e la menzione<br />
di una manifestazione di Totlazonantzin,<br />
Nostra preziosa madre [Guadalupe],<br />
sono ricordati in vari annali. Tra di<br />
essi si trovano quelli di Tlatelolco e México,<br />
quelli di Puebla e di Tlaxcala e l’<br />
Añalejo de Bartolache, che registrano<br />
un anno equivalente al 1531 per ciò che<br />
riguarda Tonantzin [Guadalupe] e quello<br />
del 1540 [sic] per la morte di Juan<br />
Diego. Tutto ciò lascia quindi intravedere<br />
che effettivamente, così come concorreva<br />
molta gente alla cappella del Tepeyac,<br />
già molto prima del 1556, anche si<br />
era ormai diffusa la tradizione che parlava<br />
di Juan Diego e delle apparizioni di<br />
Tonantzin [Guadalupe]»<br />
Leon Portilla, con grande onestà<br />
scientifica di esperto in lingua e letteratura<br />
nahuatl, riconosce quindi una verità<br />
evidente, che lo storico di professione<br />
non può non verificare comparandola<br />
con altri documenti e arrivando alla<br />
doppia conclusione: la forma poetica<br />
della relazione dove si incorporano sia<br />
forme poetiche antiche e forme cristiane<br />
recenti, imparate nella scuola francescana,<br />
e i dati storici che vengono presi dai<br />
testimoni e dalla tradizione viva (i fatti e<br />
testimoni erano «vecchi» di appena pressapoco<br />
di vent’anni) e che vengono presentati<br />
in forma poetica di una bellezza<br />
straordinaria dove si trovano congiugate<br />
«dos visiones del mundo, creencias,<br />
metáforas y atisbos, trama y urdimbre<br />
de hilos multicolores...» (14).<br />
Il documento di Antonio Valeriano,<br />
reso noto nel suo testo náhuatl da Lasso<br />
de Vega nel 1649, «è un testo complesso<br />
e, allo stesso tempo, semplice che<br />
è divenuto il paradigma per altre relazione<br />
successive e che influisce decisamente<br />
sul processo religioso del Messico.<br />
In questo testo in náhuatl ciò che<br />
emerge maggiormente è, come aveva<br />
già detto lo storico e nahuatlaco A. María<br />
Garibay, lo straordinario messaggio<br />
della maternità spirituale di Maria, soprattutto<br />
verso i poveri e gli emarginati»<br />
(15). Per tutto ciò, il documento va studiato<br />
nel suo contesto culturale, nella<br />
«configurazione letteraria dell’evento<br />
guadalupano» (16).<br />
Nell’interpretazione delle fonti indigene<br />
guadalupane bisogna anche tener<br />
conto del fatto che esse non sono «pure»<br />
nel senso culturale del concetto,<br />
bensì provengono da indigeni cristiani o<br />
che sono venuti a contatto con il mondo<br />
culturale spagnolo. Non bisogna dimenticare<br />
la provenienza umanistica di molti<br />
frati missionari e di numerosi conquistatori.<br />
Questo umanesimo cristiano si<br />
CONTINUA A PAGINA 7