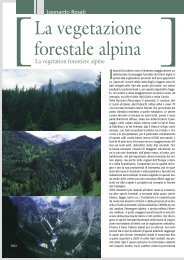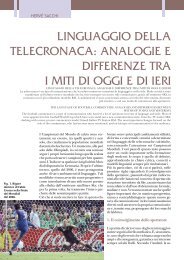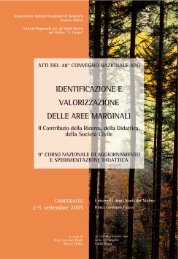Terre di mezzo: la Basilicata tra costruzione regionale e proiezioni ...
Terre di mezzo: la Basilicata tra costruzione regionale e proiezioni ...
Terre di mezzo: la Basilicata tra costruzione regionale e proiezioni ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Italo Talia<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne idrogeologico, dal <strong>di</strong>sboscamento e da un’emigrazione volta dapprima<br />
al<strong>la</strong> “scoperta” dell’America e poi al<strong>la</strong> “scoperta” dell’Europa.<br />
Considerata, dunque, secondo alcuni in<strong>di</strong>catori significativi, quali il flusso<br />
migratorio superiore al<strong>la</strong> me<strong>di</strong>a meri<strong>di</strong>onale, l’occupazione agrico<strong>la</strong> superiore al<br />
50% <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> totale, l’armatura urbana debole con un’offerta <strong>di</strong> servizi a livello<br />
banale, un’industria <strong>tra</strong><strong>di</strong>zionale e con respiro locale, si può ritenere che <strong>la</strong><br />
<strong>Basilicata</strong> mantenesse, al<strong>la</strong> metà degli anni ’70, tutte le caratteristiche <strong>di</strong> un’area<br />
interna del Mezzogiorno.<br />
L’aggettivazione <strong>di</strong> “area interna” non può però essere generalizzata. Già<br />
agli inizi del secolo scorso Eugenio Azimonti poteva <strong>di</strong>stinguere «innanzi tutto<br />
l’Alta <strong>Basilicata</strong>, o <strong>Basilicata</strong> montuosa, o <strong>Basilicata</strong> Occidentale, dal<strong>la</strong> <strong>Basilicata</strong><br />
Orientale o “marine” <strong>di</strong> <strong>Basilicata</strong>». Ed aggiungeva che «i limiti dei due quadri,<br />
<strong>la</strong>ddove essi dovrebbero congiungersi, non sono ben definiti ed è giocoforza<br />
iso<strong>la</strong>re, frapposto ai due, un terzo quadro <strong>di</strong> un paese che piglia le tinte un po’<br />
dell’uno, un po’ dell’altro, e forma come una zona grigia, un <strong>tra</strong>it d’union, salvo<br />
che in una parte (il Melfese), dove assume tinte spiccatamente proprie,<br />
omogenee, costituendo così come un quarto piccolo pays».<br />
Tale re<strong>la</strong>tiva <strong>di</strong>somogeneità dei quattro <strong>di</strong>versi quadri ambientali in<strong>di</strong>viduati<br />
dall’Azimonti sul<strong>la</strong> base delle caratteristiche agro-pedologiche trova poi<br />
un’ulteriore specificazione nel<strong>la</strong> illus<strong>tra</strong>zione del<strong>la</strong> carta dell’uso del suolo, nei<br />
primi anni ’60, da parte <strong>di</strong> Manlio Rossi Doria, in cui si <strong>di</strong>stingue <strong>tra</strong> <strong>la</strong><br />
montagna potentina in senso stretto e quel<strong>la</strong> <strong>la</strong>gonegrese, con uno più spiccato<br />
carattere silvo-pastorale. E si <strong>di</strong>stingue inoltre <strong>tra</strong> le “marine” del Bradano e<br />
quelle del Metapontino, in cui, aggiunge Rossi Doria, i dati hanno subito dal<br />
1929 ad oggi «i più profon<strong>di</strong> mutamenti e ancor più ne subiranno negli anni<br />
prossimi quando entreranno in funzione i gran<strong>di</strong> impianti irrigui, per il fatto <strong>di</strong><br />
essere oggetto dell’unica, profonda e generale <strong>tra</strong>sformazione degli or<strong>di</strong>namenti<br />
agricoli nel<strong>la</strong> regione».<br />
È negli anni ’50 e ’60, che si intacca una realtà quasi compatta <strong>di</strong><br />
sottosviluppo omogeneo e si determina, come si è detto, un dualismo interno al<strong>la</strong><br />
stessa regione, in partico<strong>la</strong>r modo <strong>tra</strong> le aree montane e le “marine”, <strong>tra</strong> le aree<br />
montane e collinari e una rete urbana che inizia, a partire dagli anni ’70, ad<br />
ispessirsi. Fondamentale, da questo ultimo punto <strong>di</strong> vista, appare <strong>la</strong> rottura<br />
dell’iso<strong>la</strong>mento geografico, rottura che non si era verificata con <strong>la</strong> “cura <strong>di</strong> ferro”<br />
a cavallo <strong>tra</strong> ’800 e ’900, né con <strong>la</strong> minuta rete ferroviaria dell’Ofanto, né con<br />
quelle sulle più lunghe <strong>di</strong>rettrici lungo il Tirreno, lungo <strong>la</strong> costa ionica e <strong>tra</strong><br />
Tirreno e Ionio, <strong>tra</strong> Salerno e Taranto. Maggiore successo ha avuto, al con<strong>tra</strong>rio,<br />
<strong>la</strong> cura “su gomma”. Dapprima il collegamento longitu<strong>di</strong>nale lungo il Basento,<br />
poi lungo l’Agri ed il Sinni, e quin<strong>di</strong> at<strong>tra</strong>verso l’incompiuta Bradanica, per cui,<br />
sia pure in modo non completo, lo spazio <strong>regionale</strong> tende ad integrarsi con le<br />
aree contermini. Ma, in assenza <strong>di</strong> forze centripete, vale a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> una rete urbana<br />
forte, il raccordo territoriale non si è <strong>tra</strong>dotto anche in una integrazione<br />
economica all’interno del<strong>la</strong> regione. È continuata a manifestarsi <strong>la</strong> tendenza<br />
verso gravitazioni esterne: l’area del Vùlture verso il Foggiano, quel<strong>la</strong> del<br />
Bradano verso l’area metropolitana <strong>di</strong> Bari, il Metapontino verso Taranto e Bari,<br />
le aree montane occidentali verso <strong>la</strong> propaggine meri<strong>di</strong>onale dell’area<br />
metropolitana del<strong>la</strong> Campania.<br />
34