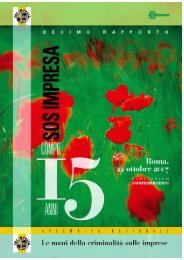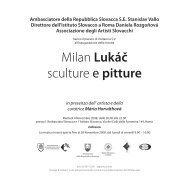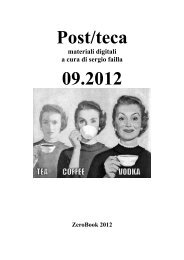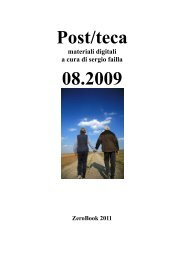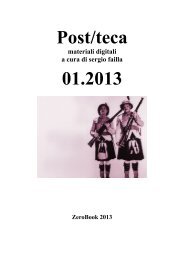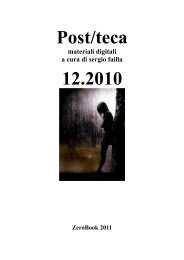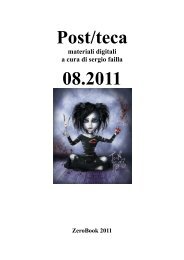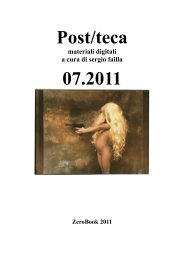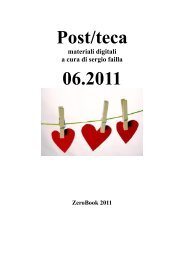postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Post/teca<br />
Fatta l’Italia, 1861, restavano da fare gli italiani,<br />
secondo il monito di Massimo d’Azeglio; ma mancavano anche i libri che potessero, per la loro<br />
storia, valori e ideali, porsi come strumenti di educazione e formazione della rinata Italia. A tale<br />
progetto contribuirono certamente I promessi sposi, in specie a partire dall’edizione illustrata del<br />
1840. Ma non bisogna dimenticare il ruolo essenziale avuto da Le mie prigioni di Silvio Pellico<br />
(Saluzzo 1789 - Torino 1854). Ci fu un’Italia eroica del sacrificio: quello del sangue, delle lotte<br />
risorgimentali, dei giovani morti a Curtatone e Montanara (29 maggio 1848), dei garibaldini e<br />
mazziniani; di tutto quel sangue saranno eredi le pagine di Cuore. Ma ci fu anche un’Italia più<br />
silente, stoica, quella di un cattolicesimo biblico, legato più alla coscienza che ai riti o ai poteri, del<br />
quale il Pellico e il Rosmini furono i più coerenti interpreti. Rileggere oggi qualche pagina da Le<br />
mie prigioni significa ritrovare la storia sotterranea di un "pietismo" europeo che, basato sulla<br />
semplicità, su un narrare sobrio, per quadretti raccolti, per capitoletti distribuiti intorno a una o due<br />
figure, aveva dato i suoi migliori frutti in Johann Peter Hebel (1760-1826), autore poi amatissimo<br />
da Walter Benjamin. Le sue Storie bibliche (1828-1829) sono, sul versante riformato, quello che Le<br />
mie prigioni rappresentano, con ben più ampia risonanza, sul versante cattolico; con la stessa<br />
attenuazione anti-eroica dello stile, nella ricerca di una «calma costante» («Curioso fatto, che il<br />
vivere arrabbiato piaccia tanto! Vi si pone una specie di eroismo!», capitolo XVII) nel governo di sé,<br />
nel giudizio sugli eventi, per quanto terribili come il carcere duro. La loro diffusione fu europea<br />
(edizioni in lingua italiana: Torino e Saluzzo 1832; Capolago 1833; Lugano 1834 e 1842; Parigi-<br />
Lione 1833, 1834, 1840, 1845; Bruxelles 1839; Bastia 1842; Malta 1842; Firenze 1847 e 1851;<br />
Milano 1858), anche in lingua francese (Mes prisons, Paris, Fournier 1833, 1837, 1838, 1842,<br />
eccetera). Più tardi – nello Stato unitario – continuò ad essere modello delle virtù risorgimentali: le<br />
edizioni si moltiplicarono, in effetti, dall’anno stesso dell’unificazione: Napoli 1860; Torino e Milano<br />
1862, eccetera; e anche nei decenni successivi: Milano 1867, 1871, 1877, 1886, 1880, 1889,<br />
1898; Torino 1874, 1887, 1890, 1893, eccetera, senza contare le molte edizioni scolastiche<br />
fiorentine, torinesi e milanesi di inizio XX secolo. Andrà anzi osservato, a proposito della<br />
formazione del Pellico, che gli anni lionesi lo porranno in contatto non solo con le correnti<br />
dell’Illuminismo, ma anche con i circoli di un cattolicesimo riformatore – si ricordino, su tutti, Pierre-<br />
Simon Ballanche (Lione 1776 – Parigi 1847), e sulla sua scia, appena più giovani del Pellico,<br />
Frédéric Ozanam (1813-1853), studioso di Dante e fondatore delle Conferenze di San Vincenzo<br />
de’ Paoli, e Jean-Jacques Ampère (1800-1864), francesista e comparatista, entrambi poi allievi, a<br />
Parigi, di Fauriel – che gli permetterà, negli anni milanesi, di aderire alla Carboneria e, non meno,<br />
di rimanere fedele alla Filotea di san Francesco de Sales. L’esperienza milanese, 1809-1820, lo<br />
vede prima di tutto artefice di testi teatrali: la tragedia Francesca da Rimini, 1815, ebbe un<br />
successo immediato, tanto che venne tradotta anche in francese e tedesco. Nel 1818 esce il<br />
Conciliatore, rivista-manifesto dei Romantici milanesi: il Pellico ne sarà animatore e sollecito<br />
redattore. Nel 1820, entra in contatto con Pietro Maroncelli, affiliato alla Carboneria, e vi aderisce;<br />
arrestato dagli austriaci, è processato a Milano (1820-1821), poi trasferito ai Piombi a Venezia,<br />
infine condannato a morte (pena commutata in «quindici anni di carcere duro» e trasferito alla<br />
258