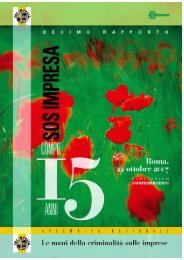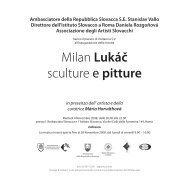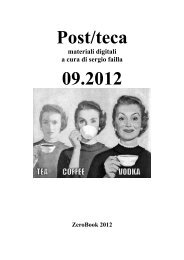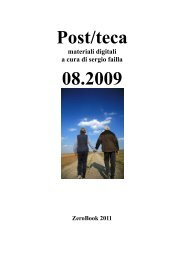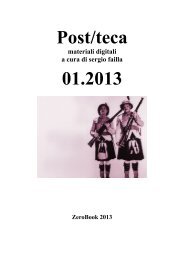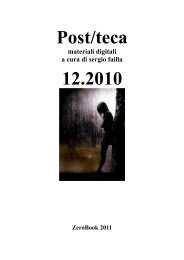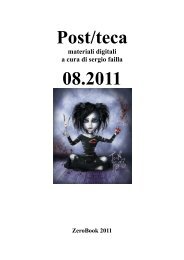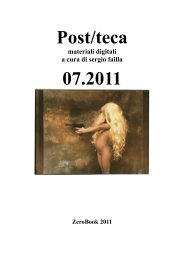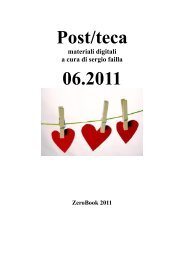postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
postteca201008 (PDF - 3.8 Mb) - Girodivite
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Post/teca<br />
fortezza dello Spielberg in Moravia). Nel 1830 viene graziato ed, espulso dai territori austriaci,<br />
rientra in Piemonte: di questa vicenda danno conto Le mie prigioni. Il Pellico si impiega come<br />
bibliotecario dei marchesi Barolo, rinuncia a qualsiasi attività pubblica e sostiene l’attività<br />
filantropica promossa – come nella Francia di Ozanam – dalla marchesa Giulia di Barolo Colbert.<br />
Seppe nondimeno contribuire ai libri dell’«identità italiana» non solo con il ritratto autobiografico,<br />
ma anche con un volumetto di letture: Dei doveri degli uomini: discorso ad un giovane, 1834, che<br />
ebbe una diffusione prodigiosa (nello stesso 1834 il libro venne pubblicato, presso distinti editori, a<br />
Torino, Milano, Bergamo, Cremona, Capolago, Venezia, Trieste, Padova, Parma, Bologna,<br />
Ancona, Firenze, Livorno, Napoli e, in italiano, a Lione e Parigi. Venne tradotto in svedese nel<br />
1836) e fu poi rilanciato, nell’Italia unita, da un’edizione prefata dal sacerdote, e poi beato,<br />
Giovanni Bosco. Nel 1853 volle rendergli visita Giuseppe Mazzini. Morì a Torino l’anno dopo, il 31<br />
gennaio 1854. Poeta degli spazi minimi, testimone tra i primi dell’universo concentrazionario – che<br />
avrà nel Novecento i suoi più marcati interpreti: Mandel’štam, Primo Levi, Varlam Šalamov,<br />
Aleksander Solzenicyn – Silvio Pellico ha, come questi, gli stessi compagni di coscienza e d’esilio:<br />
«Ben mi si permise ch’io avessi una Bibbia ed il Dante» (capitolo VI). Egli sa isolare, come negli<br />
stessi anni il Leopardi, e nel Novecento Calvino, il palpito creaturale e trasformarlo in simbolo<br />
universale. Il «bel ragno» o le formiche del capitolo XXVI de Le mie prigioni come la lucciola dei<br />
Ricordi d’infanzia e d’adolescenza del Leopardi («Intanto la lucciola era risorta ec. avrei voluto ec.<br />
ma quegli se n’accorse tornò – porca buzzarona – un’altra botta la fa cadere già debole com’era<br />
ed egli col piede ne fa una striscia lucida fra la polvere ec.»), il «geco» di Calvino rimangono<br />
emblemi assoluti, forme pure della vita al di là del male di esistere. Ma, soprattutto, Le mie prigioni,<br />
sono un lungo, sommesso, e insieme esigente, monologo di coscienza: «Il vivere libero è assai più<br />
bello del vivere in carcere; chi ne dubita? Eppure anche nelle miserie d’un carcere, quando ivi si<br />
pensa che Dio è presente, che le gioie del mondo sono fugaci, che il vero bene sta nella coscienza<br />
e non negli oggetti esteriori, puossi con piacere sentire la vita» (capitolo VII). Questa hebeliana<br />
simplicitas non manca tuttavia di lucide, e persin aguzze, allusioni; basterebbe ricordare l’episodio<br />
della "Maddalena" per osservare quanto il Pellico sottolinei la sua distanza dagli episodi<br />
manzoniani della Monaca di Monza, rifiutando i contatti e le facili complicità di una sottile parete<br />
(che avevano invece portato all’abnorme sviluppo di simile episodio nel Fermo e Lucia): «Mi<br />
passavano parimente sotto gli occhi molte donne arrestate. Da quella galleria s’andava, per un<br />
voltone, sopra un altro cortile, e là erano le carceri muliebri e l’ospedale delle sifilitiche. Un muro<br />
solo, ed assai sottile, mi dividea da una delle stanze delle donne. […] Se avessi voluto entrare in<br />
colloquio, avrei potuto. Me n’astenni» (capitolo XI). Per molti aspetti, questo libro è una "riduzione<br />
al minimo" delle Confessioni di Agostino e di quelle di Rousseau; ma questa attenuazione di tono è<br />
compensata da una affilata capacità di autoanalisi, che di rado capita di trovare anche nei grandi<br />
moralistes del Sei e del Settecento: «L’uomo infelice ed arrabbiato è tremendamente ingegnoso a<br />
calunniare i suoi simili e lo stesso Creatore. L’ira è più immorale, più scellerata che generalmente<br />
non si pensa. Siccome non si può ruggire dalla mattina alla sera, per settimane, e l’anima la più<br />
dominata dal furore ha di necessità i suoi intervalli di riposo, quegli intervalli sogliono risentirsi<br />
dell’immoralità che li ha preceduti. Allora sembra d’essere in pace, ma è una pace maligna,<br />
irreligiosa; un sorriso selvaggio, senza carità, senza dignità; un amore di disordine, d’ebbrezza, di<br />
scherno» (capitolo XXIV). La prigione non accentua soltanto il controllo di sé; essa suscita anzi –<br />
come nelle notti tassiane della prigionia di Sant’Anna – fantasmi e simulacri, descritti dal Pellico<br />
con la stessa febbrile impotenza di Torquato Tasso: «In quelle orrende notti, l’immaginazione mi<br />
s’esaltava talora in guisa che pareami, sebbene svegliato, or d’udir gemiti nel mio carcere, or d’udir<br />
risa soffocate. Dall’infanzia in poi, non era mai stato credulo a streghe e folletti, ed or quelle risa e<br />
259