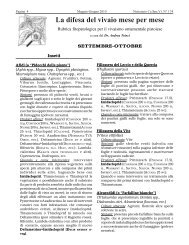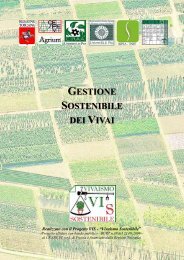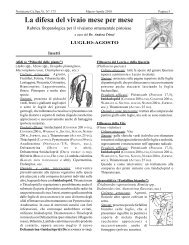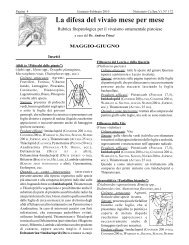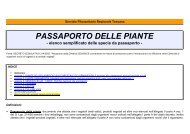Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FLOROVIVAISMO: L’ACQUA245Toscana), due aspetti sono sicuramente da sottolineare,perlomeno per la Toscana:1. la presenza di lavoratori giovani (meno di 40anni) <strong>nel</strong>le aziende florovivaistiche (<strong>nel</strong> 40%circa dei casi), che risulta doppia rispetto allamedia negli altri tipi di azienda agricola;2. il ricambio gene<strong>razionale</strong>; <strong>nel</strong> <strong>florovivaismo</strong> piùdi un quarto <strong>delle</strong> aziende ha un giovane chepuò potenzialmente rimpiazzare il titolare, dopoil suo ritiro (sempre per la Toscana, la media pertutte le aziende agricole è meno del 5%).Questi due indicatori suggeriscono l’attitudine<strong>delle</strong> aziende florovivaistiche all’innovazione ostacolata,però, dalle dimensioni contenute <strong>delle</strong>aziende che si ripercuotono negativamente sulleeconomie di scala, sugli ammortamenti e sui tempidi ritorno degli investimenti.Come ultimo aspetto, vale la pena sottolinearela consapevolezza dei florovivaisti del valore assolutodell’acqua, che in effetti è l’unico fattore diproduzione non surrogabile. Si dice, esagerandoun po’, che il successo di un’azienda florovivaisticadipende da “chi annaffia le piante”. Questo, però,è in evidente contrasto con il fatto che in moltissimicasi i titolari <strong>delle</strong> aziende non hanno che un’ideaapprossimativa (per usare un eufemismo!) deifabbisogni idrici <strong>delle</strong> proprie colture.Le coltureAnche se non mancano esempi di produzionilow-input (ad esempio, gli alberi di Natale e, tuttoconsiderato, anche le fronde recise), le colture florovivaisticheprevedono normalmente un ingenteimpiego d’energia (necessaria, ad esempio, per ilriscaldamento <strong>delle</strong> serre), di prodotti chimici disintesi (fertilizzanti, fitofarmaci, materiali plasticiecc.) e, ultima ma non per importanza, d’acqua.Le piante allevate nei vivai all’aperto o <strong>nel</strong>le serre,infatti, sono contraddistinte da un elevato ritmo dicrescita e sviluppo e necessitano, appunto per questo,di un abbondante rifornimento, oltre che dielementi nutritivi (in particolare, di azoto), diacqua, peraltro di buona qualità, considerando chele specie ornamentali sono <strong>nel</strong>la maggior parte deicasi poco tolleranti della salinità (vedi Capitolo 4).I fabbisogni idrici e minerali sono particolarmenteelevati <strong>nel</strong> caso <strong>delle</strong> colture in contenitore semprepiù diffuse anche <strong>nel</strong> vivaismo in pien’aria per tuttauna serie di vantaggi (disponibilità in qualsiasiperiodo dell’anno; trasporto e trapianto più facili;semplice soluzione al problema del terreno asportatocon la tradizionale zollatura ecc.).L’irrigazione è sicuramente meno importante<strong>nel</strong>le coltivazioni tradizionali a terra in pien’aria,<strong>nel</strong>le quali non di rado assume le caratteristiched’intervento di soccorso. È invece fondamentale<strong>nel</strong>le colture in contenitore e in serra. I volumi irriguierogati annualmente alle colture florovivaistichesono assai variabili, da meno di 1000 m 3 /hadei vivai di pieno campo fino ai 12-15 mila e piùm 3 /ha <strong>nel</strong>le colture in vaso; durante la stagioneirrigua la quantità d’acqua distribuita giornalmentead un vivaio è compresa fra 10 e 20 mm (100-200 m 3 /ha).Solo <strong>nel</strong>l’area di Pistoia ci sono oltre 5000 ettaridi vivai, circa 1000 dei quali attrezzati per la colturain contenitore, anche di alberi di grandi dimensioni.In quest’area, si stima (secondo alcuni perdifetto) un consumo annuale d’acqua irrigua dioltre 12 milioni di m 3 , fornita per oltre il 90% dapozzi e distribuita per il 75-80% alla vasetteria(ARPAT, 2001). D’altra parte, occorre ricordare che,<strong>nel</strong>la stessa area l’evapotraspirazione potenziale(ETP) supera i 1100 mm/anno (11,000 mila m 3 /ha), concentrati per circa l’80% <strong>nel</strong>la stagione irrigua(maggio-ottobre) (fonte: Ce.Spe.Vi.; tab. 1).Non di rado, comunque, le quantità d’acquadistribuite alle colture florovivaistiche sono superiorialle effettive necessità fisiologiche <strong>delle</strong> piante,che approssimativamente possiamo far coinciderecon l’ETP, considerando, cioè, un valore di1,0 per il coefficiente colturale (Kc, vedi Capitoli4, 12 e 13). A titolo di esempio, dal bilancio idri-Tab. 1 - Valori mensili <strong>delle</strong> pioggee dell’evapotraspirazione potenziale<strong>nel</strong>l’area di Pistoia*Mese Pioggia (mm) ETP (mm)Gennaio 90,2 28,0Febbraio 79,4 31,0Marzo 64,9 71,4Aprile 115,8 89,2Maggio 72,4 153,8Giugno 57,5 172,0Luglio 30,1 208,5Agosto 42,5 192,9Settembre 103,7 102,7Ottobre 173,9 44,6Novembre 184,0 24,4Dicembre 138,6 21,8Totale (maggio-ottobre) 480,1 874,5Totale (gennaio-dicembre) 1153,0 1140,3* I dati sono le medie dei valori registrati dalla centralinameteorologica del Ce.Spe.Vi. di Pistoia <strong>nel</strong> periodo 1990-2003.