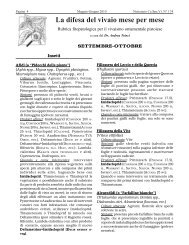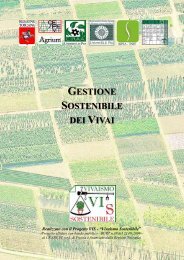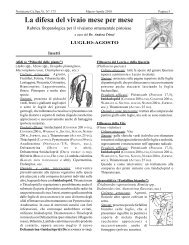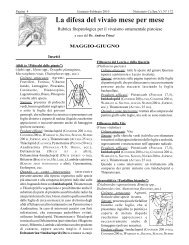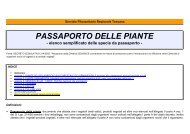Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FLOROVIVAISMO: L’ACQUA61La determinazione della porosità totale puòessere stimata in base al PSA del materiale, secondola seguente formula:P = 98 – (36,2 • PSA) Eq. 5L’equazione precedente consente una buonastima della P <strong>nel</strong> caso di substrati organici, mentretende a sovrastimarla <strong>nel</strong> caso di substrati minerali.P è costituita dalla somma di due classi didimensioni di pori: i micropori e i macropori. Permicropori s’intendono i pori di dimensioni inferioriai 30-50 µm (micron). Questa suddivisione risultautile nei confronti <strong>delle</strong> proprietà idraulichedel materiale, in quanto solo la microporosità èresponsabile della ritenzione ‘stabile’ dell’acquadopo drenaggio libero, chiamando in causa i fenomenidi capillarità. La macroporosità è detta ancheporosità libera, in quanto i macropori sono normalmenteoccupati dall’aria.Un’altra suddivisione della porosità totale coinvolgela porosità ‘aperta’ e per contro quella ‘chiusa’,a seconda che i pori comunichino o meno conl’ambiente esterno. I pori chiusi sono interpretabilicome bolle d’aria racchiuse entro la fase solida eperciò di nessuna influenza sulle proprietà idraulichedel materiale. Ad esempio, la pomice possiedeuna notevole porosità chiusa, mentre il tufo possiedeun’elevata porosità aperta. Si giunge così alladefinizione della porosità interparticellare, costituitadagli spazi fra le particelle, e della porositàintraparticellare, costituita dagli spazi presentiall’interno dei granuli o <strong>delle</strong> fibre dei materialiesaminati.Rispetto al terreno agrario (talvolta, aggiuntoin piccola quantità nei miscugli per vasetteria), isubstrati utilizzati per il <strong>florovivaismo</strong> hanno un’elevataporosità (fino al 95% e più, come <strong>nel</strong> casodella lana di roccia, e in genere non inferiore al 70-75%) e anche una diversa ripartizione tra fase solida,liquida e gassosa (tab. 2).Tab. 2 - Confronto fra la ripartizione<strong>delle</strong> tre fasi presenti in un terreno agrarioe in un substrato ideale per colture in vaso% Volume Terreno SubstratoFase solida 50 10Fase liquida 25 - 30 60Fase gassosa 20 - 25 30I rapporti aria-acquaLa relazione fra aria e ritenzione idrica <strong>nel</strong> substratodipende da cinque fattori principali:1. il/i materiale/i utilizzato/i;2. le caratteristiche geometriche del contenitore(volume, altezza e forma);3. le procedure di preparazione del substrato e diinvasatura;4. la pratica irrigua;5. la coltivazione stessa.La curva di ritenzione idricaIl potenziale idrico (Ψ w) è l’energia potenzialedell’acqua per unità di massa. Se il contenuto idricoci dice quanta acqua è contenuta da un certomateriale, il potenziale idrico ci dice quanto questaè disponibile; in altre parole, Ψ wesprime il lavoronecessario per estrarre una quantità unitaria d’acquaritenuta dal sistema. Il potenziale idrico Ψ wènegativo in quanto assume valori negativi rispettoa quello dell’acqua libera e pura (Ψ w= 0), presacome sistema di riferimento.Nel caso del terreno e di un substrato, Ψ wdeterminala suzione necessaria per estrarre l’acquadal sistema, cioè la forza necessaria alla radice perassorbire acqua dal substrato. Più è asciutto il substrato,maggiore è la forza necessaria per estrarreacqua.Il potenziale idrico comprende tre diversi componenti:1) potenziale matriciale (Ψ m), legato allacapillarità, per pori di diametro inferiore a 30-50 µm(micron); 2) potenziale gravitazionale (Ψ g), legatoalla forza di gravità; 3) potenziale osmotico (Ψ o),determinato dal contenuto <strong>delle</strong> sostanze disciolte.La relazione tra il potenziale idrico e le sue componentiè descritta dalla seguente equazione:Ψ w= Ψ m+ Ψ g+ Ψ oEq. 6Per i valori di concentrazione salina tipici <strong>delle</strong>acque di irrigazione e fertirrigazione, Ψ 0può essereconsiderato trascurabile, pertanto l’Eq. 6 si riduce:Ψ w= Ψ m+ Ψ gEq. 7La curva di ritenzione idrica esprime la relazioneesistente tra il potenziale idrico <strong>nel</strong> substrato(detto anche tensione o potenziale matriciale, daltermine ‘matrice’ che sta a indicare il materialeporoso dove l’acqua si accumula) e il contenuto diliquido stesso presente <strong>nel</strong> mezzo poroso, in genereespresso in rapporto percentuale volumetrico.Studi di natura fisiologica hanno dimostratoche, fino a -25 ÷ -30 kPa di tensione, le piante nonsono influenzate dalla tensione con cui l’acqua è