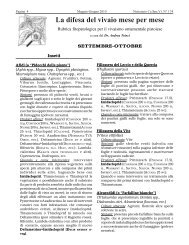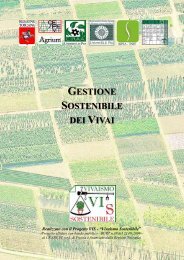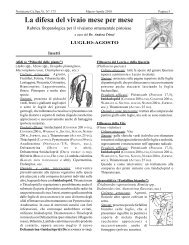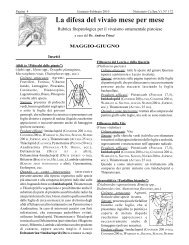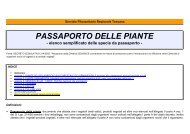Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FLOROVIVAISMO: L’ACQUA632) la capacità per l’aria (CA) alla tensione di -1kPa, calcolata come differenza tra la porosità eil contenuto idrico a -1 kPa;4) la differenza tra il contenuto idrico a -1 kPa equello a -5 kPa, detta acqua facilmente disponibile(AFD);3) la differenza tra il contenuto idrico a -1 kPa equello a -10 kPa, detta acqua disponibile (AD);5) la differenza tra il contenuto idrico a -5 kPa equello a -10 kPa, detta acqua di riserva (AR) otampone idrico.Il tampone idrico indica la capacità del substratodi attenuare le variazioni di tensione (diminuzioneal di sotto di -5 kPa) man mano che si asciugae di consentire, conseguentemente, un certoadattamento fisiologico della pianta alla carenzaidrica. Uno scarso potere tampone indica un maggiorrischio di stress idrico per la pianta e suggerisce,quindi, una maggior cura <strong>nel</strong>l’irrigazione.Quelli ora descritti sono i parametri normalmenteutilizzati <strong>nel</strong>la caratterizzazione dei substrati.Alcuni autori (ad esempio, Lieth, 1996) usanoanche un altro indice, l’acqua non disponibile(AND), definito come il contenuto idrico volumetricoa -30 kPa. AND può superare anche il 20-25% nei substrati a base di torba ed è invece bassissimo(< 3%) <strong>nel</strong>le lane minerali.I valori ottimali per un substrato di coltivazionesono i seguenti:P = 60-85%; CA = 10-30%;AD = 45-65%; AND = 25-35%.Ogni materiale è caratterizzato da una propriacurva di ritenzione idrica: i dati relativi ad alcunimateriali e miscugli largamente impiegati <strong>nel</strong> <strong>florovivaismo</strong>sono riportati in tab. 3. Per la torba, ilsubstrato per eccellenza in virtù dell’elevata porosità(oltre che della stabilità, del pH acido ma facilmentemodificabile, e della sanità) esiste una strettarelazione tra PSA e proprietà idrauliche. In unlavoro con diversi tipi di torba, infatti, Verdonck(1995) ha osservato che all’aumentare di PSA (conle torbe di sfagno, bionde e brune in ordine crescenteper questo parametro), P e CA tendono adiminuire e aumenta, quindi, la ritenzione idrica.In laboratorio, la curva di ritenzione idrica èdeterminata solitamente come ‘curva di drenaggio’,cioè a partire dallo stato di saturazione equilibrandovia via il campione a tensioni minori(maggiori in valore assoluto). Se invertiamo il processoa una qualsiasi tensione e umidifichiamo dinuovo il campione, otterremo <strong>delle</strong> curve (’di umidificazione’)diverse dalle precedenti e situate più‘in basso’ su un piano ‘tensione-umidità percentualevolumetrica’, ovvero con minor contenutoidrico. Si tratta di un fenomeno d’istèresi dovutoprincipalmente alla presenza d’aria intrappolata ealla momentanea idrorepellenza di alcune superficidi materiali quali quelli torbosi. Risulta alloraimportante determinare le curve principali di drenaggioe di umidificazione poiché, secondo la tecnicairrigua utilizzata (irrigazione a goccia oppuresubirrigazione), la determinazione dei parametrilegati alla curva di ritenzione idrica deve essereeffettuata su una o sull’altra curva, in relazioneappunto al meccanismo di assorbimento dell’acqua(Bibbiani, 1996).Relazioni idriche del SSCCome per il terreno, anche per il SSC si puòparlare di ‘capacità di campo’ o, meglio ‘capacità dicontenitore’ (CC). CC rappresenta il massimocontenuto di acqua per un substrato posto in unparticolare contenitore, cioè la quantità d’acquache il sistema trattiene dopo un’irrigazione fino asaturazione e successivo drenaggio (sgocciolamento).L’argomento merita una trattazione più esaustiva.In un contenitore, dopo irrigazione fino a saturazionee successivo drenaggio, quando l’acquacessa di drenare significa che si è raggiunto unequilibrio diΨ wcon Ψ w= 0, perché sul fondo permaneuno strato d’acqua libera (a tensione nulla,assumendo come detto Ψ w= 0).Quindi, seΨ w= 0, Ψ m= -Ψ gsul fondo del vaso Ψ m= -Ψ g= 0,ma a una altezza ‘H’, Ψ m= -Ψ g= -H (vedi fig. 2).Il contenuto idrico all’altezza H, cioè al potenzialematriciale (o tensione) pari a -H, è determinatodalla curva di ritenzione idrica caratteristicadel substrato contenuto dal vaso. Ciò significa chea ogni strato di substrato situato ad altezza crescentedal fondo corrisponde un contenuto diumidità via via decrescente (quindi, un contenutod’aria crescente) e pari al valore da leggersi sullacurva di ritenzione per la altezza (tensione) prescelta(fig. 3).A seguito di questo fatto, per calcolare la capacitàidrica del contenitore, basta pensare di sezionareil contenitore in ‘fettine’ orizzontali di 2 cmcirca di altezza, trovare il volume di ciascuna ‘fetta’(tronco di cono, di piramide o di prisma a secondache il contenitore sia conico, a sezione circolareoppure piramidale, o prismatico) e moltiplicarloper il contenuto volumetrico di acqua relativo allaaltezza del suo baricentro dal fondo del contenitore.Nell’esempio di fig. 3, i valori dei volumi <strong>delle</strong>