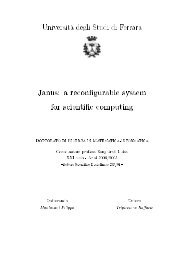- Page 1 and 2: Università degli Studi di Ferrara
- Page 3 and 4: RINGRAZIAMENTI Nel corso dei tre an
- Page 5 and 6: INDICE INTRODUZIONE……………
- Page 7 and 8: CAP. 7 RIPARO TAGLIENTE…………
- Page 9 and 10: Capitolo 1 MATERIALI E METODI
- Page 11 and 12: Cap. 1 Materiali e metodi materiale
- Page 13 and 14: Cap. 1 Materiali e metodi Débitag
- Page 15 and 16: Cap. 1 Materiali e metodi usate com
- Page 17 and 18: Cap. 1 Materiali e metodi Fig. 1.1
- Page 19: 2.1 DEFINIZIONE DI ERRORE DI SCHEGG
- Page 23 and 24: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 25 and 26: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 27 and 28: Fig.2.3 : bending fracture (da Baen
- Page 29 and 30: Fig.2.6: scheggia riflessa (a), inf
- Page 31 and 32: 2.2 PROTOCOLLO SPERIMENTALE Cap. 2
- Page 33 and 34: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 35 and 36: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 37 and 38: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 39 and 40: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 41 and 42: SCHEDA N.1 Evaluation du savoir fai
- Page 43 and 44: Sperimentazione N° Qualità: Morfo
- Page 45 and 46: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 47 and 48: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 49 and 50: nucleo sfruttato schegge funzionali
- Page 51 and 52: Fig. 2.16: Incidente di Siret causa
- Page 53 and 54: Cap. 2 Definizione di errore e sper
- Page 55 and 56: 2.4.3 LE DUE COLLEZIONI SPERIMENTAL
- Page 57 and 58: fratture nette bulbi diedri Siret f
- Page 59 and 60: 3.1 IL SITO E IL CONTESTO STRATIGRA
- Page 61 and 62: Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 63 and 64: Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 65 and 66: Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 67 and 68: Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 69 and 70: Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 71 and 72:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 73 and 74:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 75 and 76:
Distacco calotta Cap. 3 Cà Belvede
- Page 77 and 78:
3.4.4 L’ANALISI FUNZIONALE Cap. 3
- Page 79 and 80:
a Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Pog
- Page 81 and 82:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 83 and 84:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 85 and 86:
2 cm Fig.3.23: 102C 56/8 n.9; incid
- Page 87 and 88:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 89 and 90:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 91 and 92:
Cap. 3 Cà Belvedere di Monte Poggi
- Page 93 and 94:
4.1 IL SITO E IL CONTESTO STRATIGRA
- Page 95 and 96:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 conservaz
- Page 97 and 98:
Fig. 4.3: Guado San Nicola; l’are
- Page 99 and 100:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 anche da
- Page 101 and 102:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 Alcune de
- Page 103 and 104:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 percussio
- Page 105 and 106:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 Nell’in
- Page 107 and 108:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 Fig. 4.12
- Page 109 and 110:
Fig.4.17: USB*C, Q Q12 n.119; scheg
- Page 111 and 112:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 Fig. 4.22
- Page 113 and 114:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 (vedi fig
- Page 115 and 116:
37 19 49 doppio bulbo Cap. 4 Guado
- Page 117 and 118:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 rinvenute
- Page 119 and 120:
Fig. 4.37: USC, Q M15 n.5: punta di
- Page 121 and 122:
Cap. 4 Guado San Nicola 1 Concluden
- Page 123 and 124:
5.1 IL SITO E IL CONTESTO STRATIGRA
- Page 125 and 126:
Cap. 5 Payre 117 Fig. 5.2: il riemp
- Page 127 and 128:
Cap. 5 Payre 119 Fig. 5.3: planimet
- Page 129 and 130:
Cap. 5 Payre 121 I carnivori sono r
- Page 131 and 132:
Cap. 5 Payre 123 Fig. 5.7: framment
- Page 133 and 134:
Cap. 5 Payre 125 variazioni stratig
- Page 135 and 136:
Fig. 5.10: alcuni dei denti umani r
- Page 137 and 138:
5.4 L’INDUSTRIA LITICA: GLI STUDI
- Page 139 and 140:
5.4.2 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
- Page 141 and 142:
Cap. 5 Payre 133 Fig. 5.14: materia
- Page 143 and 144:
5.4.3 L’ANALISI FUNZIONALE Cap. 5
- Page 145 and 146:
Cap. 5 Payre 137 Fig.5.18: diverse
- Page 147 and 148:
Cap. 5 Payre 139 dunque qui essere
- Page 149 and 150:
Cap. 5 Payre 141 Fig.5.22: nucleo D
- Page 151 and 152:
Fig. 5.27: D, O8 n.92. Frammento di
- Page 153 and 154:
Cap. 5 Payre 145 esaurimento, sia n
- Page 155 and 156:
Cap. 5 Payre 147 ciò significa che
- Page 157 and 158:
Capitolo 6 ABRI DU MARAS
- Page 159 and 160:
Cap. 6 Abri du Maras corrispondente
- Page 161 and 162:
Cap. 6 Abri du Maras Strato O: str
- Page 163 and 164:
Cap. 6 Abri du Maras Sono state eff
- Page 165 and 166:
Cap. 6 Abri du Maras autunnale del
- Page 167 and 168:
Cap. 6 Abri du Maras Livello 6: li
- Page 169 and 170:
Cap. 6 Abri du Maras Livello 7: (7
- Page 171 and 172:
Cap. 6 Abri du Maras metà di conce
- Page 173 and 174:
Cap. 6 Abri du Maras Fig. 6.11 : in
- Page 175 and 176:
Cap. 6 Abri du Maras dalla presenza
- Page 177 and 178:
Cap. 6 Abri du Maras Le campagne di
- Page 179 and 180:
Cap. 6 Abri du Maras Le schegge pre
- Page 181 and 182:
Cap. 6 Abri du Maras Fig.6.20: HS,
- Page 183 and 184:
Fig. 6.25: USI-J, E13 n.1: framment
- Page 185 and 186:
Cap. 6 Abri du Maras Fig. 6.28: C3,
- Page 187 and 188:
Cap. 6 Abri du Maras Fig. 6.30: alc
- Page 189 and 190:
7.1 IL SITO E IL CONTESTO STRATIGRA
- Page 191 and 192:
Cap. 7 Riparo Tagliente La stratigr
- Page 193 and 194:
al., 1982): Cap. 7 Riparo Tagliente
- Page 195 and 196:
Cap. 7 Riparo Tagliente Dal taglio
- Page 197 and 198:
Archeozoologia Cap. 7 Riparo Taglie
- Page 199 and 200:
Cap. 7 Riparo Tagliente Fig. 7.5: R
- Page 201 and 202:
Cap. 7 Riparo Tagliente Queste popo
- Page 203 and 204:
Cap. 7 Riparo Tagliente In conclusi
- Page 205 and 206:
Cap. 7 Riparo Tagliente alle fasi f
- Page 207 and 208:
Cap. 7 Riparo Tagliente superficie
- Page 209 and 210:
Cap. 7 Riparo Tagliente Si tratta d
- Page 211 and 212:
Cap. 7 Riparo Tagliente della forma
- Page 213 and 214:
Cap. 7 Riparo Tagliente I reperti l
- Page 215 and 216:
Cap. 7 Riparo Tagliente Fig. 7.16:
- Page 217 and 218:
Cap. 7 Riparo Tagliente Fig. 7.21:
- Page 219 and 220:
Capitolo 8 CONSIDERAZIONI FINALI
- Page 221 and 222:
8.2 GLI ERRORI DI SCHEGGIATURA INDI
- Page 223 and 224:
350 300 250 200 150 100 50 0 36 43
- Page 225 and 226:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 21
- Page 227 and 228:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 21
- Page 229 and 230:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 22
- Page 231 and 232:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 22
- Page 233 and 234:
8.4 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RI
- Page 235 and 236:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 22
- Page 237 and 238:
Cap. 8 Considerazioni conclusive 22
- Page 239 and 240:
BIBLIOGRAFIA Bibliografia Aimar A.,
- Page 241 and 242:
Bibliografia Bamforth D., Finlay N.
- Page 243 and 244:
Bibliografia (Eds.), La terra degli
- Page 245 and 246:
Bibliografia Demars P.-Y., 1998. Ci
- Page 247 and 248:
Bibliografia Piperno M. & Scichilon
- Page 249 and 250:
Bibliografia Lowe J., Walker M., 19
- Page 251 and 252:
Bibliografia Moncel M.-H. 2005. Bau
- Page 253 and 254:
Bibliografia di Monte Poggiolo: str
- Page 255 and 256:
Bibliografia Thun Hohenstein U., 20
- Page 257 and 258:
INDICE DELLE FIGURE Indice delle ta
- Page 259 and 260:
Indice delle tabelle 251 transizion
- Page 261 and 262:
Indice delle tabelle 253 Fig. 4.7:
- Page 263 and 264:
Fig. 5.2: il riempimento di Payre.
- Page 265 and 266:
Indice delle tabelle 257 Fig. 6.1:
- Page 267 and 268:
Fig. 7.2: Progno di Valpantena, nel
- Page 269 and 270:
INDICE DELLE TABELLE Indice delle t
- Page 271 and 272:
ESERCIZIO 1 Appendice 1. La collezi
- Page 273 and 274:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 275 and 276:
ESERCIZIO 2 Appendice 1. La collezi
- Page 277 and 278:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 279 and 280:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 281 and 282:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 283 and 284:
ESERCIZIO 3 Appendice 1. La collezi
- Page 285 and 286:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 287 and 288:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 289 and 290:
Appendice 1. La collezione sperimen
- Page 291 and 292:
Sperimentazione N°1 Qualità: buon
- Page 293 and 294:
Sperimentazione N°3 Materia prima
- Page 295 and 296:
Appendice 2. La collezione sperimen
- Page 297 and 298:
Sperimentazione N°6 Qualità: buon
- Page 299 and 300:
Sperimentazione N°8 Qualità: buon
- Page 301 and 302:
Sperimentazione N° 10 Qualità: bu
- Page 303 and 304:
Il nucleo finale. Appendice 2. La c
- Page 305 and 306:
Sperimentazione N°12 Qualità: buo
- Page 307 and 308:
Sperimentazione N°14 Qualità: buo
- Page 309 and 310:
Il nucleo rimontato visto secondo i
- Page 311 and 312:
Sperimentazione N°16 Qualità: ott
- Page 313 and 314:
Sperimentazione N°18 Qualità: buo
- Page 315 and 316:
Sperimentazione N°20 Qualità: ott
- Page 317 and 318:
Sperimentazione N°21 Qualità: mol
- Page 319 and 320:
Sperimentazione N°23 Qualità: mol
- Page 321 and 322:
Sperimentazione N°25 Qualità: buo
- Page 323 and 324:
Sperimentazione N°26 Qualità: buo
- Page 325 and 326:
Sperimentazione N°28 Qualità: mol
- Page 327 and 328:
Il nucleo rimontato visto dalla sup
- Page 329 and 330:
Rimontaggio del nucleo visto dal pi
- Page 331 and 332:
Sperimentazione N°31 Materia prima
- Page 333 and 334:
Sperimentazione N°33 Qualità: mol
- Page 335 and 336:
Sperimentazione N°34 Qualità: mol
- Page 337 and 338:
Sperimentazione N°36 Qualità: buo
- Page 339 and 340:
Appendice 2. La collezione sperimen
- Page 341 and 342:
Il nucleo rimontato visto dalla sup
- Page 343 and 344:
Sperimentazione N°39 Qualità: mol
- Page 345 and 346:
Il nucleo rimontato. Il bifacciale