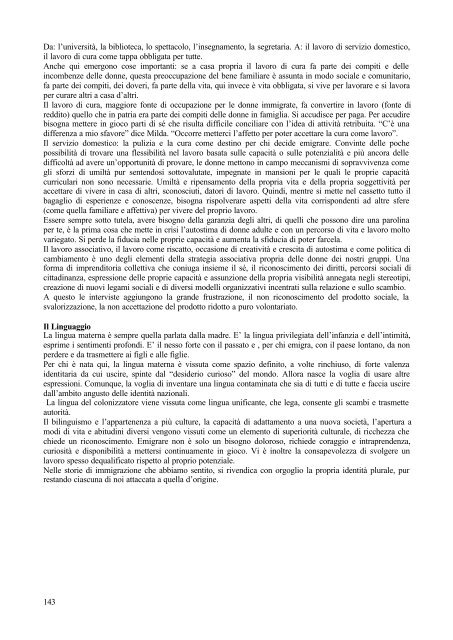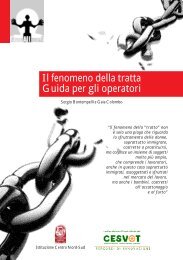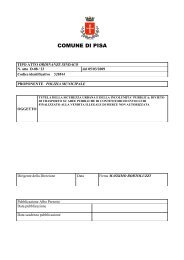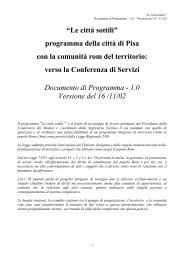Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Da: l’università, la biblioteca, lo spettacolo, l’insegnamento, la segretaria. A: il lavoro di servizio domestico,<br />
il lavoro di cura come tappa obbligata per tutte.<br />
Anche qui emergono cose importanti: se a casa propria il lavoro di cura fa parte dei compiti e <strong>del</strong>le<br />
incombenze <strong>del</strong>le donne, questa preoccupazione <strong>del</strong> bene familiare è assunta in modo sociale e comunitario,<br />
fa parte dei compiti, dei doveri, fa parte <strong>del</strong>la vita, qui invece è vita obbligata, si vive per lavorare e si lavora<br />
per curare altri a casa d’altri.<br />
Il lavoro di cura, maggiore fonte di occupazione per le donne immigrate, fa convertire in lavoro (fonte di<br />
reddito) quello che in patria era parte dei compiti <strong>del</strong>le donne in famiglia. Si accudisce per paga. Per accudire<br />
bisogna mettere in gioco parti di sé che risulta difficile conciliare con l’idea di attività retribuita. “C’è una<br />
differenza a mio sfavore” dice Milda. “Occorre metterci l’affetto per poter accettare la cura come lavoro”.<br />
Il servizio domestico: la pulizia e la cura come destino per chi decide emigrare. Convinte <strong>del</strong>le poche<br />
possibilità di trovare una flessibilità nel lavoro basata sulle capacità o sulle potenzialità e più ancora <strong>del</strong>le<br />
difficoltà ad avere un’opportunità di provare, le donne mettono in campo meccanismi di sopravvivenza come<br />
gli sforzi di umiltà pur sentendosi sottovalutate, impegnate in mansioni per le quali le proprie capacità<br />
curriculari non sono necessarie. Umiltà e ripensamento <strong>del</strong>la propria vita e <strong>del</strong>la propria soggettività per<br />
accettare di vivere in casa di altri, sconosciuti, datori di lavoro. Quindi, mentre si mette nel cassetto tutto il<br />
bagaglio di esperienze e conoscenze, bisogna rispolverare aspetti <strong>del</strong>la vita corrispondenti ad altre sfere<br />
(come quella familiare e affettiva) per vivere <strong>del</strong> proprio lavoro.<br />
Essere sempre sotto tutela, avere bisogno <strong>del</strong>la garanzia degli altri, di quelli che possono dire una parolina<br />
per te, è la prima cosa che mette in crisi l’autostima di donne adulte e con un percorso di vita e lavoro molto<br />
variegato. Si perde la fiducia nelle proprie capacità e aumenta la sfiducia di poter farcela.<br />
Il lavoro associativo, il lavoro come riscatto, occasione di creatività e crescita di autostima e come politica di<br />
cambiamento è uno degli elementi <strong>del</strong>la strategia associativa propria <strong>del</strong>le donne dei nostri gruppi. Una<br />
forma di imprenditoria collettiva che coniuga insieme il sé, il riconoscimento dei diritti, percorsi sociali di<br />
cittadinanza, espressione <strong>del</strong>le proprie capacità e assunzione <strong>del</strong>la propria visibilità annegata negli stereotipi,<br />
creazione di nuovi legami sociali e di diversi mo<strong>del</strong>li organizzativi incentrati sulla relazione e sullo scambio.<br />
A questo le interviste aggiungono la grande frustrazione, il non riconoscimento <strong>del</strong> prodotto sociale, la<br />
svalorizzazione, la non accettazione <strong>del</strong> prodotto ridotto a puro volontariato.<br />
Il Linguaggio<br />
La lingua materna è sempre quella parlata dalla madre. E’ la lingua privilegiata <strong>del</strong>l’infanzia e <strong>del</strong>l’intimità,<br />
esprime i sentimenti profondi. E’ il nesso forte con il passato e , per chi emigra, con il paese lontano, da non<br />
perdere e da trasmettere ai figli e alle figlie.<br />
Per chi è nata qui, la lingua materna è vissuta come spazio definito, a volte rinchiuso, di forte valenza<br />
identitaria da cui uscire, spinte dal “desiderio curioso” <strong>del</strong> mondo. Allora nasce la voglia di usare altre<br />
espressioni. Comunque, la voglia di inventare una lingua contaminata che sia di tutti e di tutte e faccia uscire<br />
dall’ambito angusto <strong>del</strong>le identità nazionali.<br />
La lingua <strong>del</strong> colonizzatore viene vissuta come lingua unificante, che lega, consente gli scambi e trasmette<br />
autorità.<br />
Il bilinguismo e l’appartenenza a più culture, la capacità di adattamento a una nuova società, l’apertura a<br />
modi di vita e abitudini diversi vengono vissuti come un elemento di superiorità culturale, di ricchezza che<br />
chiede un riconoscimento. Emigrare non è solo un bisogno doloroso, richiede coraggio e intraprendenza,<br />
curiosità e disponibilità a mettersi continuamente in gioco. Vi è inoltre la consapevolezza di svolgere un<br />
lavoro spesso dequalificato rispetto al proprio potenziale.<br />
Nelle storie di immigrazione che abbiamo sentito, si rivendica con orgoglio la propria identità plurale, pur<br />
restando ciascuna di noi attaccata a quella d’origine.<br />
143