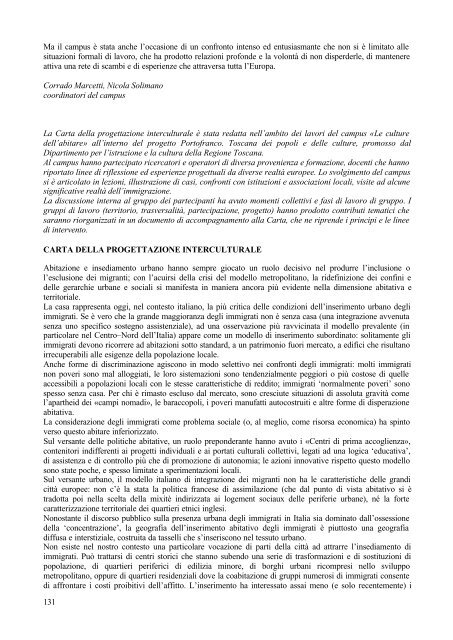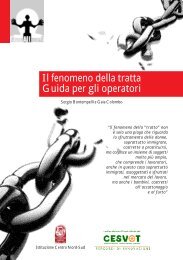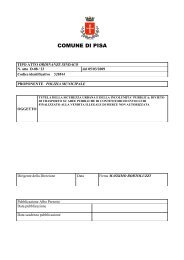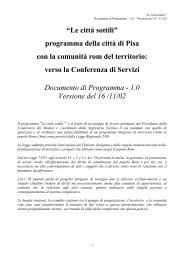Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ma il campus è stata anche l’occasione di un confronto intenso ed entusiasmante che non si è limitato alle<br />
situazioni formali di lavoro, che ha prodotto relazioni profonde e la volontà di non disperderle, di mantenere<br />
attiva una rete di scambi e di esperienze che attraversa tutta l’Europa.<br />
Corrado Marcetti, Nicola Solimano<br />
coordinatori <strong>del</strong> campus<br />
La Carta <strong>del</strong>la progettazione interculturale è stata redatta nell’ambito dei lavori <strong>del</strong> campus «Le culture<br />
<strong>del</strong>l’abitare» all’interno <strong>del</strong> <strong>progetto</strong> <strong>Porto</strong>franco. <strong>Toscana</strong> dei popoli e <strong>del</strong>le culture, promosso dal<br />
Dipartimento per l’istruzione e la cultura <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Toscana</strong>.<br />
Al campus hanno partecipato ricercatori e operatori di diversa provenienza e formazione, docenti che hanno<br />
riportato linee di riflessione ed esperienze progettuali da diverse realtà europee. Lo svolgimento <strong>del</strong> campus<br />
si è articolato in lezioni, illustrazione di casi, confronti con istituzioni e associazioni locali, visite ad alcune<br />
significative realtà <strong>del</strong>l’immigrazione.<br />
La discussione interna al gruppo dei partecipanti ha avuto momenti collettivi e fasi di lavoro di gruppo. I<br />
gruppi di lavoro (territorio, trasversalità, partecipazione, <strong>progetto</strong>) hanno prodotto contributi tematici che<br />
saranno riorganizzati in un documento di accompagnamento alla Carta, che ne riprende i principi e le linee<br />
di intervento.<br />
CARTA DELLA PROGETTAZIONE INTERCULTURALE<br />
Abitazione e insediamento urbano hanno sempre giocato un ruolo decisivo nel produrre l’inclusione o<br />
l’esclusione dei migranti; con l’acuirsi <strong>del</strong>la crisi <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo metropolitano, la ridefinizione dei confini e<br />
<strong>del</strong>le gerarchie urbane e sociali si manifesta in maniera ancora più evidente nella dimensione abitativa e<br />
territoriale.<br />
La casa rappresenta oggi, nel contesto italiano, la più critica <strong>del</strong>le condizioni <strong>del</strong>l’inserimento urbano degli<br />
immigrati. Se è vero che la grande maggioranza degli immigrati non è senza casa (una integrazione avvenuta<br />
senza uno specifico sostegno assistenziale), ad una osservazione più ravvicinata il mo<strong>del</strong>lo prevalente (in<br />
particolare nel Centro–Nord <strong>del</strong>l’Italia) appare come un mo<strong>del</strong>lo di inserimento subordinato: solitamente gli<br />
immigrati devono ricorrere ad abitazioni sotto standard, a un patrimonio fuori mercato, a edifici che risultano<br />
irrecuperabili alle esigenze <strong>del</strong>la popolazione locale.<br />
Anche forme di discriminazione agiscono in modo selettivo nei confronti degli immigrati: molti immigrati<br />
non poveri sono mal alloggiati, le loro sistemazioni sono tendenzialmente peggiori o più costose di quelle<br />
accessibili a popolazioni locali con le stesse caratteristiche di reddito; immigrati ‘normalmente poveri’ sono<br />
spesso senza casa. Per chi è rimasto escluso dal mercato, sono cresciute situazioni di assoluta gravità come<br />
l’apartheid dei «campi nomadi», le baraccopoli, i poveri manufatti autocostruiti e altre forme di disperazione<br />
abitativa.<br />
La considerazione degli immigrati come problema sociale (o, al meglio, come risorsa economica) ha spinto<br />
verso questo abitare inferiorizzato.<br />
Sul versante <strong>del</strong>le politiche abitative, un ruolo preponderante hanno avuto i «Centri di prima accoglienza»,<br />
contenitori indifferenti ai progetti individuali e ai portati culturali collettivi, legati ad una logica ‘educativa’,<br />
di assistenza e di controllo più che di promozione di autonomia; le azioni innovative rispetto questo mo<strong>del</strong>lo<br />
sono state poche, e spesso limitate a sperimentazioni locali.<br />
Sul versante urbano, il mo<strong>del</strong>lo italiano di integrazione dei migranti non ha le caratteristiche <strong>del</strong>le grandi<br />
città europee: non c’è la stata la politica francese di assimilazione (che dal punto di vista abitativo si è<br />
tradotta poi nella scelta <strong>del</strong>la mixitè indirizzata ai logement sociaux <strong>del</strong>le periferie urbane), né la forte<br />
caratterizzazione territoriale dei quartieri etnici inglesi.<br />
Nonostante il discorso pubblico sulla presenza urbana degli immigrati in Italia sia dominato dall’ossessione<br />
<strong>del</strong>la ‘concentrazione’, la geografia <strong>del</strong>l’inserimento abitativo degli immigrati è piuttosto una geografia<br />
diffusa e interstiziale, costruita da tasselli che s’inseriscono nel tessuto urbano.<br />
Non esiste nel nostro contesto una particolare vocazione di parti <strong>del</strong>la città ad attrarre l’insediamento di<br />
immigrati. Può trattarsi di centri storici che stanno subendo una serie di trasformazioni e di sostituzioni di<br />
popolazione, di quartieri periferici di edilizia minore, di borghi urbani ricompresi nello sviluppo<br />
metropolitano, oppure di quartieri residenziali dove la coabitazione di gruppi numerosi di immigrati consente<br />
di affrontare i costi proibitivi <strong>del</strong>l’affitto. L’inserimento ha interessato assai meno (e solo recentemente) i<br />
131