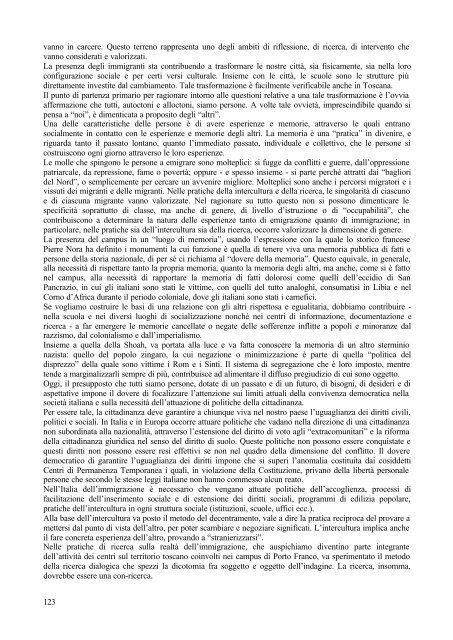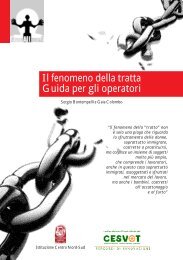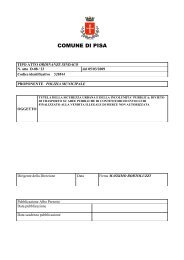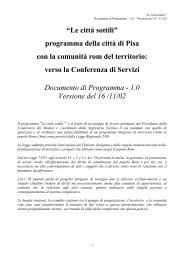Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
vanno in carcere. Questo terreno rappresenta uno degli ambiti di riflessione, di ricerca, di intervento che<br />
vanno considerati e valorizzati.<br />
La presenza degli immigranti sta contribuendo a trasformare le nostre città, sia fisicamente, sia nella loro<br />
configurazione sociale e per certi versi culturale. Insieme con le città, le scuole sono le strutture più<br />
direttamente investite dal cambiamento. Tale trasformazione è facilmente verificabile anche in <strong>Toscana</strong>.<br />
Il punto di partenza primario per ragionare intorno alle questioni relative a una tale trasformazione è l’ovvia<br />
affermazione che tutti, autoctoni e alloctoni, siamo persone. A volte tale ovvietà, imprescindibile quando si<br />
pensa a “noi”, è dimenticata a proposito degli “altri”.<br />
Una <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>le persone è di avere esperienze e memorie, attraverso le quali entrano<br />
socialmente in contatto con le esperienze e memorie degli altri. La memoria è una “pratica” in divenire, e<br />
riguarda tanto il passato lontano, quanto l’immediato passato, individuale e collettivo, che le persone si<br />
costruiscono ogni giorno attraverso le loro esperienze.<br />
Le molle che spingono le persone a emigrare sono molteplici: si fugge da conflitti e guerre, dall’oppressione<br />
patriarcale, da repressione, fame o povertà; oppure - e spesso insieme - si parte perché attratti dai “bagliori<br />
<strong>del</strong> Nord”, o semplicemente per cercare un avvenire migliore. Molteplici sono anche i percorsi migratori e i<br />
vissuti dei migranti e <strong>del</strong>le migranti. Nelle pratiche <strong>del</strong>la intercultura e <strong>del</strong>la ricerca, le singolarità di ciascuno<br />
e di ciascuna migrante vanno valorizzate. Nel ragionare su tutto questo non si possono dimenticare le<br />
specificità soprattutto di classe, ma anche di genere, di livello d’istruzione o di “occupabilità”, che<br />
contribuiscono a determinare la natura <strong>del</strong>le esperienze tanto di emigrazione quanto di immigrazione; in<br />
particolare, nelle pratiche sia <strong>del</strong>l’intercultura sia <strong>del</strong>la ricerca, occorre valorizzare la dimensione di genere.<br />
La presenza <strong>del</strong> campus in un “luogo di memoria”, usando l’espressione con la quale lo storico francese<br />
Pierre Nora ha definito i monumenti la cui funzione è quella di tenere viva una memoria pubblica di fatti e<br />
persone <strong>del</strong>la storia nazionale, di per sé ci richiama al “dovere <strong>del</strong>la memoria”. Questo equivale, in generale,<br />
alla necessità di rispettare tanto la propria memoria, quanto la memoria degli altri, ma anche, come si è fatto<br />
nel campus, alla necessità di rapportare la memoria di fatti dolorosi come quelli <strong>del</strong>l’eccidio di San<br />
Pancrazio, in cui gli italiani sono stati le vittime, con quelli <strong>del</strong> tutto analoghi, consumatisi in Libia e nel<br />
Corno d’Africa durante il periodo coloniale, dove gli italiani sono stati i carnefici.<br />
Se vogliamo costruire le basi di una relazione con gli altri rispettosa e egualitaria, dobbiamo contribuire -<br />
nella scuola e nei diversi luoghi di socializzazione nonché nei centri di informazione, documentazione e<br />
ricerca - a far emergere le memorie cancellate o negate <strong>del</strong>le sofferenze inflitte a popoli e minoranze dal<br />
razzismo, dal colonialismo e dall’imperialismo.<br />
Insieme a quella <strong>del</strong>la Shoah, va portata alla luce e va fatta conoscere la memoria di un altro sterminio<br />
nazista: quello <strong>del</strong> popolo zingaro, la cui negazione o minimizzazione è parte di quella “politica <strong>del</strong><br />
disprezzo” <strong>del</strong>la quale sono vittime i Rom e i Sinti. Il sistema di segregazione che è loro imposto, mentre<br />
tende a marginalizzarli sempre di più, contribuisce ad alimentare il diffuso pregiudizio di cui sono oggetto.<br />
Oggi, il presupposto che tutti siamo persone, dotate di un passato e di un futuro, di bisogni, di desideri e di<br />
aspettative impone il dovere di focalizzare l’attenzione sui limiti attuali <strong>del</strong>la convivenza democratica nella<br />
società italiana e sulla necessità <strong>del</strong>l’attuazione di politiche <strong>del</strong>la cittadinanza.<br />
Per essere tale, la cittadinanza deve garantire a chiunque viva nel nostro paese l’uguaglianza dei diritti civili,<br />
politici e sociali. In Italia e in Europa occorre attuare politiche che vadano nella direzione di una cittadinanza<br />
non subordinata alla nazionalità, attraverso l’estensione <strong>del</strong> diritto di voto agli “extracomunitari” e la riforma<br />
<strong>del</strong>la cittadinanza giuridica nel senso <strong>del</strong> diritto di suolo. Queste politiche non possono essere conquistate e<br />
questi diritti non possono essere resi effettivi se non nel quadro <strong>del</strong>la dimensione <strong>del</strong> conflitto. Il dovere<br />
democratico di garantire l’uguaglianza dei diritti impone che si superi l’anomalia costituita dai cosiddetti<br />
Centri di Permanenza Temporanea i quali, in violazione <strong>del</strong>la Costituzione, privano <strong>del</strong>la libertà personale<br />
persone che secondo le stesse leggi italiane non hanno commesso alcun reato.<br />
Nell’Italia <strong>del</strong>l’immigrazione è necessario che vengano attuate politiche <strong>del</strong>l’accoglienza, processi di<br />
facilitazione <strong>del</strong>l’inserimento sociale e di estensione dei diritti sociali, programmi di edilizia popolare,<br />
pratiche <strong>del</strong>l’intercultura in ogni struttura sociale (istituzioni, scuole, uffici ecc.).<br />
Alla base <strong>del</strong>l’intercultura va posto il metodo <strong>del</strong> decentramento, vale a dire la pratica reciproca <strong>del</strong> provare a<br />
mettersi dal punto di vista <strong>del</strong>l’altro, per poter scambiare e negoziare significati. L’intercultura implica anche<br />
il fare concreta esperienza <strong>del</strong>l’altro, provando a “stranierizzarsi”.<br />
Nelle pratiche di ricerca sulla realtà <strong>del</strong>l’immigrazione, che auspichiamo diventino parte integrante<br />
<strong>del</strong>l’attività dei centri sul territorio toscano coinvolti nei campus di <strong>Porto</strong> <strong>Franco</strong>, va sperimentato il metodo<br />
<strong>del</strong>la ricerca dialogica che spezzi la dicotomia fra soggetto e oggetto <strong>del</strong>l’indagine. La ricerca, insomma,<br />
dovrebbe essere una con-ricerca.<br />
123