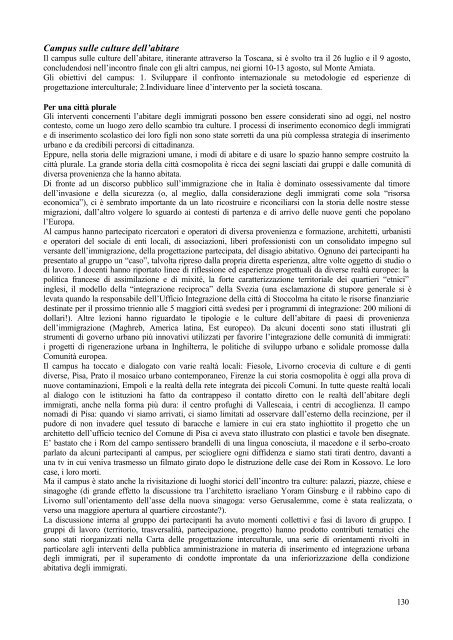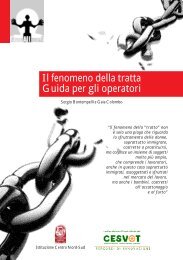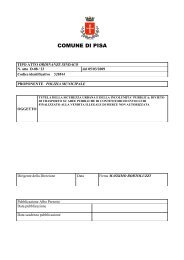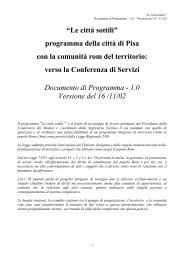Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Campus sulle culture <strong>del</strong>l’abitare<br />
Il campus sulle culture <strong>del</strong>l’abitare, itinerante attraverso la <strong>Toscana</strong>, si è svolto tra il 26 luglio e il 9 agosto,<br />
concludendosi nell’incontro finale con gli altri campus, nei giorni 10-13 agosto, sul Monte Amiata.<br />
Gli obiettivi <strong>del</strong> campus: 1. Sviluppare il confronto internazionale su metodologie ed esperienze di<br />
progettazione interculturale; 2.Individuare linee d’intervento per la società toscana.<br />
Per una città plurale<br />
Gli interventi concernenti l’abitare degli immigrati possono ben essere considerati sino ad oggi, nel nostro<br />
contesto, come un luogo zero <strong>del</strong>lo scambio tra culture. I processi di inserimento economico degli immigrati<br />
e di inserimento scolastico dei loro figli non sono state sorretti da una più complessa strategia di inserimento<br />
urbano e da credibili percorsi di cittadinanza.<br />
Eppure, nella storia <strong>del</strong>le migrazioni umane, i modi di abitare e di usare lo spazio hanno sempre costruito la<br />
città plurale. La grande storia <strong>del</strong>la città cosmopolita è ricca dei segni lasciati dai gruppi e dalle comunità di<br />
diversa provenienza che la hanno abitata.<br />
Di fronte ad un discorso pubblico sull’immigrazione che in Italia è dominato ossessivamente dal timore<br />
<strong>del</strong>l’invasione e <strong>del</strong>la sicurezza (o, al meglio, dalla considerazione degli immigrati come sola “risorsa<br />
economica”), ci è sembrato importante da un lato ricostruire e riconciliarsi con la storia <strong>del</strong>le nostre stesse<br />
migrazioni, dall’altro volgere lo sguardo ai contesti di partenza e di arrivo <strong>del</strong>le nuove genti che popolano<br />
l’Europa.<br />
Al campus hanno partecipato ricercatori e operatori di diversa provenienza e formazione, architetti, urbanisti<br />
e operatori <strong>del</strong> sociale di enti locali, di associazioni, liberi professionisti con un consolidato impegno sul<br />
versante <strong>del</strong>l’immigrazione, <strong>del</strong>la progettazione partecipata, <strong>del</strong> disagio abitativo. Ognuno dei partecipanti ha<br />
presentato al gruppo un “caso”, talvolta ripreso dalla propria diretta esperienza, altre volte oggetto di studio o<br />
di lavoro. I docenti hanno riportato linee di riflessione ed esperienze progettuali da diverse realtà europee: la<br />
politica francese di assimilazione e di mixité, la forte caratterizzazione territoriale dei quartieri “etnici”<br />
inglesi, il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la “integrazione reciproca” <strong>del</strong>la Svezia (una esclamazione di stupore generale si è<br />
levata quando la responsabile <strong>del</strong>l’Ufficio Integrazione <strong>del</strong>la città di Stoccolma ha citato le risorse finanziarie<br />
destinate per il prossimo triennio alle 5 maggiori città svedesi per i programmi di integrazione: 200 milioni di<br />
dollari!). Altre lezioni hanno riguardato le tipologie e le culture <strong>del</strong>l’abitare di paesi di provenienza<br />
<strong>del</strong>l’immigrazione (Maghreb, America latina, Est europeo). Da alcuni docenti sono stati illustrati gli<br />
strumenti di governo urbano più innovativi utilizzati per favorire l’integrazione <strong>del</strong>le comunità di immigrati:<br />
i progetti di rigenerazione urbana in Inghilterra, le politiche di sviluppo urbano e solidale promosse dalla<br />
Comunità europea.<br />
Il campus ha toccato e dialogato con varie realtà locali: Fiesole, Livorno crocevia di culture e di genti<br />
diverse, Pisa, Prato il mosaico urbano contemporaneo, Firenze la cui storia cosmopolita è oggi alla prova di<br />
nuove contaminazioni, Empoli e la realtà <strong>del</strong>la rete integrata dei piccoli Comuni. In tutte queste realtà locali<br />
al dialogo con le istituzioni ha fatto da contrappeso il contatto diretto con le realtà <strong>del</strong>l’abitare degli<br />
immigrati, anche nella forma più dura: il centro profughi di Vallescaia, i centri di accoglienza. Il campo<br />
nomadi di Pisa: quando vi siamo arrivati, ci siamo limitati ad osservare dall’esterno <strong>del</strong>la recinzione, per il<br />
pudore di non invadere quel tessuto di baracche e lamiere in cui era stato inghiottito il <strong>progetto</strong> che un<br />
architetto <strong>del</strong>l’ufficio tecnico <strong>del</strong> Comune di Pisa ci aveva stato illustrato con plastici e tavole ben disegnate.<br />
E’ bastato che i Rom <strong>del</strong> campo sentissero bran<strong>del</strong>li di una lingua conosciuta, il macedone e il serbo-croato<br />
parlato da alcuni partecipanti al campus, per sciogliere ogni diffidenza e siamo stati tirati dentro, davanti a<br />
una tv in cui veniva trasmesso un filmato girato dopo le distruzione <strong>del</strong>le case dei Rom in Kossovo. Le loro<br />
case, i loro morti.<br />
Ma il campus è stato anche la rivisitazione di luoghi storici <strong>del</strong>l’incontro tra culture: palazzi, piazze, chiese e<br />
sinagoghe (di grande effetto la discussione tra l’architetto israeliano Yoram Ginsburg e il rabbino capo di<br />
Livorno sull’orientamento <strong>del</strong>l’asse <strong>del</strong>la nuova sinagoga: verso Gerusalemme, come è stata realizzata, o<br />
verso una maggiore apertura al quartiere circostante?).<br />
La discussione interna al gruppo dei partecipanti ha avuto momenti collettivi e fasi di lavoro di gruppo. I<br />
gruppi di lavoro (territorio, trasversalità, partecipazione, <strong>progetto</strong>) hanno prodotto contributi tematici che<br />
sono stati riorganizzati nella Carta <strong>del</strong>le progettazione interculturale, una serie di orientamenti rivolti in<br />
particolare agli interventi <strong>del</strong>la pubblica amministrazione in materia di inserimento ed integrazione urbana<br />
degli immigrati, per il superamento di condotte improntate da una inferiorizzazione <strong>del</strong>la condizione<br />
abitativa degli immigrati.<br />
130