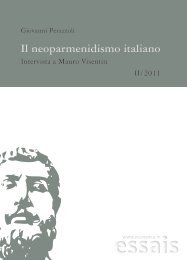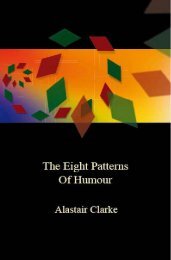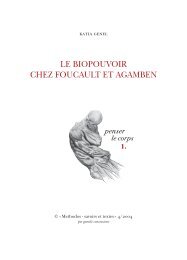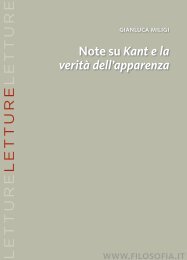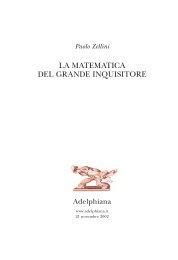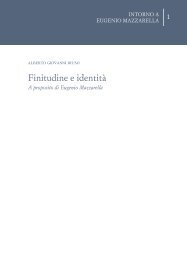CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mente c’è come un «egli» o come un «io» («io spingo», «io<br />
succhio») che saprebbe o non saprebbe. Possiamo allora «parlare»<br />
della sua esperienza la quale è cost<strong>it</strong>utivamente scissa da<br />
ogni sapere e da ogni parola? esperienza che traccia e che separa,<br />
ma in cui non vi è traccia di sapere?<br />
Noi parliamo del cost<strong>it</strong>uirsi della relazione tra interno ed esterno,<br />
ma il soggetto di questa relazione non ha né l’uno né<br />
l’altro di questi termini, non essendo affatto un soggetto che si<br />
osserva e che si dice nel sapere. Attestati nelle nostre descrizioni<br />
categoriali, ci riferiamo a un livello precategoriale che è forse<br />
ancora più profondo e originario di ciò che Husserl intendeva<br />
comunemente con questa epressione (ma non vanno dimenticate<br />
le sue analisi sulla «sintesi passiva» e le altre relative alla cost<strong>it</strong>uzione<br />
temporale). Noi che bene o male siamo in un sapere,<br />
con che dir<strong>it</strong>to parliamo di una dimensione nella quale il sapere<br />
non c’è? che è poi ciò che di essa dice appunto il sapere: che è<br />
priva di sapere. Naturalmente essa non è priva di sapere «in sé».<br />
Nulla, sappiamo, è «in sé», ma è sempre così e così determinato<br />
per un altro, cioè come segno di sé. La dimensione «precategoriale»<br />
di cui parliamo è priva di sapere dal punto di vista<br />
del sapere in nome del quale appunto parliamo e in forza del<br />
quale la diciamo come la diciamo: «priva di sapere».<br />
Inoltre: qual è il luogo a partire dal quale noi che diciamo<br />
queste cose ci poniamo e parliamo? Qual è, in altri termini, il<br />
luogo del soggetto fenomenologico che stiamo incarnando nel<br />
corso delle presenti analisi? Anche Hegel si poneva domande<br />
non molto dissimili nella sua Fenomenologia dello spir<strong>it</strong>o: chi è<br />
colui che parla e che dice la «fenomenologia dello spir<strong>it</strong>o»? e<br />
dove è collocato rispetto a quella esperienza che descrive? Nel<br />
rapporto «signoria-serv<strong>it</strong>ù», per esempio, le due figure, del signore<br />
e del servo, si fronteggiano. Il servo fa esperienza di avere<br />
la sua ver<strong>it</strong>à nel signore, cui deve la v<strong>it</strong>a; ma anche il signore<br />
ha la sua ver<strong>it</strong>à nel servo, perché senza il «riconoscimento» di<br />
questi non sarebbe signore di nessuno. Nella concreta prassi essi<br />
si scambiano le parti, senza rendersene conto, perché «per noi»<br />
la ver<strong>it</strong>à del loro rapporto è altra ancora da quella che essi potevano<br />
vedere e sperimentare. Già, ma che significa «per noi»?<br />
188