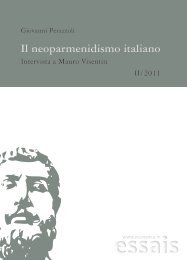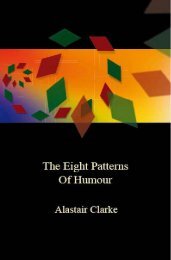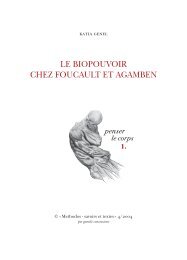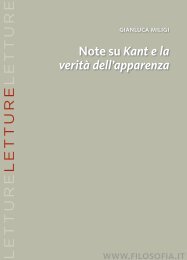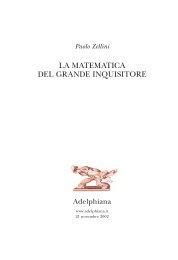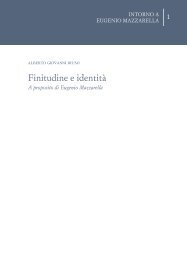CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
CARLO SINI SCRIVERE IL FENOMENO - Filosofia.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
della scienza ottica. Noi troveremmo molte parti del libro incomprensibili.<br />
Come cap<strong>it</strong>erebbe ai più di fronte a un trattato di<br />
alchimia: parole latine, parole ebraiche, frecce, disegni, simboli<br />
astrologici, nomi e figure di oggetti che non sappiamo bene<br />
come fossero fatti e a cosa servissero, e così via. Il fatto è che<br />
anche un testo scientifico moderno usa tante pratiche, tanti saperi,<br />
persino tante logiche che non sono affatto scientifiche,<br />
cioè rigorosamente costru<strong>it</strong>e nel trattato stesso. Già l’uso costante<br />
e ineliminabile del linguaggio comune comporta una<br />
frequentazione di giochi linguistici, direbbe W<strong>it</strong>tgenstein, diversi<br />
e fatalmente vaghi: prendete questo, fate quello e allora,<br />
se osservate attentamente... già, ma che significa osservare «attentamente»?<br />
Si suppone che lo si sappia e che lo si sappia fare.<br />
Uno psicologo cogn<strong>it</strong>ivista osserverebbe che la cosa non è affatto<br />
così semplice e così garant<strong>it</strong>a.<br />
In conclusione: quanto nel libro di ottica è puramente categoriale<br />
e quanto non lo è? Che cosa è rigorosamente scientifico e<br />
che cosa è, rispetto a esso, prescientifico? Lo scienziato non se<br />
lo chiede, non ci riflette, non lo sa. Ed è qui il germe della sua<br />
«crisi», almeno secondo Husserl. La scienza appare disinteressata,<br />
e del resto anche impreparata, a conoscere a fondo le prassi<br />
che usa. La scienza scrive, calcola, misura, combina altissime<br />
astrazioni grafiche e matematiche, ma di tutte queste operazioni<br />
fa un uso irriflesso. Le prende come ovvietà precategoriali,<br />
così come uno accende la sua lampada senza pensare neppure<br />
un attimo all’«elettric<strong>it</strong>à». Lo scienziato, come del resto ogni<br />
persona che pensa e agisce, deve dare per scontate un sacco di<br />
cose per poter procedere nella sua ricerca. E d’altra parte ciò che<br />
fa, come accade a ogni uomo sul piano della v<strong>it</strong>a comune, è un<br />
misterioso intreccio di categoriale e precategoriale.<br />
6. Nella Krisis, come si sa, Husserl esamina il caso emblematico<br />
di Galileo: «scopr<strong>it</strong>ore» della fisica moderna e «ricopr<strong>it</strong>ore» del<br />
suo «senso» ultimo. Galileo matematizza la scienza della natura,<br />
ma non si chiede il senso delle operazioni matematicogeometriche<br />
che ered<strong>it</strong>a dalla tradizione e che applica in un certo<br />
modo ai suoi problemi. E così oggi uno studente di fisica non si<br />
azzarderebbe a domandare al suo professore perché mai, per lau-<br />
70