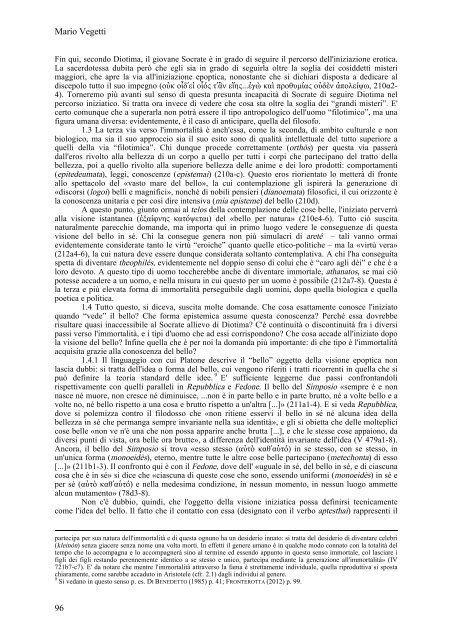Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mario Vegetti<br />
Fin qui, secondo Diotima, il giovane Socrate è in grado di seguire il percorso dell'iniziazione erotica.<br />
La sacerdotessa dubita però che egli sia in grado di seguirla oltre la soglia dei cosiddetti misteri<br />
maggiori, che apre la via all'iniziazione epoptica, nonostante che si dichiari disposta a dedicare al<br />
discepolo tutto il suo impegno (οὐκ οἶδ´εἰ οἷός τ´ἂν εἴης...ἐγὼ καὶ προθυµίας οὐδὲν ἀπολείψω, 210α2-<br />
4). Torneremo più avanti sul senso di questa presunta incapacità di Socrate di seguire Diotima nel<br />
percorso iniziatico. Si tratta ora invece di vedere che cosa sta oltre la soglia dei “grandi misteri”. E'<br />
certo comunque che a superarla non potrà essere il tipo antropologico dell'uomo “filotimico”, ma una<br />
figura umana diversa: evidentemente, è il caso di anticipare, quella del filosofo.<br />
1.3 La terza via verso l'immortalità è anch'essa, come la seconda, di ambito culturale e non<br />
biologico, ma sia il suo approccio sia il suo esito sono di qualità intellettuale del tutto superiore a<br />
quelli della via “filotimica”. Chi dunque procede correttamente (orthòs) per questa via passerà<br />
dall'eros rivolto alla bellezza di un corpo a quello per tutti i corpi che partecipano del tratto della<br />
bellezza, poi a quello rivolto alla superiore bellezza delle anime e dei loro prodotti: comportamenti<br />
(epitedeumata), leggi, conoscenze (epistemai) (210a-c). Questo eros riorientato lo metterà di fronte<br />
allo spettacolo del «vasto mare del bello», la cui contemplazione gli ispirerà la generazione di<br />
«discorsi (logoi) belli e magnifici», nonché di nobili pensieri (dianoemata) filosofici, il cui orizzonte è<br />
la conoscenza unitaria e per così dire intensiva (mia episteme) del bello (210d).<br />
A questo punto, giunto ormai al telos della contemplazione delle cose belle, l'iniziato perverrà<br />
alla visione istantanea (ἐξαίφνης κατόψεται) del «bello per natura» (210e4-6). Tutto ciò suscita<br />
naturalmente parecchie domande, ma importa qui in primo luogo vedere le conseguenze di questa<br />
visione del bello in sé. Chi la consegue genera non più simulacri di areté – tali vanno ormai<br />
evidentemente considerate tanto le virtù “eroiche” quanto quelle etico-politiche – ma la «virtù vera»<br />
(212a4-6), la cui natura deve essere dunque considerata soltanto contemplativa. A chi l'ha conseguita<br />
spetta di diventare theophilés, evidentemente nel doppio senso di colui che è “caro agli dèi” e che è a<br />
loro devoto. A questo tipo di uomo toccherebbe anche di diventare immortale, athanatos, se mai ciò<br />
potesse accadere a un uomo, e nella misura in cui questo per un uomo è possibile (212a7-8). Questa è<br />
la terza e più elevata forma di immortalità perseguibile dagli uomini, dopo quella biologica e quella<br />
poetica e politica.<br />
1.4 Tutto questo, si diceva, suscita molte domande. Che cosa esattamente conosce l'iniziato<br />
quando “vede” il bello? Che forma epistemica assume questa conoscenza? Perché essa dovrebbe<br />
risultare quasi inaccessibile al Socrate allievo di Diotima? C'è continuità o discontinuità fra i diversi<br />
passi verso l'immortalità, e i tipi d'uomo che ad essi corrispondono? Che cosa accade all'iniziato dopo<br />
la visione del bello? Infine quella che è per noi la domanda più importante: di che tipo è l'immortalità<br />
acquisita grazie alla conoscenza del bello?<br />
1.4.1 Il linguaggio con cui Platone descrive il “bello” oggetto della visione epoptica non<br />
lascia dubbi: si tratta dell'idea o forma del bello, cui vengono riferiti i tratti ricorrenti in quella che si<br />
può definire la teoria standard delle idee. 9 E' sufficiente leggerne due passi confrontandoli<br />
rispettivamente con quelli paralleli in Repubblica e Fedone. Il bello del Simposio «sempre è e non<br />
nasce né muore, non cresce né diminuisce, ...non è in parte bello e in parte brutto, né a volte bello e a<br />
volte no, né bello rispetto a una cosa e brutto rispetto a un'altra [...]» (211a1-4). E si veda Repubblica,<br />
dove si polemizza contro il filodosso che «non ritiene esservi il bello in sé né alcuna idea della<br />
bellezza in sé che permanga sempre invariante nella sua identità», e gli si obietta che delle molteplici<br />
cose belle «non ve n'è una che non possa apparire anche brutta [...], e che le stesse cose appaiono, da<br />
diversi punti di vista, ora belle ora brutte», a differenza dell'identità invariante dell'idea (V 479a1-8).<br />
Ancora, il bello del Simposio si trova «esso stesso (αὐτὸ καθ´αὑτό) in se stesso, con se stesso, in<br />
un'unica forma (monoeidès), eterno, mentre tutte le altre cose belle partecipano (metechonta) di esso<br />
[...]» (211b1-3). Il confronto qui è con il Fedone, dove dell' «uguale in sé, del bello in sé, e di ciascuna<br />
cosa che è in sé» si dice che «ciascuna di queste cose che sono, essendo uniformi (monoeidès) in sé e<br />
per sé (αὐτὸ καθ´αὑτό) e nella medesima condizione, in nessun momento, in nessun luogo ammette<br />
alcun mutamento» (78d3-8).<br />
Non c'è dubbio, quindi, che l'oggetto della visione iniziatica possa definirsi tecnicamente<br />
come l'idea del bello. Il fatto che il contatto con essa (designato con il verbo aptesthai) rappresenti il<br />
partecipa per sua natura dell'immortalità e di questa ognuno ha un desiderio innato: si tratta del desiderio di diventare celebri<br />
(kleinòn) senza giacere senza nome una volta morti. In effetti il genere umano è in qualche modo connato con la totalità del<br />
tempo che lo accompagna e lo accompagnerà sino al termine ed essendo appunto in questo senso immortale, col lasciare i<br />
figli dei figli restando perennemente identico a se stesso e unico, partecipa mediante la generazione all'immortalità» (IV<br />
721b7-c7). E' da notare che mentre l'immortalità attraverso la fama è strettamente individuale, quella riproduttiva si sposta<br />
chiaramente, come sarebbe accaduto in Aristotele (cfr. 2.1) dagli individui al genere.<br />
9 Si vedano in questo senso p. es. DI BENEDETTO (1985) p. 41; FRONTEROTTA (2012) p. 99.<br />
96