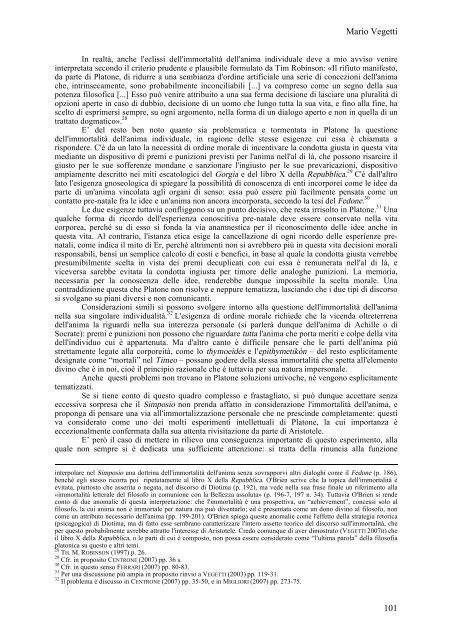You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mario Vegetti<br />
In realtà, anche l'eclissi dell'immortalità dell'anima individuale deve a mio avviso venire<br />
interpretata secondo il criterio prudente e plausibile formulato da Tim Robinson: «Il rifiuto manifesto,<br />
da parte di Platone, di ridurre a una sembianza d'ordine artificiale una serie di concezioni dell'anima<br />
che, intrinsecamente, sono probabilmente inconciliabili [...] va compreso come un segno della sua<br />
potenza filosofica [...] Esso può venire attribuito a una sua ferma decisione di lasciare una pluralità di<br />
opzioni aperte in caso di dubbio, decisione di un uomo che lungo tutta la sua vita, e fino alla fine, ha<br />
scelto di esprimersi sempre, su ogni argomento, nella forma di un dialogo aperto e non in quella di un<br />
trattato dogmatico». 28<br />
E’ del resto ben noto quanto sia problematica e tormentata in Platone la questione<br />
dell'immortalità dell'anima individuale, in ragione delle stesse esigenze cui essa è chiamata a<br />
rispondere. C'è da un lato la necessità di ordine morale di incentivare la condotta giusta in questa vita<br />
mediante un dispositivo di premi e punizioni previsti per l'anima nell'al di là, che possono risarcire il<br />
giusto per le sue sofferenze mondane e sanzionare l'ingiusto per le sue prevaricazioni, dispositivo<br />
ampiamente descritto nei miti escatologici del Gorgia e del libro X della Repubblica. 29 C'è dall'altro<br />
lato l'esigenza gnoseologica di spiegare la possibilità di conoscenza di enti incorporei come le idee da<br />
parte di un'anima vincolata agli organi di senso: essa può essere più facilmente pensata come un<br />
contatto pre-natale fra le idee e un'anima non ancora incorporata, secondo la tesi del Fedone. 30<br />
Le due esigenze tuttavia confliggono su un punto decisivo, che resta irrisolto in Platone. 31 Una<br />
qualche forma di ricordo dell'esperienza conoscitiva pre-natale deve essere conservato nella vita<br />
corporea, perché su di esso si fonda la via anamnestica per il riconoscimento delle idee anche in<br />
questa vita. Al contrario, l'istanza etica esige la cancellazione di ogni ricordo delle esperienze prenatali,<br />
come indica il mito di Er, perché altrimenti non si avrebbero più in questa vita decisioni morali<br />
responsabili, bensì un semplice calcolo di costi e benefici, in base al quale la condotta giusta verrebbe<br />
presumibilmente scelta in vista dei premi decuplicati con cui essa è remunerata nell'al di là, e<br />
viceversa sarebbe evitata la condotta ingiusta per timore delle analoghe punizioni. La memoria,<br />
necessaria per la conoscenza delle idee, renderebbe dunque impossibile la scelta morale. Una<br />
contraddizione questa che Platone non risolve e neppure tematizza, lasciando che i due tipi di discorso<br />
si svolgano su piani diversi e non comunicanti.<br />
Considerazioni simili si possono svolgere intorno alla questione dell'immortalità dell'anima<br />
nella sua singolare individualità. 32 L'esigenza di ordine morale richiede che la vicenda oltreterrena<br />
dell'anima la riguardi nella sua interezza personale (si parlerà dunque dell'anima di Achille o di<br />
Socrate): premi e punizioni non possono che riguardare tutta l'anima che porta meriti e colpe della vita<br />
dell'individuo cui è appartenuta. Ma d'altro canto è difficile pensare che le parti dell'anima più<br />
strettamente legate alla corporeità, come lo thymoeidès e l'epithymetikòn – del resto esplicitamente<br />
designate come “mortali” nel Timeo – possano godere della stessa immortalità che spetta all'elemento<br />
divino che è in noi, cioè il principio razionale che è tuttavia per sua natura impersonale.<br />
Anche questi problemi non trovano in Platone soluzioni univoche, né vengono esplicitamente<br />
tematizzati.<br />
Se si tiene conto di questo quadro complesso e frastagliato, si può dunque accettare senza<br />
eccessiva sorpresa che il Simposio non prenda affatto in considerazione l'immortalità dell'anima, e<br />
proponga di pensare una via all'immortalizzazione personale che ne prescinde completamente: questi<br />
va considerato come uno dei molti esperimenti intellettuali di Platone, la cui importanza è<br />
eccezionalmente confermata dalla sua attenta rivisitazione da parte di Aristotele.<br />
E’ però il caso di mettere in rilievo una conseguenza importante di questo esperimento, alla<br />
quale non sempre si è dedicata una sufficiente attenzione: si tratta della rinuncia alla funzione<br />
interpolare nel Simposio una dottrina dell'immortalità dell'anima senza sovrapporvi altri dialoghi come il Fedone (p. 186),<br />
benché egli stesso ricorra poi ripetutamente al libro X della Repubblica. O'Brien scrive che la topica dell'immortalità è<br />
evitata, piuttosto che asserita o negata, nel discorso di Diotima (p. 192), ma vede nella sua frase finale un riferimento alla<br />
«immortalità letterale del filosofo in comunione con la Bellezza assoluta» (p. 196-7, 197 n. 34). Tuttavia O'Brien si rende<br />
conto di due anomalie di questa interpretazione: che l'immortalità è una prospettiva, un “achievement”, concessi solo al<br />
filosofo, la cui anima non è immortale per natura ma può diventarlo; ed è presentata come un dono divino al filosofo, non<br />
come un attributo necessario dell'anima (pp. 199-201). O'Brien spiega queste anomalie come l'effetto della strategia retorica<br />
(psicagogica) di Diotima, ma di fatto esse sembrano caratterizzare l'intero assetto teorico del discorso sull'immortalità, che<br />
per questo probabilmente avrebbe attratto l'interesse di Aristotele. Credo comunque di aver dimostrato (VEGETTI 2007B) che<br />
il libro X della Repubblica, o le parti di cui è composto, non possa essere considerato come “l'ultima parola” della filosofia<br />
platonica su questo e altri temi.<br />
28 TH. M. ROBINSON (1997) p. 26.<br />
29 Cfr. in proposito CENTRONE (2007) pp. 36 s.<br />
30 Cfr. in questo senso FERRARI (2007) pp. 80-83.<br />
31 Per una discussione più ampia in proposito rinvio a VEGETTI (2003) pp. 119-31.<br />
32 Il problema è discusso in CENTRONE (2007) pp. 35-50, e in MIGLIORI (2007) pp. 273-75.<br />
101