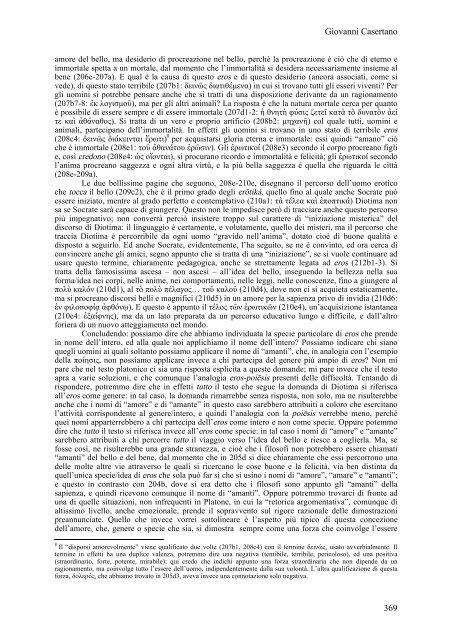You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Casertano<br />
amore del bello, ma desiderio di procreazione nel bello, perché la procreazione è ciò che di eterno e<br />
immortale spetta a un mortale, dal momento che l’immortalità si desidera necessariamente insieme al<br />
bene (206e-207a). E qual è la causa di questo eros e di questo desiderio (ancora associati, come si<br />
vede), di questo stato terribile (207b1: δεινῶς διατιθέµενα) in cui si trovano tutti gli esseri viventi? Per<br />
gli uomini si potrebbe pensare anche che si tratti di una disposizione derivante da un ragionamento<br />
(207b7-8: ἐκ λογισµοῦ), ma per gli altri animali? La risposta è che la natura mortale cerca per quanto<br />
è possibile di essere sempre e di essere immortale (207d1-2: ἡ θνητὴ φύσις ζετεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεί<br />
τε καὶ ἀθάναθος). Si tratta di un vero e proprio artificio (208b2: µηχανῆ) col quale tutti, uomini e<br />
animali, partecipano dell’immortalità. In effetti gli uomini si trovano in uno stato di terribile eros<br />
(208c4: δεινῶς διάκεινται ἔρωτι) 8 per acquistarsi gloria eterna e immortale: essi quindi “amano” ciò<br />
che è immortale (208e1: τοῦ ἀθανάτου ἐρῶσιν). Gli ἐρωτικοί (208e3) secondo il corpo procreano figli<br />
e, così credono (208e4: ὡς οἴονται), si procurano ricordo e immortalità e felicità; gli ἐρωτικοί secondo<br />
l’anima procreano saggezza e ogni altra virtù, e la più bella saggezza è quella che riguarda le città<br />
(208e-209a).<br />
Le due bellissime pagine che seguono, 208e-210e, disegnano il percorso dell’uomo erotico<br />
che tocca il bello (209c2), che è il primo grado degli erōtiká, quello fino al quale anche Socrate può<br />
essere iniziato, mentre al grado perfetto e contemplativo (210a1: τὰ τέλεα καὶ ἐποπτικά) Diotima non<br />
sa se Socrate sarà capace di giungere. Questo non le impedisce però di tracciare anche questo percorso<br />
più impegnativo; non converrà perciò insistere troppo sul carattere di “iniziazione misterica” del<br />
discorso di Diotima: il linguaggio è certamente, e volutamente, quello dei misteri, ma il percorso che<br />
traccia Diotima è percorribile da ogni uomo “gravido nell’anima”, dotato cioè di buone qualità e<br />
disposto a seguirlo. Ed anche Socrate, evidentemente, l’ha seguito, se ne è convinto, ed ora cerca di<br />
convincere anche gli amici, segno appunto che si tratta di una “iniziazione”, se si vuole continuare ad<br />
usare questo termine, chiaramente pedagogica, anche se strettamente legata ad eros (212b1-3). Si<br />
tratta della famosissima ascesa – non ascesi – all’idea del bello, inseguendo la bellezza nella sua<br />
forma/idea nei corpi, nelle anime, nei comportamenti, nelle leggi, nelle conoscenze, fino a giungere al<br />
πολὺ καλόν (210d1), al τὸ πολὺ πέλαγος… τοῦ καλοῦ (210d4), dove non ci si acquieta estaticamente,<br />
ma si procreano discorsi belli e magnifici (210d5) in un amore per la sapienza privo di invidia (210d6:<br />
ἐν φιλοσοφίᾳ ἀφθόνῳ). E questo è appunto il τέλος τῶν ἐρωτικῶν (210e4), un’acquisizione istantanea<br />
(210e4: ἐξαίφνης), ma da un lato preparata da un percorso educativo lungo e difficile, e dall’altro<br />
foriera di un nuovo atteggiamento nel mondo.<br />
Concludendo: possiamo dire che abbiamo individuata la specie particolare di eros che prende<br />
in nome dell’intero, ed alla quale noi applichiamo il nome dell’intero? Possiamo indicare chi siano<br />
quegli uomini ai quali soltanto possiamo applicare il nome di “amanti”, che, in analogia con l’esempio<br />
della ποίησις, non possiamo applicare invece a chi partecipa del genere più ampio di eros? Non mi<br />
pare che nel testo platonico ci sia una risposta esplicita a queste domande; mi pare invece che il testo<br />
apra a varie soluzioni, e che comunque l’analogia eros-poiēsis presenti delle difficoltà. Tentando di<br />
rispondere, potremmo dire che in effetti tutto il testo che segue la domanda di Diotima si riferisca<br />
all’eros come genere: in tal caso, la domanda rimarrebbe senza risposta, non solo, ma ne risulterebbe<br />
anche che i nomi di “amore” e di “amante” in questo caso sarebbero attribuiti a coloro che esercitano<br />
l’attività corrispondente al genere/intero, e quindi l’analogia con la poiēsis verrebbe meno, perché<br />
quei nomi apparterrebbero a chi partecipa dell’eros come intero e non come specie. Oppure potemmo<br />
dire che tutto il testo si riferisca invece all’eros come specie: in tal caso i nomi di “amore” e “amante”<br />
sarebbero attribuiti a chi percorre tutto il viaggio verso l’idea del bello e riesce a coglierla. Ma, se<br />
fosse così, ne risulterebbe una grande stranezza, e cioè che i filosofi non potrebbero essere chiamati<br />
“amanti” del bello e del bene, dal momento che in 205d si dice chiaramente che essi percorrono una<br />
delle molte altre vie attraverso le quali si ricercano le cose buone e la felicità, via ben distinta da<br />
quell’unica specie/idea di eros che sola può far sì che si usino i nomi di “amore”, “amare” e “amanti”;<br />
e questo in contrasto con 204b, dove si era detto che i filosofi sono appunto gli “amanti” della<br />
sapienza, e quindi ricevono comunque il nome di “amanti”. Oppure potremmo trovarci di fronte ad<br />
una di quelle situazioni, non infrequenti in Platone, in cui la “retorica argomentativa”, comunque di<br />
altissimo livello, anche emozionale, prende il sopravvento sul rigore razionale delle dimostrazioni<br />
preannunciate. Quello che invece vorrei sottolineare è l’aspetto più tipico di questa concezione<br />
dell’amore, che, genere o specie che sia, si dimostra sempre come una forza che coinvolge l’essere<br />
8 Il “disporsi amorevolmente” viene qualificato due volte (207b1, 208c4) con il termine δεινῶς, usato avverbialmente. Il<br />
termine in effetti ha una duplice valenza, potremmo dire una negativa (temibile, terribile, pericoloso), ed una positiva<br />
(straordinario, forte, potente, mirabile): qui credo che indichi appunto una forza straordinaria che non dipende da un<br />
ragionamento, ma coinvolge tutto l’essere dell’uomo, indipendentemente dalla sua volontà. L’altra qualificazione di questa<br />
forza, δολερός, che abbiamo trovato in 205d3, aveva invece una connotazione solo negativa.<br />
369