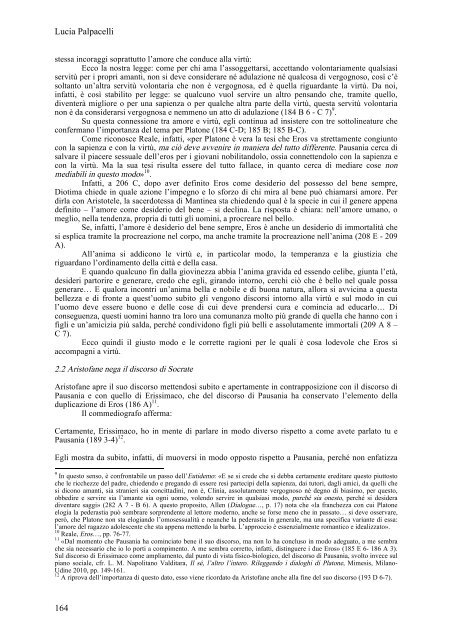Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lucia Palpacelli<br />
stessa incoraggi soprattutto l’amore che conduce alla virtù:<br />
Ecco la nostra legge: come per chi ama l’assoggettarsi, accettando volontariamente qualsiasi<br />
servitù per i propri amanti, non si deve considerare né adulazione né qualcosa di vergognoso, così c’è<br />
soltanto un’altra servitù volontaria che non è vergognosa, ed è quella riguardante la virtù. Da noi,<br />
infatti, è così stabilito per legge: se qualcuno vuol servire un altro pensando che, tramite quello,<br />
diventerà migliore o per una sapienza o per qualche altra parte della virtù, questa servitù volontaria<br />
non è da considerarsi vergognosa e nemmeno un atto di adulazione (184 B 6 - C 7) 9 .<br />
Su questa connessione tra amore e virtù, egli continua ad insistere con tre sottolineature che<br />
confermano l’importanza del tema per Platone (184 C-D; 185 B; 185 B-C).<br />
Come riconosce Reale, infatti, «per Platone è vera la tesi che Eros va strettamente congiunto<br />
con la sapienza e con la virtù, ma ciò deve avvenire in maniera del tutto differente. Pausania cerca di<br />
salvare il piacere sessuale dell’eros per i giovani nobilitandolo, ossia connettendolo con la sapienza e<br />
con la virtù. Ma la sua tesi risulta essere del tutto fallace, in quanto cerca di mediare cose non<br />
mediabili in questo modo» 10 .<br />
Infatti, a 206 C, dopo aver definito Eros come desiderio del possesso del bene sempre,<br />
Diotima chiede in quale azione l’impegno e lo sforzo di chi mira al bene può chiamarsi amore. Per<br />
dirla con Aristotele, la sacerdotessa di Mantinea sta chiedendo qual è la specie in cui il genere appena<br />
definito – l’amore come desiderio del bene – si declina. La risposta è chiara: nell’amore umano, o<br />
meglio, nella tendenza, propria di tutti gli uomini, a procreare nel bello.<br />
Se, infatti, l’amore è desiderio del bene sempre, Eros è anche un desiderio di immortalità che<br />
si esplica tramite la procreazione nel corpo, ma anche tramite la procreazione nell’anima (208 E - 209<br />
A).<br />
All’anima si addicono le virtù e, in particolar modo, la temperanza e la giustizia che<br />
riguardano l’ordinamento della città e della casa.<br />
E quando qualcuno fin dalla giovinezza abbia l’anima gravida ed essendo celibe, giunta l’età,<br />
desideri partorire e generare, credo che egli, girando intorno, cerchi ciò che è bello nel quale possa<br />
generare… E qualora incontri un’anima bella e nobile e di buona natura, allora si avvicina a questa<br />
bellezza e di fronte a quest’uomo subito gli vengono discorsi intorno alla virtù e sul modo in cui<br />
l’uomo deve essere buono e delle cose di cui deve prendersi cura e comincia ad educarlo… Di<br />
conseguenza, questi uomini hanno tra loro una comunanza molto più grande di quella che hanno con i<br />
figli e un’amicizia più salda, perché condividono figli più belli e assolutamente immortali (209 A 8 –<br />
C 7).<br />
Ecco quindi il giusto modo e le corrette ragioni per le quali è cosa lodevole che Eros si<br />
accompagni a virtù.<br />
2.2 Aristofane nega il discorso di Socrate<br />
Aristofane apre il suo discorso mettendosi subito e apertamente in contrapposizione con il discorso di<br />
Pausania e con quello di Erissimaco, che del discorso di Pausania ha conservato l’elemento della<br />
duplicazione di Eros (186 A) 11 .<br />
Il commediografo afferma:<br />
Certamente, Erissimaco, ho in mente di parlare in modo diverso rispetto a come avete parlato tu e<br />
Pausania (189 3-4) 12 .<br />
Egli mostra da subito, infatti, di muoversi in modo opposto rispetto a Pausania, perché non enfatizza<br />
9 In questo senso, è confrontabile un passo dell’Eutidemo: «E se si crede che si debba certamente ereditare questo piuttosto<br />
che le ricchezze del padre, chiedendo e pregando di essere resi partecipi della sapienza, dai tutori, dagli amici, da quelli che<br />
si dicono amanti, sia stranieri sia concittadini, non è, Clinia, assolutamente vergognoso né degno di biasimo, per questo,<br />
obbedire e servire sia l’amante sia ogni uomo, volendo servire in qualsiasi modo, purché sia onesto, perché si desidera<br />
diventare saggi» (282 A 7 - B 6). A questo proposito, Allen (Dialogue…, p. 17) nota che «la franchezza con cui Platone<br />
elogia la pederastia può sembrare sorprendente al lettore moderno, anche se forse meno che in passato… si deve osservare,<br />
però, che Platone non sta elogiando l’omosessualità e neanche la pederastia in generale, ma una specifica variante di essa:<br />
l’amore del ragazzo adolescente che sta appena mettendo la barba. L’approccio è essenzialmente romantico e idealizzato».<br />
10 Reale, Eros…, pp. 76-77.<br />
11 «Dal momento che Pausania ha cominciato bene il suo discorso, ma non lo ha concluso in modo adeguato, a me sembra<br />
che sia necessario che io lo porti a compimento. A me sembra corretto, infatti, distinguere i due Eros» (185 E 6- 186 A 3).<br />
Sul discorso di Erissimaco come ampliamento, dal punto di vista fisico-biologico, del discorso di Pausania, svolto invece sul<br />
piano sociale, cfr. L. M. Napolitano Valditara, Il sé, l’altro l’intero. Rileggendo i dialoghi di Platone, Mimesis, Milano-<br />
Udine 2010, pp. 149-161.<br />
12 A riprova dell’importanza di questo dato, esso viene ricordato da Aristofane anche alla fine del suo discorso (193 D 6-7).<br />
164