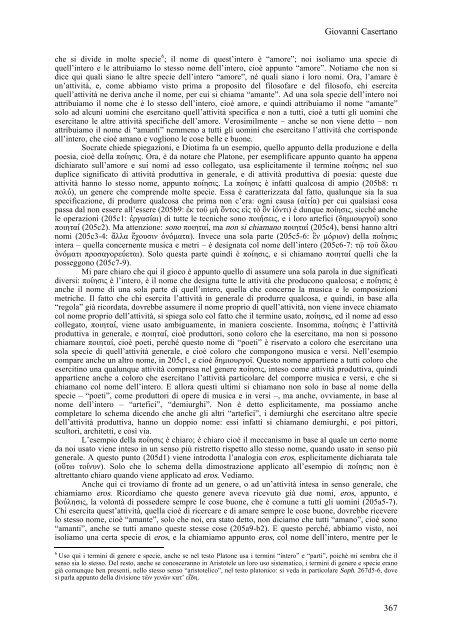You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Giovanni Casertano<br />
che si divide in molte specie 6 ; il nome di quest’intero è “amore”; noi isoliamo una specie di<br />
quell’intero e le attribuiamo lo stesso nome dell’intero, cioè appunto “amore”. Notiamo che non si<br />
dice qui quali siano le altre specie dell’intero “amore”, né quali siano i loro nomi. Ora, l’amare è<br />
un’attività, e, come abbiamo visto prima a proposito del filosofare e del filosofo, chi esercita<br />
quell’attività ne deriva anche il nome, per cui si chiama “amante”. Ad una sola specie dell’intero noi<br />
attribuiamo il nome che è lo stesso dell’intero, cioè amore, e quindi attribuiamo il nome “amante”<br />
solo ad alcuni uomini che esercitano quell’attività specifica e non a tutti, cioè a tutti gli uomini che<br />
esercitano le altre attività specifiche dell’amore. Verosimilmente – anche se non viene detto – non<br />
attribuiamo il nome di “amanti” nemmeno a tutti gli uomini che esercitano l’attività che corrisponde<br />
all’intero, che cioè amano e vogliono le cose belle e buone.<br />
Socrate chiede spiegazioni, e Diotima fa un esempio, quello appunto della produzione e della<br />
poesia, cioè della ποίησις. Ora, è da notare che Platone, per esemplificare appunto quanto ha appena<br />
dichiarato sull’amore e sui nomi ad esso collegato, usa esplicitamente il termine ποίησις nel suo<br />
duplice significato di attività produttiva in generale, e di attività produttiva di poesia: queste due<br />
attività hanno lo stesso nome, appunto ποίησις. La ποίησις è infatti qualcosa di ampio (205b8: τι<br />
πολύ), un genere che comprende molte specie. Essa è caratterizzata dal fatto, qualunque sia la sua<br />
specificazione, di produrre qualcosa che prima non c’era: ogni causa (αἰτία) per cui qualsiasi cosa<br />
passa dal non essere all’essere (205b9: ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν ἰόντι) è dunque ποίησις, sicché anche<br />
le operazioni (205c1: ἐργασίαι) di tutte le tecniche sono ποιήσεις, e i loro artefici (δηµιουργοῖ) sono<br />
ποιηταί (205c2). Ma attenzione: sono ποιηταί, ma non si chiamano ποιηταί (205c4), bensì hanno altri<br />
nomi (205c3-4: ἄλλα ἔχουσιν ὀνόµατα). Invece una sola parte (205c5-6: ἓν µόριον) della ποίησις<br />
intera – quella concernente musica e metri – è designata col nome dell’intero (205c6-7: τῷ τοῦ ὅλου<br />
ὀνόµατι προσαγορεύεται). Solo questa parte quindi è ποίησις, e si chiamano ποιηταί quelli che la<br />
posseggono (205c7-9).<br />
Mi pare chiaro che qui il gioco è appunto quello di assumere una sola parola in due significati<br />
diversi: ποίησις è l’intero, è il nome che designa tutte le attività che producono qualcosa; e ποίησις è<br />
anche il nome di una sola parte di quell’intero, quella che concerne la musica e le composizioni<br />
metriche. Il fatto che chi esercita l’attività in generale di produrre qualcosa, e quindi, in base alla<br />
“regola” già ricordata, dovrebbe assumere il nome proprio di quell’attività, non viene invece chiamato<br />
col nome proprio dell’attività, si spiega solo col fatto che il termine usato, ποίησις, ed il nome ad esso<br />
collegato, ποιηταί, viene usato ambiguamente, in maniera cosciente. Insomma, ποίησις è l’attività<br />
produttiva in generale, e ποιηταί, cioè produttori, sono coloro che la esercitano, ma non si possono<br />
chiamare ποιηταί, cioè poeti, perché questo nome di “poeti” è riservato a coloro che esercitano una<br />
sola specie di quell’attività generale, e cioè coloro che compongono musica e versi. Nell’esempio<br />
compare anche un altro nome, in 205c1, e cioè δηµιουργοῖ. Questo nome appartiene a tutti coloro che<br />
esercitino una qualunque attività compresa nel genere ποίησις, inteso come attività produttiva, quindi<br />
appartiene anche a coloro che esercitano l’attività particolare del comporre musica e versi, e che si<br />
chiamano col nome dell’intero. E allora questi ultimi si chiamano non solo in base al nome della<br />
specie – “poeti”, come produttori di opere di musica e in versi –, ma anche, ovviamente, in base al<br />
nome dell’intero – “artefici”, “demiurghi”. Non è detto esplicitamente, ma possiamo anche<br />
completare lo schema dicendo che anche gli altri “artefici”, i demiurghi che esercitano altre specie<br />
dell’attività produttiva, hanno un doppio nome: essi infatti si chiamano demiurghi, e poi pittori,<br />
scultori, architetti, e così via.<br />
L’esempio della ποίησις è chiaro; è chiaro cioè il meccanismo in base al quale un certo nome<br />
da noi usato viene inteso in un senso più ristretto rispetto allo stesso nome, quando usato in senso più<br />
generale. A questo punto (205d1) viene introdotta l’analogia con eros, esplicitamente dichiarata tale<br />
(οὕτω τοίνυν). Solo che lo schema della dimostrazione applicato all’esempio di ποίησις non è<br />
altrettanto chiaro quando viene applicato ad eros. Vediamo.<br />
Anche qui ci troviamo di fronte ad un genere, o ad un’attività intesa in senso generale, che<br />
chiamiamo eros. Ricordiamo che questo genere aveva ricevuto già due nomi, eros, appunto, e<br />
βούλησις, la volontà di possedere sempre le cose buone, che è comune a tutti gli uomini (205a5-7).<br />
Chi esercita quest’attività, quella cioè di ricercare e di amare sempre le cose buone, dovrebbe ricevere<br />
lo stesso nome, cioè “amante”, solo che noi, era stato detto, non diciamo che tutti “amano”, cioè sono<br />
“amanti”, anche se tutti amano queste stesse cose (205a9-b2). E questo perché, abbiamo visto, noi<br />
isoliamo una certa specie di eros, e la chiamiamo appunto eros, col nome dell’intero, mentre per le<br />
6 Uso qui i termini di genere e specie, anche se nel testo Platone usa i termini “intero” e “parti”, poiché mi sembra che il<br />
senso sia lo stesso. Del resto, anche se conosceranno in Aristotele un loro uso sistematico, i termini di genere e specie erano<br />
già comunque ben presenti, nello stesso senso “aristotelico”, nel testo platonico: si veda in particolare Soph. 267d5-6, dove<br />
si parla appunto della divisione τῶν γενῶν κατ’ εἴδη.<br />
367