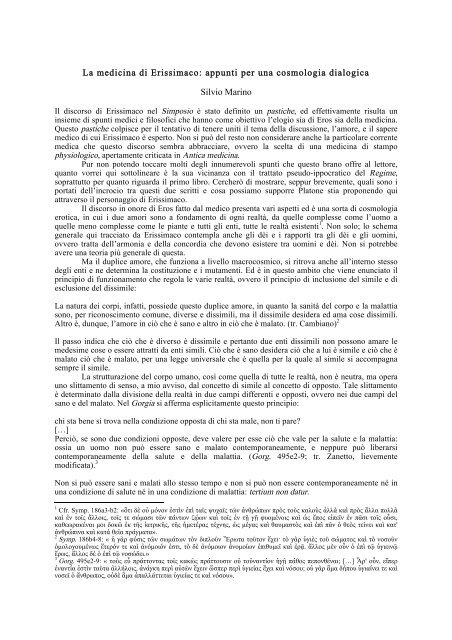You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La medicina di Erissimaco: appunti per una cosmologia dialogica<br />
Silvio Marino<br />
Il discorso di Erissimaco nel Simposio è stato definito un pastiche, ed effettivamente risulta un<br />
insieme di spunti medici e filosofici che hanno come obiettivo l’elogio sia di Eros sia della medicina.<br />
Questo pastiche colpisce per il tentativo di tenere uniti il tema della discussione, l’amore, e il sapere<br />
medico di cui Erissimaco è esperto. Non si può del resto non considerare anche la particolare corrente<br />
medica che questo discorso sembra abbracciare, ovvero la scelta di una medicina di stampo<br />
physiologico, apertamente criticata in Antica medicina.<br />
Pur non potendo toccare molti degli innumerevoli spunti che questo brano offre al lettore,<br />
quanto vorrei qui sottolineare è la sua vicinanza con il trattato pseudo-ippocratico del Regime,<br />
soprattutto per quanto riguarda il primo libro. Cercherò di mostrare, seppur brevemente, quali sono i<br />
portati dell’incrocio tra questi due scritti e cosa possiamo supporre Platone stia proponendo qui<br />
attraverso il personaggio di Erissimaco.<br />
Il discorso in onore di Eros fatto dal medico presenta vari aspetti ed è una sorta di cosmologia<br />
erotica, in cui i due amori sono a fondamento di ogni realtà, da quelle complesse come l’uomo a<br />
quelle meno complesse come le piante e tutti gli enti, tutte le realtà esistenti 1 . Non solo; lo schema<br />
generale qui tracciato da Erissimaco contempla anche gli dèi e i rapporti tra gli dèi e gli uomini,<br />
ovvero tratta dell’armonia e della concordia che devono esistere tra uomini e dèi. Non si potrebbe<br />
avere una teoria più generale di questa.<br />
Ma il duplice amore, che funziona a livello macrocosmico, si ritrova anche all’interno stesso<br />
degli enti e ne determina la costituzione e i mutamenti. Ed è in questo ambito che viene enunciato il<br />
principio di funzionamento che regola le varie realtà, ovvero il principio di inclusione del simile e di<br />
esclusione del dissimile:<br />
La natura dei corpi, infatti, possiede questo duplice amore, in quanto la sanità del corpo e la malattia<br />
sono, per riconoscimento comune, diverse e dissimili, ma il dissimile desidera ed ama cose dissimili.<br />
Altro è, dunque, l’amore in ciò che è sano e altro in ciò che è malato. (tr. Cambiano) 2<br />
Il passo indica che ciò che è diverso è dissimile e pertanto due enti dissimili non possono amare le<br />
medesime cose o essere attratti da enti simili. Ciò che è sano desidera ciò che a lui è simile e ciò che è<br />
malato ciò che è malato, per una legge universale che è quella per la quale al simile si accompagna<br />
sempre il simile.<br />
La strutturazione del corpo umano, così come quella di tutte le realtà, non è neutra, ma opera<br />
uno slittamento di senso, a mio avviso, dal concetto di simile al concetto di opposto. Tale slittamento<br />
è determinato dalla divisione della realtà in due campi differenti e opposti, ovvero nei due campi del<br />
sano e del malato. Nel Gorgia si afferma esplicitamente questo principio:<br />
chi sta bene si trova nella condizione opposta di chi sta male, non ti pare?<br />
[…]<br />
Perciò, se sono due condizioni opposte, deve valere per esse ciò che vale per la salute e la malattia:<br />
ossia un uomo non può essere sano e malato contemporaneamente, e neppure può liberarsi<br />
contemporaneamente della salute e della malattia. (Gorg. 495e2-9; tr. Zanetto, lievemente<br />
modificata). 3<br />
Non si può essere sani e malati allo stesso tempo e non si può non essere contemporaneamente né in<br />
una condizione di salute né in una condizione di malattia: tertium non datur.<br />
1 Cfr. Symp. 186a3-b2: «ὅτι δὲ οὐ µόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ<br />
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώµασι τῶν πάντων ζῴων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φυοµένοις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι,<br />
καθεωρακέναι µοι δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἡµετέρας τέχνης, ὡς µέγας καὶ θαυµαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τείνει καὶ κατ'<br />
ἀνθρώπινα καὶ κατὰ θεῖα πράγµατα».<br />
2 Symp. 186b4-8: « ἡ γὰρ φύσις τῶν σωµάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει· τὸ γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώµατος καὶ τὸ νοσοῦν<br />
ὁµολογουµένως ἕτερόν τε καὶ ἀνόµοιόν ἐστι, τὸ δὲ ἀνόµοιον ἀνοµοίων ἐπιθυµεῖ καὶ ἐρᾷ. ἄλλος µὲν οὖν ὁ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ<br />
ἔρως, ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει.»<br />
3 Gorg. 495e2-9: « τοὺς εὖ πράττοντας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγῇ πάθος πεπονθέναι; […] Ἆρ' οὖν, εἴπερ<br />
ἐναντία ἐστὶν ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγιείας ἔχει καὶ νόσου; οὐ γὰρ ἅµα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ<br />
νοσεῖ ὁ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἅµα ἀπαλλάττεται ὑγιείας τε καὶ νόσου».