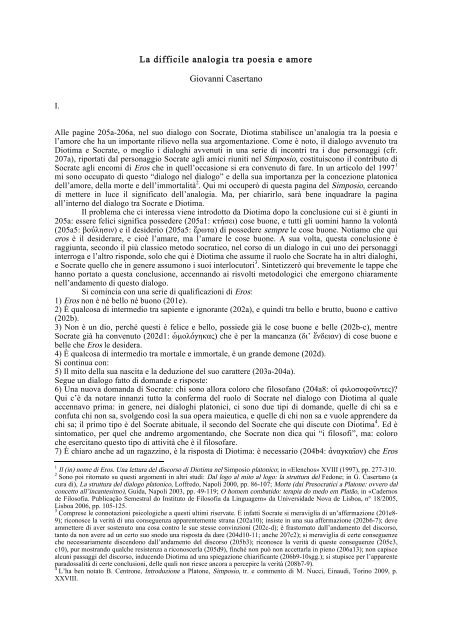You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I.<br />
La difficile analogia tra poesia e amore<br />
Giovanni Casertano<br />
Alle pagine 205a-206a, nel suo dialogo con Socrate, Diotima stabilisce un’analogia tra la poesia e<br />
l’amore che ha un importante rilievo nella sua argomentazione. Come è noto, il dialogo avvenuto tra<br />
Diotima e Socrate, o meglio i dialoghi avvenuti in una serie di incontri tra i due personaggi (cfr.<br />
207a), riportati dal personaggio Socrate agli amici riuniti nel Simposio, costituiscono il contributo di<br />
Socrate agli encomi di Eros che in quell’occasione si era convenuto di fare. In un articolo del 1997 1<br />
mi sono occupato di questo “dialogo nel dialogo” e della sua importanza per la concezione platonica<br />
dell’amore, della morte e dell’immortalità 2 . Qui mi occuperò di questa pagina del Simposio, cercando<br />
di mettere in luce il significato dell’analogia. Ma, per chiarirlo, sarà bene inquadrare la pagina<br />
all’interno del dialogo tra Socrate e Diotima.<br />
Il problema che ci interessa viene introdotto da Diotima dopo la conclusione cui si è giunti in<br />
205a: essere felici significa possedere (205a1: κτήσει) cose buone, e tutti gli uomini hanno la volontà<br />
(205a5: βούλησιν) e il desiderio (205a5: ἔρωτα) di possedere sempre le cose buone. Notiamo che qui<br />
eros è il desiderare, e cioè l’amare, ma l’amare le cose buone. A sua volta, questa conclusione è<br />
raggiunta, secondo il più classico metodo socratico, nel corso di un dialogo in cui uno dei personaggi<br />
interroga e l’altro risponde, solo che qui è Diotima che assume il ruolo che Socrate ha in altri dialoghi,<br />
e Socrate quello che in genere assumono i suoi interlocutori 3 . Sintetizzerò qui brevemente le tappe che<br />
hanno portato a questa conclusione, accennando ai risvolti metodologici che emergono chiaramente<br />
nell’andamento di questo dialogo.<br />
Si comincia con una serie di qualificazioni di Eros:<br />
1) Eros non è né bello né buono (201e).<br />
2) È qualcosa di intermedio tra sapiente e ignorante (202a), e quindi tra bello e brutto, buono e cattivo<br />
(202b).<br />
3) Non è un dio, perché questi è felice e bello, possiede già le cose buone e belle (202b-c), mentre<br />
Socrate già ha convenuto (202d1: ὡµολόγηκας) che è per la mancanza (δι’ ἔνδειαν) di cose buone e<br />
belle che Eros le desidera.<br />
4) È qualcosa di intermedio tra mortale e immortale, è un grande demone (202d).<br />
Si continua con:<br />
5) Il mito della sua nascita e la deduzione del suo carattere (203a-204a).<br />
Segue un dialogo fatto di domande e risposte:<br />
6) Una nuova domanda di Socrate: chi sono allora coloro che filosofano (204a8: οἱ φιλοσοφοῦντες)?<br />
Qui c’è da notare innanzi tutto la conferma del ruolo di Socrate nel dialogo con Diotima al quale<br />
accennavo prima: in genere, nei dialoghi platonici, ci sono due tipi di domande, quelle di chi sa e<br />
confuta chi non sa, svolgendo così la sua opera maieutica, e quelle di chi non sa e vuole apprendere da<br />
chi sa; il primo tipo è del Socrate abituale, il secondo del Socrate che qui discute con Diotima 4 . Ed è<br />
sintomatico, per quel che andremo argomentando, che Socrate non dica qui “i filosofi”, ma: coloro<br />
che esercitano questo tipo di attività che è il filosofare.<br />
7) È chiaro anche ad un ragazzino, è la risposta di Diotima: è necessario (204b4: ἀναγκαῖον) che Eros<br />
1 Il (in) nome di Eros. Una lettura del discorso di Diotima nel Simposio platonico; in «Elenchos» XVIII (1997), pp. 277-310.<br />
2 Sono poi ritornato su questi argomenti in altri studi: Dal logo al mito al logo: la struttura del Fedone; in G. Casertano (a<br />
cura di), La struttura del dialogo platonico, Loffredo, Napoli 2000, pp. 86-107; Morte (dai Presocratici a Platone: ovvero dal<br />
concetto all’incantesimo), Guida, Napoli 2003, pp. 49-119; O homem combatido: terapia do medo em Platão, in «Cadernos<br />
de Filosofia. Publicação Semestral do Instituto de Filosofia da Linguagem» da Universidade Nova de Lisboa, n° 18/2005,<br />
Lisboa 2006, pp. 105-125.<br />
3 Comprese le connotazioni psicologiche a questi ultimi riservate. E infatti Socrate si meraviglia di un’affermazione (201e8-<br />
9); riconosce la verità di una conseguenza apparentemente strana (202a10); insiste in una sua affermazione (202b6-7); deve<br />
ammettere di aver sostenuto una cosa contro le sue stesse convinzioni (202c-d); è frastornato dall’andamento del discorso,<br />
tanto da non avere ad un certo suo snodo una risposta da dare (204d10-11; anche 207c2); si meraviglia di certe conseguenze<br />
che necessariamente discendono dall’andamento del discorso (205b3); riconosce la verità di queste conseguenze (205c3,<br />
c10), pur mostrando qualche resistenza a riconoscerla (205d9), finché non può non accettarla in pieno (206a13); non capisce<br />
alcuni passaggi del discorso, inducendo Diotima ad una spiegazione chiarificante (206b9-10sgg.); si stupisce per l’apparente<br />
paradossalità di certe conclusioni, delle quali non riesce ancora a percepire la verità (208b7-9).<br />
4 L’ha ben notato B. Centrone, Introduzione a Platone, Simposio, tr. e commento di M. Nucci, Einaudi, Torino 2009, p.<br />
XXVIII.