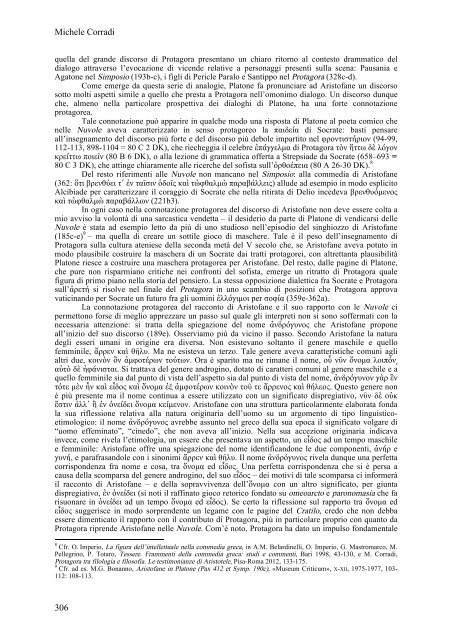You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Michele Corradi<br />
quella del grande discorso di Protagora presentano un chiaro ritorno al contesto drammatico del<br />
dialogo attraverso l’evocazione di vicende relative a personaggi presenti sulla scena: Pausania e<br />
Agatone nel Simposio (193b-c), i figli di Pericle Paralo e Santippo nel Protagora (328c-d).<br />
Come emerge da questa serie di analogie, Platone fa pronunciare ad Aristofane un discorso<br />
sotto molti aspetti simile a quello che presta a Protagora nell’omonimo dialogo. Un discorso dunque<br />
che, almeno nella particolare prospettiva dei dialoghi di Platone, ha una forte connotazione<br />
protagorea.<br />
Tale connotazione può apparire in qualche modo una risposta di Platone al poeta comico che<br />
nelle Nuvole aveva caratterizzato in senso protagoreo la παιδεία di Socrate: basti pensare<br />
all’insegnamento del discorso più forte e del discorso più debole impartito nel φροντιστήριον (94-99,<br />
112-113, 898-1104 = 80 C 2 DK), che riecheggia il celebre ἐπάγγελµα di Protagora τὸν ἥττω δὲ λόγον<br />
κρείττω ποιεῖν (80 B 6 DK), o alla lezione di grammatica offerta a Strepsiade da Socrate (658–693 =<br />
80 C 3 DK), che attinge chiaramente alle ricerche del sofista sull’ὀρθοέπεια (80 A 26-30 DK). 8<br />
Del resto riferimenti alle Nuvole non mancano nel Simposio: alla commedia di Aristofane<br />
(362: ὅτι βρενθύει τ΄ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφθαλµὼ παραβάλλεις) allude ad esempio in modo esplicito<br />
Alcibiade per caratterizzare il coraggio di Socrate che nella ritirata di Delio incedeva βρενθυόµενος<br />
καὶ τὠφθαλµὼ παραβάλλων (221b3).<br />
In ogni caso nella connotazione protagorea del discorso di Aristofane non deve essere colta a<br />
mio avviso la volontà di una sarcastica vendetta – il desiderio da parte di Platone di vendicarsi delle<br />
Nuvole è stata ad esempio letto da più di uno studioso nell’episodio del singhiozzo di Aristofane<br />
(185c-e) 9 – ma quella di creare un sottile gioco di maschere. Tale è il peso dell’insegnamento di<br />
Protagora sulla cultura ateniese della seconda metà del V secolo che, se Aristofane aveva potuto in<br />
modo plausibile costruire la maschera di un Socrate dai tratti protagorei, con altrettanta plausibilità<br />
Platone riesce a costruire una maschera protagorea per Aristofane. Del resto, dalle pagine di Platone,<br />
che pure non risparmiano critiche nei confronti del sofista, emerge un ritratto di Protagora quale<br />
figura di primo piano nella storia del pensiero. La stessa opposizione dialettica fra Socrate e Protagora<br />
sull’ἀρετή si risolve nel finale del Protagora in uno scambio di posizioni che Protagora approva<br />
vaticinando per Socrate un futuro fra gli uomini ἐλλόγιµοι per σοφία (359e-362a).<br />
La connotazione protagorea del racconto di Aristofane e il suo rapporto con le Nuvole ci<br />
permettono forse di meglio apprezzare un passo sul quale gli interpreti non si sono soffermati con la<br />
necessaria attenzione: si tratta della spiegazione del nome ἀνδρόγυνος che Aristofane propone<br />
all’inizio del suo discorso (189e). Osserviamo più da vicino il passo. Secondo Aristofane la natura<br />
degli esseri umani in origine era diversa. Non esistevano soltanto il genere maschile e quello<br />
femminile, ἄρρεν καὶ θῆλυ. Ma ne esisteva un terzo. Tale genere aveva caratteristiche comuni agli<br />
altri due, κοινὸν ὂν ἀµφοτέρων τούτων. Ora è sparito ma ne rimane il nome, οὗ νῦν ὄνοµα λοιπόν͵<br />
αὐτὸ δὲ ἠφάνισται. Si trattava del genere androgino, dotato di caratteri comuni al genere maschile e a<br />
quello femminile sia dal punto di vista dell’aspetto sia dal punto di vista del nome, ἀνδρόγυνον γὰρ ἓν<br />
τότε µὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνοµα ἐξ ἀµφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ θήλεος. Questo genere non<br />
è più presente ma il nome continua a essere utilizzato con un significato dispregiativo, νῦν δὲ οὐκ<br />
ἔστιν ἀλλ΄ ἢ ἐν ὀνείδει ὄνοµα κείµενον. Aristofane con una struttura particolarmente elaborata fonda<br />
la sua riflessione relativa alla natura originaria dell’uomo su un argomento di tipo linguisticoetimologico:<br />
il nome ἀνδρόγυνος avrebbe assunto nel greco della sua epoca il significato volgare di<br />
“uomo effeminato”, “cinedo”, che non aveva all’inizio. Nella sua accezione originaria indicava<br />
invece, come rivela l’etimologia, un essere che presentava un aspetto, un εἶδος ad un tempo maschile<br />
e femminile: Aristofane offre una spiegazione del nome identificandone le due componenti, ἀνήρ e<br />
γυνή, e parafrasandole con i sinonimi ἄρρεν καὶ θῆλυ. Il nome ἀνδρόγυνος rivela dunque una perfetta<br />
corrispondenza fra nome e cosa, tra ὄνοµα ed εἶδος. Una perfetta corrispondenza che si è persa a<br />
causa della scomparsa del genere androgino, del suo εἶδος – dei motivi di tale scomparsa ci informerà<br />
il racconto di Aristofane – e della sopravvivenza dell’ὄνοµα con un altro significato, per giunta<br />
dispregiativo, ἐν ὀνείδει (si noti il raffinato gioco retorico fondato su omeoarcto e paronomasia che fa<br />
risuonare in ὀνείδει ad un tempo ὄνοµα ed εἶδος). Se certo la riflessione sul rapporto tra ὄνοµα ed<br />
εἶδος suggerisce in modo sorprendente un legame con le pagine del Cratilo, credo che non debba<br />
essere dimenticato il rapporto con il contributo di Protagora, più in particolare proprio con quanto da<br />
Protagora riprende Aristofane nelle Nuvole. Com’è noto, Protagora ha dato un impulso fondamentale<br />
8 Cfr. O. Imperio, La figura dell’intellettuale nella commedia greca, in A.M. Belardinelli, O. Imperio, G. Mastromarco, M.<br />
Pellegrino, P. Totaro, Tessere. Frammenti della commedia greca: studi e commenti, Bari 1998, 43-130, e M. Corradi,<br />
Protagora tra filologia e filosofia. Le testimonianze di Aristotele, Pisa-Roma 2012, 133-175.<br />
9 Cfr. ad es. M.G. Bonanno, Aristofane in Platone (Pax 412 et Symp. 190c), «Museum Criticum», X-XII, 1975-1977, 103-<br />
112: 108-113.<br />
306