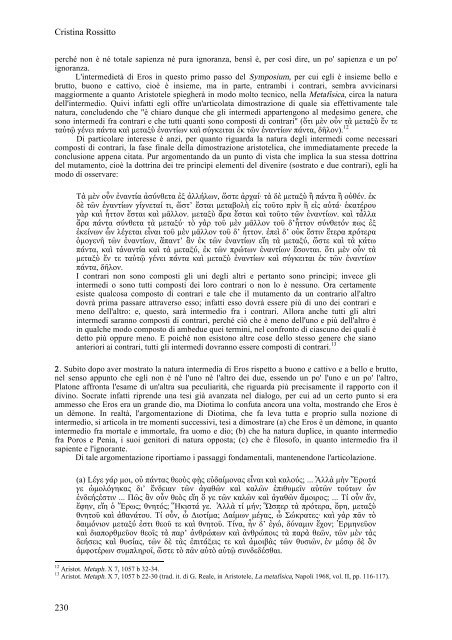Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cristina Rossitto<br />
perché non è né totale sapienza né pura ignoranza, bensì è, per così dire, un po' sapienza e un po'<br />
ignoranza.<br />
L'intermedietà di Eros in questo primo passo del <strong>Symposium</strong>, per cui egli è insieme bello e<br />
brutto, buono e cattivo, cioè è insieme, ma in parte, entrambi i contrari, sembra avvicinarsi<br />
maggiormente a quanto Aristotele spiegherà in modo molto tecnico, nella Metafisica, circa la natura<br />
dell'intermedio. Quivi infatti egli offre un'articolata dimostrazione di quale sia effettivamente tale<br />
natura, concludendo che "è chiaro dunque che gli intermedi appartengono al medesimo genere, che<br />
sono intermedi fra contrari e che tutti quanti sono composti di contrari" (ὅτι µὲν οὖν τὰ µεταξὺ ἔν τε<br />
ταὐτῷ γένει πάντα καὶ µεταξὺ ἐναντίων καὶ σύγκειται ἐκ τῶν ἐναντίων πάντα, δῆλον). 12<br />
Di particolare interesse è anzi, per quanto riguarda la natura degli intermedi come necessari<br />
composti di contrari, la fase finale della dimostrazione aristotelica, che immediatamente precede la<br />
conclusione appena citata. Pur argomentando da un punto di vista che implica la sua stessa dottrina<br />
del mutamento, cioè la dottrina dei tre princìpi elementi del divenire (sostrato e due contrari), egli ha<br />
modo di osservare:<br />
230<br />
Τὰ µὲν οὖν ἐναντία ἀσύνθετα ἐξ ἀλλήλων, ὥστε ἀρχαί· τὰ δὲ µεταξὺ ἢ πάντα ἢ οὐθέν. ἐκ<br />
δὲ τῶν ἐναντίων γίγνεταί τι, ὥστ’ ἔσται µεταβολὴ εἰς τοῦτο πρὶν ἢ εἰς αὐτά· ἑκατέρου<br />
γὰρ καὶ ἧττον ἔσται καὶ µᾶλλον. µεταξὺ ἄρα ἔσται καὶ τοῦτο τῶν ἐναντίων. καὶ τἆλλα<br />
ἄρα πάντα σύνθετα τὰ µεταξύ· τὸ γὰρ τοῦ µὲν µᾶλλον τοῦ δ’ἧττον σύνθετόν πως ἐξ<br />
ἐκείνων ὧν λέγεται εἶναι τοῦ µὲν µᾶλλον τοῦ δ’ ἧττον. ἐπεὶ δ’ οὐκ ἔστιν ἕτερα πρότερα<br />
ὁµογενῆ τῶν ἐναντίων, ἅπαντ’ ἂν ἐκ τῶν ἐναντίων εἴη τὰ µεταξύ, ὥστε καὶ τὰ κάτω<br />
πάντα, καὶ τἀναντία καὶ τὰ µεταξύ, ἐκ τῶν πρώτων ἐναντίων ἔσονται. ὅτι µὲν οὖν τὰ<br />
µεταξὺ ἔν τε ταὐτῷ γένει πάντα καὶ µεταξὺ ἐναντίων καὶ σύγκειται ἐκ τῶν ἐναντίων<br />
πάντα, δῆλον.<br />
I contrari non sono composti gli uni degli altri e pertanto sono princìpi; invece gli<br />
intermedi o sono tutti composti dei loro contrari o non lo è nessuno. Ora certamente<br />
esiste qualcosa composto di contrari e tale che il mutamento da un contrario all'altro<br />
dovrà prima passare attraverso esso; infatti esso dovrà essere più di uno dei contrari e<br />
meno dell'altro: e, questo, sarà intermedio fra i contrari. Allora anche tutti gli altri<br />
intermedi saranno composti di contrari, perché ciò che è meno dell'uno e più dell'altro è<br />
in qualche modo composto di ambedue quei termini, nel confronto di ciascuno dei quali è<br />
detto più oppure meno. E poiché non esistono altre cose dello stesso genere che siano<br />
anteriori ai contrari, tutti gli intermedi dovranno essere composti di contrari. 13<br />
2. Subito dopo aver mostrato la natura intermedia di Eros rispetto a buono e cattivo e a bello e brutto,<br />
nel senso appunto che egli non è né l'uno né l'altro dei due, essendo un po' l'uno e un po' l'altro,<br />
Platone affronta l'esame di un'altra sua peculiarità, che riguarda più precisamente il rapporto con il<br />
divino. Socrate infatti riprende una tesi già avanzata nel dialogo, per cui ad un certo punto si era<br />
ammesso che Eros era un grande dio, ma Diotima lo confuta ancora una volta, mostrando che Eros è<br />
un dèmone. In realtà, l'argomentazione di Diotima, che fa leva tutta e proprio sulla nozione di<br />
intermedio, si articola in tre momenti successivi, tesi a dimostrare (a) che Eros è un dèmone, in quanto<br />
intermedio fra mortale e immortale, fra uomo e dio; (b) che ha natura duplice, in quanto intermedio<br />
fra Poros e Penia, i suoi genitori di natura opposta; (c) che è filosofo, in quanto intermedio fra il<br />
sapiente e l'ignorante.<br />
Di tale argomentazione riportiamo i passaggi fondamentali, mantenendone l'articolazione.<br />
(a) Lέγε γάρ µοι, οὐ πάντας θεοὺς φῂς εὐδαίµονας εἶναι καὶ καλούς; ... Ἀλλὰ µὴν Ἔρωτά<br />
γε ὡµολόγηκας δι’ ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυµεῖν αὐτῶν τούτων ὧν<br />
ἐνδεήςἐστιν ... Πῶς ἂν οὖν θεὸς εἴη ὅ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄµοιρος; ... Τί οὖν ἄν,<br />
ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως; θνητός; Ἥκιστά γε. Ἀλλὰ τί µήν; Ὥσπερ τὰ πρότερα, ἔφη, µεταξὺ<br />
θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί οὖν, ὦ Διοτίµα; Δαίµων µέγας, ὦ Σώκρατες· καὶ γὰρ πᾶν τὸ<br />
δαιµόνιον µεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ’ ἐγώ, δύναµιν ἔχον; Ἑρµηνεῦον<br />
καὶ διαπορθµεῦον θεοῖς τὰ παρ’ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν, τῶν µὲν τὰς<br />
δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε καὶ ἀµοιβὰς τῶν θυσιῶν, ἐν µέσῳ δὲ ὂν<br />
ἀµφοτέρων συµπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συνδεδέσθαι.<br />
12 Aristot. Metaph. X 7, 1057 b 32-34.<br />
13 Aristot. Metaph. X 7, 1057 b 22-30 (trad. it. di G. Reale, in Aristotele, La metafisica, Napoli 1968, vol. II, pp. 116-117).