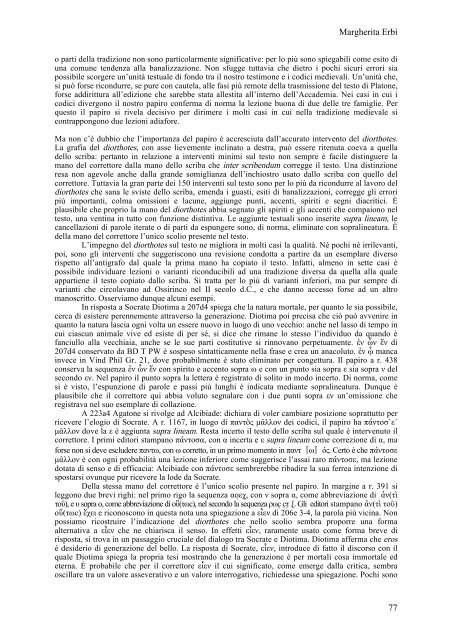You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Margherita Erbì<br />
o parti della tradizione non sono particolarmente significative: per lo più sono spiegabili come esito di<br />
una comune tendenza alla banalizzazione. Non sfugge tuttavia che dietro i pochi sicuri errori sia<br />
possibile scorgere un’unità testuale di fondo tra il nostro testimone e i codici medievali. Un’unità che,<br />
si può forse ricondurre, se pure con cautela, alle fasi più remote della trasmissione del testo di Platone,<br />
forse addirittura all’edizione che sarebbe stata allestita all’interno dell’Accademia. Nei casi in cui i<br />
codici divergono il nostro papiro conferma di norma la lezione buona di due delle tre famiglie. Per<br />
questo il papiro si rivela decisivo per dirimere i molti casi in cui nella tradizione medievale si<br />
contrappongono due lezioni adiafore.<br />
Ma non c’è dubbio che l’importanza del papiro è accresciuta dall’accurato intervento del diorthotes.<br />
La grafia del diorthotes, con asse lievemente inclinato a destra, può essere ritenuta coeva a quella<br />
dello scriba: pertanto in relazione a interventi minimi sul testo non sempre è facile distinguere la<br />
mano del correttore dalla mano dello scriba che inter scribendum corregge il testo. Una distinzione<br />
resa non agevole anche dalla grande somiglianza dell’inchiostro usato dallo scriba con quello del<br />
correttore. Tuttavia la gran parte dei 150 interventi sul testo sono per lo più da ricondurre al lavoro del<br />
diorthotes che sana le sviste dello scriba, emenda i guasti, esiti di banalizzazioni, corregge gli errori<br />
più importanti, colma omissioni e lacune, aggiunge punti, accenti, spiriti e segni diacritici. È<br />
plausibile che proprio la mano del diorthotes abbia segnato gli spiriti e gli accenti che compaiono nel<br />
testo, una ventina in tutto con funzione distintiva. Le aggiunte testuali sono inserite supra lineam, le<br />
cancellazioni di parole iterate o di parti da espungere sono, di norma, eliminate con sopralineatura. È<br />
della mano del correttore l’unico scolio presente nel testo.<br />
L’impegno del diorthotes sul testo ne migliora in molti casi la qualità. Né pochi né irrilevanti,<br />
poi, sono gli interventi che suggeriscono una revisione condotta a partire da un esemplare diverso<br />
rispetto all’antigrafo dal quale la prima mano ha copiato il testo. Infatti, almeno in sette casi è<br />
possibile individuare lezioni o varianti riconducibili ad una tradizione diversa da quella alla quale<br />
appartiene il testo copiato dallo scriba. Si tratta per lo più di varianti inferiori, ma pur sempre di<br />
varianti che circolavano ad Ossirinco nel II secolo d.C., e che danno accesso forse ad un altro<br />
manoscritto. Osserviamo dunque alcuni esempi.<br />
In risposta a Socrate Diotima a 207d4 spiega che la natura mortale, per quanto le sia possibile,<br />
cerca di esistere perennemente attraverso la generazione. Diotima poi precisa che ciò può avvenire in<br />
quanto la natura lascia ogni volta un essere nuovo in luogo di uno vecchio: anche nel lasso di tempo in<br />
cui ciascun animale vive ed esiste di per sé, si dice che rimane lo stesso l’individuo da quando è<br />
fanciullo alla vecchiaia, anche se le sue parti costitutive si rinnovano perpetuamente. ἐν ὧν ἕν di<br />
207d4 conservato da BD T PW è sospeso sintatticamente nella frase e crea un anacoluto. ἐν ᾧ manca<br />
invece in Vind Phil Gr. 21, dove probabilmente è stato eliminato per congettura. Il papiro a r. 438<br />
conserva la sequenza ἐν ὧν ἕν con spirito e accento sopra ω e con un punto sia sopra ε sia sopra ν del<br />
secondo εν. Nel papiro il punto sopra la lettera è registrato di solito in modo incerto. Di norma, come<br />
si è visto, l’espunzione di parole e passi più lunghi è indicata mediante sopralineatura. Dunque è<br />
plausibile che il correttore qui abbia voluto segnalare con i due punti sopra εν un’omissione che<br />
registrava nel suo esemplare di collazione.<br />
A 223a4 Agatone si rivolge ad Alcibiade: dichiara di voler cambiare posizione soprattutto per<br />
ricevere l’elogio di Socrate. A r. 1167, in luogo di παντὸς µᾶλλον dei codici, il papiro ha πάντοσ`ε´<br />
µᾶλλον dove la ε è aggiunta supra lineam. Resta incerto il testo dello scriba sul quale è intervenuto il<br />
correttore. I primi editori stampano πάντοσα, con α incerta e ε supra lineam come correzione di α, ma<br />
forse non si deve escludere παντω, con ω corretto, in un primo momento in παντ〚ω〛ός. Certo è che πάντοσε<br />
µᾶλλον è con ogni probabilità una lezione inferiore come suggerisce l’assai raro πάντοσε, ma lezione<br />
dotata di senso e di efficacia: Alcibiade con πάντοσε sembrerebbe ribadire la sua ferrea intenzione di<br />
spostarsi ovunque pur ricevere la lode da Socrate.<br />
Della stessa mano del correttore è l’unico scolio presente nel papiro. In margine a r. 391 si<br />
leggono due brevi righi: nel primo rigo la sequenza αο̣εχ̣, con ν sopra α, come abbreviazione di ἀν(τὶ<br />
τοῦ), e υ sopra ο, come abbreviazione di οὕ(τωϲ), nel secondo la sequenza ρωϲ̣ ϲ̣τ̣ .[. Gli editori stampano ἀν(τὶ τοῦ)<br />
οὕ(τωϲ) ἔχει e riconoscono in questa nota una spiegazione a εἶεν di 206e 3-4, la parola più vicina. Non<br />
possiamo ricostruire l’indicazione del diorthotes che nello scolio sembra proporre una forma<br />
alternativa a εἶεν che ne chiarisca il senso. In effetti εἶεν, raramente usato come forma breve di<br />
risposta, si trova in un passaggio cruciale del dialogo tra Socrate e Diotima. Diotima afferma che eros<br />
è desiderio di generazione del bello. La risposta di Socrate, εἶεν, introduce di fatto il discorso con il<br />
quale Diotima spiega la propria tesi mostrando che la generazione è per mortali cosa immortale ed<br />
eterna. È probabile che per il correttore εἶεν il cui significato, come emerge dalla critica, sembra<br />
oscillare tra un valore asseverativo e un valore interrogativo, richiedesse una spiegazione. Pochi sono<br />
77