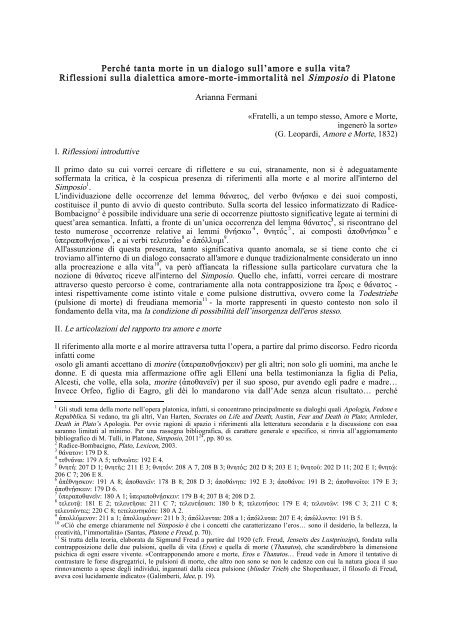Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Perché tanta morte in un dialogo sull’amore e sulla vita?<br />
Riflessioni sulla dialettica amore-morte-immortalità nel Simposio di Platone<br />
I. Riflessioni introduttive<br />
Arianna Fermani<br />
«Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte,<br />
ingenerò la sorte»<br />
(G. Leopardi, Amore e Morte, 1832)<br />
Il primo dato su cui vorrei cercare di riflettere e su cui, stranamente, non si è adeguatamente<br />
soffermata la critica, è la cospicua presenza di riferimenti alla morte e al morire all'interno del<br />
Simposio 1 .<br />
L'individuazione delle occorrenze del lemma θάνατος, del verbo θνήσκω e dei suoi composti,<br />
costituisce il punto di avvio di questo contributo. Sulla scorta del lessico informatizzato di Radice-<br />
Bombacigno 2 è possibile individuare una serie di occorrenze piuttosto significative legate ai termini di<br />
quest’area semantica. Infatti, a fronte di un’unica occorrenza del lemma θάνατος 3 , si riscontrano del<br />
testo numerose occorrenze relative ai lemmi θνήσκω 4 , θνητός 5 , ai composti ἀποθνήσκω 6 e<br />
ὑπεραποθνῄσκω 7 , e ai verbi τελευτάω 8 e ἀπόλλυµι 9 .<br />
All'assunzione di questa presenza, tanto significativa quanto anomala, se si tiene conto che ci<br />
troviamo all'interno di un dialogo consacrato all'amore e dunque tradizionalmente considerato un inno<br />
alla procreazione e alla vita 10 , va però affiancata la riflessione sulla particolare curvatura che la<br />
nozione di θάνατος riceve all'interno del Simposio. Quello che, infatti, vorrei cercare di mostrare<br />
attraverso questo percorso è come, contrariamente alla nota contrapposizione tra ἔρως e θάνατος -<br />
intesi rispettivamente come istinto vitale e come pulsione distruttiva, ovvero come la Todestriebe<br />
(pulsione di morte) di freudiana memoria 11 - la morte rappresenti in questo contesto non solo il<br />
fondamento della vita, ma la condizione di possibilità dell’insorgenza dell'eros stesso.<br />
II. Le articolazioni del rapporto tra amore e morte<br />
Il riferimento alla morte e al morire attraversa tutta l’opera, a partire dal primo discorso. Fedro ricorda<br />
infatti come<br />
«solo gli amanti accettano di morire (ὑπεραποθνῄσκειν) per gli altri; non solo gli uomini, ma anche le<br />
donne. E di questa mia affermazione offre agli Elleni una bella testimonianza la figlia di Pelia,<br />
Alcesti, che volle, ella sola, morire (ἀποθανεῖν) per il suo sposo, pur avendo egli padre e madre…<br />
Invece Orfeo, figlio di Eagro, gli dèi lo mandarono via dall’Ade senza alcun risultato… perché<br />
1 Gli studi tema della morte nell’opera platonica, infatti, si concentrano principalmente su dialoghi quali Apologia, Fedone e<br />
Repubblica. Si vedano, tra gli altri, Van Harten, Socrates on Life and Death; Austin, Fear and Death in Plato; Armleder,<br />
Death in Plato’s Apologia. Per ovvie ragioni di spazio i riferimenti alla letteratura secondaria e la discussione con essa<br />
saranno limitati al minimo. Per una rassegna bibliografica, di carattere generale e specifico, si rinvia all’aggiornamento<br />
bibliografico di M. Tulli, in Platone, Simposio, 2011 24 , pp. 80 ss.<br />
2 Radice-Bombacigno, Plato, Lexicon, 2003.<br />
3 θάνατον: 179 D 8.<br />
4 τεθνάναι: 179 A 5; τεθνεῶτε: 192 E 4.<br />
5 θνητή: 207 D 1; θνητῆς: 211 E 3; θνητόν: 208 A 7, 208 B 3; θνητός: 202 D 8; 203 E 1; θνητοῦ: 202 D 11; 202 E 1; θνητῷ:<br />
206 C 7; 206 E 8.<br />
6 ἀπέθνῃσκον: 191 A 8; ἀποθανεῖν: 178 B 8; 208 D 3; ἀποθάνητε: 192 E 3; ἀποθάνοι: 191 B 2; ἀποθανοῖτο: 179 E 3;<br />
ἀποθνῄσκειν: 179 D 6.<br />
7 ὑπεραποθανεῖν: 180 A 1; ὑπεραποθνῄσκειν: 179 B 4; 207 B 4; 208 D 2.<br />
8 τελευτᾷ: 181 E 2; τελευτῆσαι: 211 C 7; τελευτήσασι: 180 b 8; τελευτήσοι: 179 E 4; τελευτῶν: 198 C 3; 211 C 8;<br />
τελευτῶντες: 220 C 8; τετελευτηκότι: 180 A 2.<br />
9 ἀπολλύµενον: 211 a 1; ἀπολλυµένων: 211 b 3; ἀπόλλυνται: 208 a 1; ἀπόλλυται: 207 E 4; ἀπώλλυντο: 191 B 5.<br />
10 «Ciò che emerge chiaramente nel Simposio è che i concetti che caratterizzano l’eros… sono il desiderio, la bellezza, la<br />
creatività, l’immortalità» (Santas, Platone e Freud, p. 70).<br />
11 Si tratta della teoria, elaborata da Sigmund Freud a partire dal 1920 (cfr. Freud, Jenseits des Lustprinzips), fondata sulla<br />
contrapposizione delle due pulsioni, quella di vita (Eros) e quella di morte (Thanatos), che scandirebbero la dimensione<br />
psichica di ogni essere vivente. «Contrapponendo amore e morte, Eros e Thanatos… Freud vede in Amore il tentativo di<br />
contrastare le forse disgregatrici, le pulsioni di morte, che altro non sono se non le cadenze con cui la natura gioca il suo<br />
rinnovamento a spese degli individui, ingannati dalla cieca pulsione (blinder Trieb) che Shopenhauer, il filosofo di Freud,<br />
aveva così lucidamente indicato» (Galimberti, Idee, p. 19).