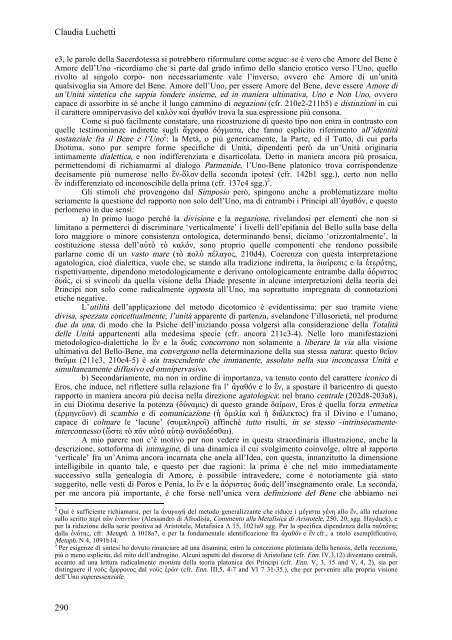You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Claudia Luchetti<br />
e3, le parole della Sacerdotessa si potrebbero riformulare come segue: se è vero che Amore del Bene è<br />
Amore dell’Uno -ricordiamo che si parte dal grado infimo dello slancio erotico verso l’Uno, quello<br />
rivolto al singolo corpo- non necessariamente vale l’inverso, ovvero che Amore di un’unità<br />
qualsivoglia sia Amore del Bene. Amore dell’Uno, per essere Amore del Bene, deve essere Amore di<br />
un’Unità sintetica che sappia fondere insieme, ed in maniera ultimativa, Uno e Non Uno, ovvero<br />
capace di assorbire in sé anche il lungo cammino di negazioni (cfr. 210e2-211b5) e distinzioni in cui<br />
il carattere omnipervasivo del καλὸν καὶ ἀγαθόν trova la sua espressione più consona.<br />
Come si può facilmente constatare, una ricostruzione di questo tipo non entra in contrasto con<br />
quelle testimonianze indirette sugli ἄγραφα δόγµατα, che fanno esplicito riferimento all’identità<br />
sostanziale fra il Bene e l’Uno 2 : la Metà, o più genericamente, la Parte, ed il Tutto, di cui parla<br />
Diotima, sono pur sempre forme specifiche di Unità, dipendenti però da un’Unità originaria<br />
intimamente dialettica, e non indifferenziata e disarticolata. Detto in maniera ancora più prosaica,<br />
permettendomi di richiamarmi al dialogo Parmenide, l’Uno-Bene platonico trova corrispondenze<br />
decisamente più numerose nello ἕν-ὅλον della seconda ipotesi (cfr. 142b1 sgg.), certo non nello<br />
ἕν indifferenziato ed inconoscibile della prima (cfr. 137c4 sgg.) 3 .<br />
Gli stimoli che provengono dal Simposio però, spingono anche a problematizzare molto<br />
seriamente la questione del rapporto non solo dell’Uno, ma di entrambi i Principi all’ἀγαθόν, e questo<br />
perlomeno in due sensi:<br />
a) In primo luogo perché la divisione e la negazione, rivelandosi per elementi che non si<br />
limitano a permetterci di discriminare ‘verticalmente’ i livelli dell’epifania del Bello sulla base della<br />
loro maggiore o minore consistenza ontologica, determinando bensì, diciamo ‘orizzontalmente’, la<br />
costituzione stessa dell’αὐτὸ τὸ καλόν, sono proprio quelle componenti che rendono possibile<br />
parlarne come di un vasto mare (τὸ πολὺ πέλαγος, 210d4). Coerenza con questa interpretazione<br />
agatologica, cioè dialettica, vuole che, se stando alla tradizione indiretta, la διαίρεσις e la ἑτερότης,<br />
rispettivamente, dipendono metodologicamente e derivano ontologicamente entrambe dalla ἀόριστος<br />
δυάς, ci si svincoli da quella visione della Diade presente in alcune interpretazioni della teoria dei<br />
Principi non solo come radicalmente opposta all’Uno, ma soprattutto impregnata di connotazioni<br />
etiche negative.<br />
L’utilità dell’applicazione del metodo dicotomico è evidentissima: per suo tramite viene<br />
divisa, spezzata concettualmente, l’unità apparente di partenza, svelandone l’illusorietà, nel produrne<br />
due da una, di modo che la Psiche dell’iniziando possa volgersi alla considerazione della Totalità<br />
delle Unità appartenenti alla medesima specie (cfr. ancora 211c3-4). Nelle loro manifestazioni<br />
metodologico-dialettiche lo ἕν e la δυάς concorrono non solamente a liberare la via alla visione<br />
ultimativa del Bello-Bene, ma convergono nella determinazione della sua stessa natura: questo θεῖον<br />
θαῦµα (211e3, 210e4-5) è sia trascendente che immanente, assoluto nella sua inconcussa Unità e<br />
simultaneamente diffusivo ed omnipervasivo.<br />
b) Secondariamente, ma non in ordine di importanza, va tenuto conto del carattere iconico di<br />
Eros, che induce, nel riflettere sulla relazione fra l’ ἀγαθόν e lo ἕν, a spostare il baricentro di questo<br />
rapporto in maniera ancora più decisa nella direzione agatologica: nel brano centrale (202d8-203a8),<br />
in cui Diotima descrive la potenza (δύναµις) di questo grande δαίµων, Eros è quella forza ermetica<br />
(ἑρµηνεῦον) di scambio e di comunicazione (ἡ ὁµιλία καὶ ἡ διάλεκτος) fra il Divino e l’umano,<br />
capace di colmare le ‘lacune’ (συµπληροῖ) affinché tutto risulti, in se stesso -intrinsecamente-<br />
interconnesso (ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συνδεδέσθαι).<br />
A mio parere non c’è motivo per non vedere in questa straordinaria illustrazione, anche la<br />
descrizione, sottoforma di immagine, di una dinamica il cui svolgimento coinvolge, oltre al rapporto<br />
‘verticale’ fra un’Anima ancora incarnata che anela all’Idea, con questa, innanzitutto la dimensione<br />
intelligibile in quanto tale, e questo per due ragioni: la prima è che nel mito immediatamente<br />
successivo sulla genealogia di Amore, è possibile intravedere, come è notoriamente già stato<br />
suggerito, nelle vesti di Poros e Penia, lo ἕν e la ἀόριστος δυάς dell’insegnamento orale. La seconda,<br />
per me ancora più importante, è che forse nell’unica vera definizione del Bene che abbiamo nei<br />
2 Qui è sufficiente richiamarsi, per la ἀναγωγή del metodo generalizzante che riduce i µέγιστα γένη allo ἕν, alla relazione<br />
sullo scritto περὶ τῶν ἐναντίων (Alessandro di Afrodisia, Commento alla Metafisica di Aristotele, 250, 20, sgg. Hayduck), e<br />
per la riduzione della serie positiva ad Aristotele, Metafisica Δ 15, 1021a9 sgg. Per la specifica dipendenza della ταὐτότης<br />
dalla ἑνότης, cfr. Metaph. Δ 1018a7, e per la fondamentale identificazione fra ἀγαθόν e ἕν cfr., a titolo esemplificativo,<br />
Metaph. Ν 4, 1091b14.<br />
3 Per esigenze di sintesi ho dovuto rinunciare ad una disamina, entro la concezione plotiniana della henosis, della recezione,<br />
più o meno esplicita, del mito dell’androgino. Alcuni aspetti del discorso di Aristofane (cfr. Enn. IV,3,12) diventano centrali,<br />
accanto ad una lettura radicalmente monista della teoria platonica dei Principi (cfr. Enn. V, 3, 15 and V, 4, 2), sia per<br />
distinguere il νοῦς ἔµφρονος dal νοῦς ἐρῶν (cfr. Enn. III,5, 4-7 and VI 7 31-35.), che per pervenire alla propria visione<br />
dell’Uno superessenziale.<br />
290