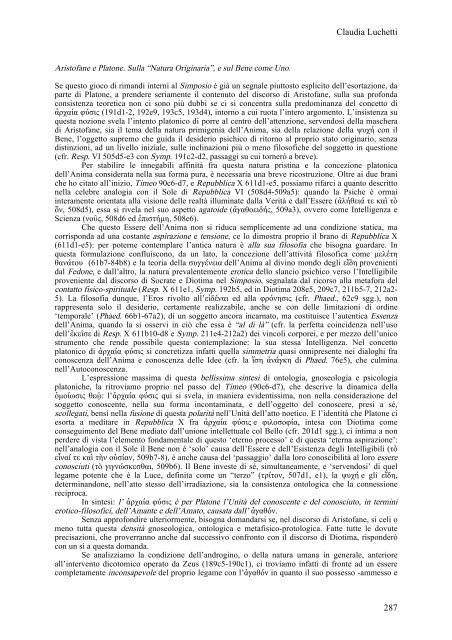You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Aristofane e Platone. Sulla “Natura Originaria”, e sul Bene come Uno.<br />
Claudia Luchetti<br />
Se questo gioco di rimandi interni al Simposio è già un segnale piuttosto esplicito dell’esortazione, da<br />
parte di Platone, a prendere seriamente il contenuto del discorso di Aristofane, sulla sua profonda<br />
consistenza teoretica non ci sono più dubbi se ci si concentra sulla predominanza del concetto di<br />
ἀρχαία φύσις (191d1-2, 192e9, 193c5, 193d4), intorno a cui ruota l’intero argomento. L’insistenza su<br />
questa nozione svela l’intento platonico di porre al centro dell’attenzione, servendosi della maschera<br />
di Aristofane, sia il tema della natura primigenia dell’Anima, sia della relazione della ψυχή con il<br />
Bene, l’oggetto supremo che guida il desiderio psichico di ritorno al proprio stato originario, senza<br />
distinzioni, ad un livello iniziale, sulle inclinazioni più o meno filosofiche del soggetto in questione<br />
(cfr. Resp. VI 505d5-e3 con Symp. 191c2-d2, passaggi su cui tornerò a breve).<br />
Per stabilire le innegabili affinità fra questa natura pristina e la concezione platonica<br />
dell’Anima considerata nella sua forma pura, è necessaria una breve ricostruzione. Oltre ai due brani<br />
che ho citato all’inizio, Timeo 90c6-d7, e Repubblica X 611d1-e5, possiamo rifarci a quanto descritto<br />
nella celebre analogia con il Sole di Repubblica VI (508d4-509a5): quando la Psiche è ormai<br />
interamente orientata alla visione delle realtà illuminate dalla Verità e dall’Essere (ἀλήθειά τε καὶ τὸ<br />
ὄν, 508d5), essa si rivela nel suo aspetto agatoide (ἀγαθοειδής, 509a3), ovvero come Intelligenza e<br />
Scienza (νοῦς, 508d6 ed ἐπιστήµη, 508e6).<br />
Che questo Essere dell’Anima non si riduca semplicemente ad una condizione statica, ma<br />
corrisponda ad una costante aspirazione e tensione, ce lo dimostra proprio il brano di Repubblica X<br />
(611d1-e5): per poterne contemplare l’antica natura è alla sua filosofia che bisogna guardare. In<br />
questa formulazione confluiscono, da un lato, la concezione dell’attività filosofica come µελέτη<br />
θανάτου (61b7-84b8) e la teoria della συγγένεια dell’Anima al divino mondo degli εἴδη provenienti<br />
dal Fedone, e dall’altro, la natura prevalentemente erotica dello slancio psichico verso l’Intelligibile<br />
proveniente dal discorso di Socrate e Diotima nel Simposio, segnalata dal ricorso alla metafora del<br />
contatto fisico-spirituale (Resp. X 611e1, Symp. 192b5, ed in Diotima 208e5, 209c7, 211b5-7, 212a2-<br />
5). La filosofia dunque, l’Eros rivolto all’εἰδέναι ed alla φρόνησις (cfr. Phaed., 62c9 sgg.), non<br />
rappresenta solo il desiderio, certamente realizzabile, anche se con delle limitazioni di ordine<br />
‘temporale’ (Phaed. 66b1-67a2), di un soggetto ancora incarnato, ma costituisce l’autentica Essenza<br />
dell’Anima, quando la si osservi in ciò che essa è “al di là” (cfr. la perfetta coincidenza nell’uso<br />
dell’ἐκεῖσε di Resp. X 611b10-d8 e Symp. 211e4-212a2) dei vincoli corporei, e per mezzo dell’unico<br />
strumento che rende possibile questa contemplazione: la sua stessa Intelligenza. Nel concetto<br />
platonico di ἀρχαία φύσις si concretizza infatti quella simmetria quasi onnipresente nei dialoghi fra<br />
conoscenza dell’Anima e conoscenza delle Idee (cfr. la ἴση ἀνάγκη di Phaed. 76e5), che culmina<br />
nell’Autoconoscenza.<br />
L’espressione massima di questa bellissima sintesi di ontologia, gnoseologia e psicologia<br />
platoniche, la ritroviamo proprio nel passo del Timeo (90c6-d7), che descrive la dinamica della<br />
ὁµοίωσις θεῷ: l’ἀρχαία φύσις qui si svela, in maniera evidentissima, non nella considerazione del<br />
soggetto conoscente, nella sua forma incontaminata, e dell’oggetto del conoscere, presi a sé,<br />
scollegati, bensì nella fusione di questa polarità nell’Unità dell’atto noetico. E l’identità che Platone ci<br />
esorta a meditare in Repubblica X fra ἀρχαία φύσις e φιλοσοφία, intesa con Diotima come<br />
conseguimento del Bene mediato dall’unione intellettuale col Bello (cfr. 201d1 sgg.), ci intima a non<br />
perdere di vista l’elemento fondamentale di questo ‘eterno processo’ e di questa ‘eterna aspirazione’:<br />
nell’analogia con il Sole il Bene non è ‘solo’ causa dell’Essere e dell’Esistenza degli Intelligibili (τὸ<br />
εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν, 509b7-8), è anche causa del ‘passaggio’ dalla loro conoscibilità al loro essere<br />
conosciuti (τὸ γιγνώσκεσθαι, 509b6). Il Bene investe di sé, simultaneamente, e ‘servendosi’ di quel<br />
legame potente che è la Luce, definita come un “terzo” (τρίτον, 507d1, e1), la ψυχή e gli εἴδη,<br />
determinandone, nell’atto stesso dell’irradiazione, sia la consistenza ontologica che la connessione<br />
reciproca.<br />
In sintesi: l’ ἀρχαία φύσις è per Platone l’Unità del conoscente e del conosciuto, in termini<br />
erotico-filosofici, dell’Amante e dell’Amato, causata dall’ ἀγαθόν.<br />
Senza approfondire ulteriormente, bisogna domandarsi se, nel discorso di Aristofane, si celi o<br />
meno tutta questa densità gnoseologica, ontologica e metafisico-protologica. Fatte tutte le dovute<br />
precisazioni, che proverranno anche dal successivo confronto con il discorso di Diotima, risponderò<br />
con un sì a questa domanda.<br />
Se analizziamo la condizione dell’androgino, o della natura umana in generale, anteriore<br />
all’intervento dicotomico operato da Zeus (189c5-190c1), ci troviamo infatti di fronte ad un essere<br />
completamente inconsapevole del proprio legame con l’ἀγαθόν in quanto il suo possesso -ammesso e<br />
287