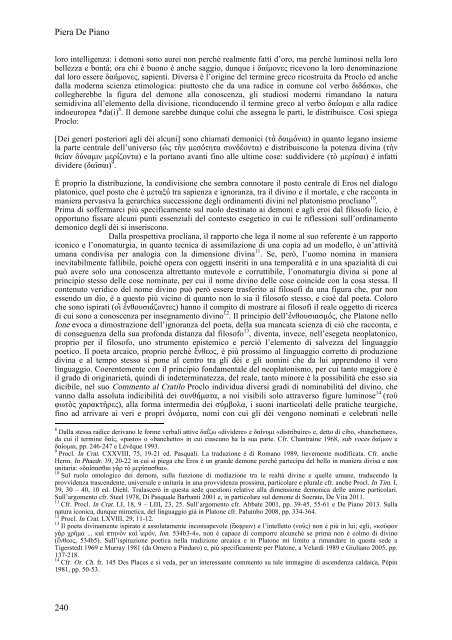You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Piera De Piano<br />
loro intelligenza: i demoni sono aurei non perché realmente fatti d’oro, ma perché luminosi nella loro<br />
bellezza e bontà; ora chi è buono è anche saggio, dunque i δαίµονες ricevono la loro denominazione<br />
dal loro essere δαήµονες, sapienti. Diversa è l’origine del termine greco ricostruita da Proclo ed anche<br />
dalla moderna scienza etimologica: piuttosto che da una radice in comune col verbo διδάσκω, che<br />
collegherebbe la figura del demone alla conoscenza, gli studiosi moderni rimandano la natura<br />
semidivina all’elemento della divisione, riconducendo il termine greco al verbo δαίοµαι e alla radice<br />
indoeuropea *da(i) 8 . Il demone sarebbe dunque colui che assegna le parti, le distribuisce. Così spiega<br />
Proclo:<br />
[Dei generi posteriori agli dèi alcuni] sono chiamati demonici (τὰ δαιµόνια) in quanto legano insieme<br />
la parte centrale dell’universo (ὡς τὴν µεσότητα συνδέοντα) e distribuiscono la potenza divina (τὴν<br />
θείαν δύναµιν µερίζοντα) e la portano avanti fino alle ultime cose: suddividere (τὸ µερίσαι) è infatti<br />
dividere (δαῖσαι) 9 .<br />
È proprio la distribuzione, la condivisione che sembra connotare il posto centrale di Eros nel dialogo<br />
platonico, quel posto che è µεταξύ tra sapienza e ignoranza, tra il divino e il mortale, e che racconta in<br />
maniera pervasiva la gerarchica successione degli ordinamenti divini nel platonismo procliano 10 .<br />
Prima di soffermarci più specificamente sul ruolo destinato ai demoni e agli eroi dal filosofo licio, è<br />
opportuno fissare alcuni punti essenziali del contesto esegetico in cui le riflessioni sull’ordinamento<br />
demonico degli dèi si inseriscono.<br />
Dalla prospettiva procliana, il rapporto che lega il nome al suo referente è un rapporto<br />
iconico e l’onomaturgia, in quanto tecnica di assimilazione di una copia ad un modello, è un’attività<br />
umana condivisa per analogia con la dimensione divina 11 . Se, però, l’uomo nomina in maniera<br />
inevitabilmente fallibile, poiché opera con oggetti inseriti in una temporalità e in una spazialità di cui<br />
può avere solo una conoscenza altrettanto mutevole e corruttibile, l’onomaturgia divina si pone al<br />
principio stesso delle cose nominate, per cui il nome divino delle cose coincide con la cosa stessa. Il<br />
contenuto veridico del nome divino può però essere trasferito ai filosofi da una figura che, pur non<br />
essendo un dio, è a questo più vicino di quanto non lo sia il filosofo stesso, e cioè dal poeta. Coloro<br />
che sono ispirati (oi̔ ἐνθουσιάζοντες) hanno il compito di mostrare ai filosofi il reale oggetto di ricerca<br />
di cui sono a conoscenza per insegnamento divino 12 . Il principio dell’ἐνθουσιασµός, che Platone nello<br />
Ione evoca a dimostrazione dell’ignoranza del poeta, della sua mancata scienza di ciò che racconta, e<br />
di conseguenza della sua profonda distanza dal filosofo 13 , diventa, invece, nell’esegeta neoplatonico,<br />
proprio per il filosofo, uno strumento epistemico e perciò l’elemento di salvezza del linguaggio<br />
poetico. Il poeta arcaico, proprio perché ἔνθεος, è più prossimo al linguaggio corretto di produzione<br />
divina e al tempo stesso si pone al centro tra gli dèi e gli uomini che da lui apprendono il vero<br />
linguaggio. Coerentemente con il principio fondamentale del neoplatonismo, per cui tanto maggiore è<br />
il grado di originarietà, quindi di indeterminatezza, del reale, tanto minore è la possibilità che esso sia<br />
dicibile, nel suo Commento al Cratilo Proclo individua diversi gradi di nominabilità del divino, che<br />
vanno dalla assoluta indicibilità dei συνθήµατα, a noi visibili solo attraverso figure luminose 14 (τοῦ<br />
φωτὸς χαρακτῆρες), alla forma intermedia dei σύµβολα, i suoni inarticolati delle pratiche teurgiche,<br />
fino ad arrivare ai veri e propri ὀνόµατα, nomi con cui gli dèi vengono nominati e celebrati nelle<br />
8 Dalla stessa radice derivano le forme verbali attive δαΐζω «dividere» e δαίνυµι «distribuire» e, detto di cibo, «banchettare»,<br />
da cui il termine δαίς, «pasto» o «banchetto» in cui ciascuno ha la sua parte. Cfr. Chantraine 1968, sub voces δαίµων e<br />
δαίοµαι, pp. 246-247 e Lévêque 1993.<br />
9 Procl. In Crat. CXXVIII, 75, 19-21 ed. Pasquali. La traduzione è di Romano 1989, lievemente modificata. Cfr. anche<br />
Herm. In Phaedr. 39, 20-22 in cui si piega che Eros è un grande demone perché partecipa del bello in maniera divisa e non<br />
unitaria: «δαίσασθαι γὰρ τὸ µερίσασθαι».<br />
10 Sul ruolo ontologico dei demoni, sulla funzione di mediazione tra le realtà divine e quelle umane, traducendo la<br />
provvidenza trascendente, universale e unitaria in una provvidenza prossima, particolare e plurale cfr. anche Procl. In Tim. I,<br />
39, 30 – 40, 10 ed. Diehl. Tralascerò in questa sede questioni relative alla dimensione demonica delle anime particolari.<br />
Sull’argomento cfr. Steel 1978, Di Pasquale Barbanti 2001 e, in particolare sul demone di Socrate, De Vita 2011.<br />
11 Cfr. Procl. In Crat. LI, 18, 9 – LIII, 23, 25. Sull’argomento cfr. Abbate 2001, pp. 39-45, 55-61 e De Piano 2013. Sulla<br />
natura iconica, dunque mimetica, del linguaggio già in Platone cfr. Palumbo 2008, pp. 334-364.<br />
12 Procl. In Crat. LXVIII, 29, 11-12.<br />
13 Il poeta divinamente ispirato è assolutamente inconsapevole (ἔκφρων) e l’intelletto (νοῦς) non è più in lui; egli, «κοῦφον<br />
γὰρ χρῆµα ... καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, Ion. 534b3-4», non è capace di comporre alcunché se prima non è colmo di divino<br />
(ἔνθεος, 534b5). Sull’ispirazione poetica nella tradizione arcaica e in Platone mi limito a rimandare in questa sede a<br />
Tigerstedt 1969 e Murray 1981 (da Omero a Pindaro) e, più specificamente per Platone, a Velardi 1989 e Giuliano 2005, pp.<br />
137-218.<br />
14 Cfr. Or. Ch. fr. 145 Des Places e si veda, per un interessante commento su tale immagine di ascendenza caldaica, Pépin<br />
1981, pp. 50-53.<br />
240