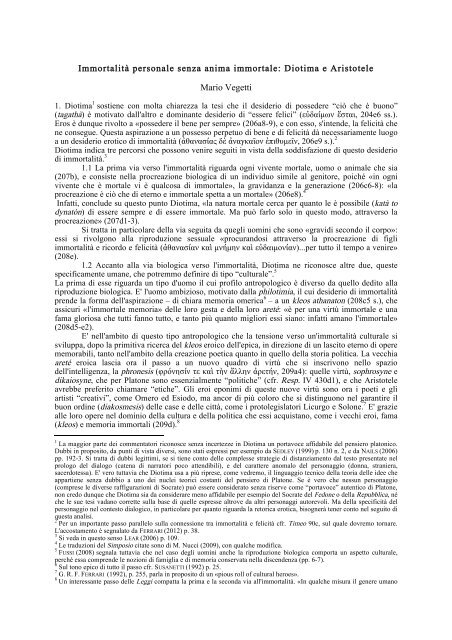Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Immortalità personale senza anima immortale: Diotima e Aristotele<br />
Mario Vegetti<br />
1. Diotima 1 sostiene con molta chiarezza la tesi che il desiderio di possedere “ciò che è buono”<br />
(tagathà) è motivato dall'altro e dominante desiderio di “essere felici” (εὐδαίµων ἔσται, 204e6 ss.).<br />
Eros è dunque rivolto a «possedere il bene per sempre» (206a8-9), e con esso, s'intende, la felicità che<br />
ne consegue. Questa aspirazione a un possesso perpetuo di bene e di felicità dà necessariamente luogo<br />
a un desiderio erotico di immortalità (ἀθανασίας δὲ ἀναγκαῖον ἐπιθυµεῖν, 206e9 s.). 2<br />
Diotima indica tre percorsi che possono venire seguiti in vista della soddisfazione di questo desiderio<br />
di immortalità. 3<br />
1.1 La prima via verso l'immortalità riguarda ogni vivente mortale, uomo o animale che sia<br />
(207b), e consiste nella procreazione biologica di un individuo simile al genitore, poiché «in ogni<br />
vivente che è mortale vi è qualcosa di immortale», la gravidanza e la generazione (206c6-8): «la<br />
procreazione è ciò che di eterno e immortale spetta a un mortale» (206e8). 4<br />
Infatti, conclude su questo punto Diotima, «la natura mortale cerca per quanto le è possibile (katà to<br />
dynatòn) di essere sempre e di essere immortale. Ma può farlo solo in questo modo, attraverso la<br />
procreazione» (207d1-3).<br />
Si tratta in particolare della via seguita da quegli uomini che sono «gravidi secondo il corpo»:<br />
essi si rivolgono alla riproduzione sessuale «procurandosi attraverso la procreazione di figli<br />
immortalità e ricordo e felicità (ἀθανασίαν καὶ µνήµην καὶ εὐδαιµονίαν)...per tutto il tempo a venire»<br />
(208e).<br />
1.2 Accanto alla via biologica verso l'immortalità, Diotima ne riconosce altre due, queste<br />
specificamente umane, che potremmo definire di tipo “culturale”. 5<br />
La prima di esse riguarda un tipo d'uomo il cui profilo antropologico è diverso da quello dedito alla<br />
riproduzione biologica. E' l'uomo ambizioso, motivato dalla philotimia, il cui desiderio di immortalità<br />
prende la forma dell'aspirazione – di chiara memoria omerica 6 – a un kleos athanaton (208c5 s.), che<br />
assicuri «l'immortale memoria» delle loro gesta e della loro areté: «è per una virtù immortale e una<br />
fama gloriosa che tutti fanno tutto, e tanto più quanto migliori essi siano: infatti amano l'immortale»<br />
(208d5-e2).<br />
E' nell'ambito di questo tipo antropologico che la tensione verso un'immortalità culturale si<br />
sviluppa, dopo la primitiva ricerca del kleos eroico dell'epica, in direzione di un lascito eterno di opere<br />
memorabili, tanto nell'ambito della creazione poetica quanto in quello della storia politica. La vecchia<br />
areté eroica lascia ora il passo a un nuovo quadro di virtù che si inscrivono nello spazio<br />
dell'intelligenza, la phronesis (φρόνησίν τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, 209a4): quelle virtù, sophrosyne e<br />
dikaiosyne, che per Platone sono essenzialmente “politiche” (cfr. Resp. IV 430d1), e che Aristotele<br />
avrebbe preferito chiamare “etiche”. Gli eroi eponimi di queste nuove virtù sono ora i poeti e gli<br />
artisti “creativi”, come Omero ed Esiodo, ma ancor di più coloro che si distinguono nel garantire il<br />
buon ordine (diakosmesis) delle case e delle città, come i protolegislatori Licurgo e Solone. 7 E' grazie<br />
alle loro opere nel dominio della cultura e della politica che essi acquistano, come i vecchi eroi, fama<br />
(kleos) e memoria immortali (209d). 8<br />
1 La maggior parte dei commentatori riconosce senza incertezze in Diotima un portavoce affidabile del pensiero platonico.<br />
Dubbi in proposito, da punti di vista diversi, sono stati espressi per esempio da SEDLEY (1999) p. 130 n. 2, e da NAILS (2006)<br />
pp. 192-3. Si tratta di dubbi legittimi, se si tiene conto delle complesse strategie di distanziamento dal testo presentate nel<br />
prologo del dialogo (catena di narratori poco attendibili), e del carattere anomalo del personaggio (donna, straniera,<br />
sacerdotessa). E' vero tuttavia che Diotima usa a più riprese, come vedremo, il linguaggio tecnico della teoria delle idee che<br />
appartiene senza dubbio a uno dei nuclei teorici costanti del pensiero di Platone. Se è vero che nessun personaggio<br />
(comprese le diverse raffigurazioni di Socrate) può essere considerato senza riserve come “portavoce” autentico di Platone,<br />
non credo dunque che Diotima sia da considerare meno affidabile per esempio del Socrate del Fedone o della Repubblica, né<br />
che le sue tesi vadano corrette sulla base di quelle espresse altrove da altri personaggi autorevoli. Ma della specificità del<br />
personaggio nel contesto dialogico, in particolare per quanto riguarda la retorica erotica, bisognerà tener conto nel seguito di<br />
questa analisi.<br />
2 Per un importante passo parallelo sulla connessione tra immortalità e felicità cfr. Timeo 90c, sul quale dovremo tornare.<br />
L'accostamento è segnalato da FERRARI (2012) p. 38.<br />
3 Si veda in questo senso LEAR (2006) p. 109.<br />
4 Le traduzioni del Simposio citate sono di M. Nucci (2009), con qualche modifica.<br />
5 FUSSI (2008) segnala tuttavia che nel caso degli uomini anche la riproduzione biologica comporta un aspetto culturale,<br />
perché essa comprende le nozioni di famiglia e di memoria conservata nella discendenza (pp. 6-7).<br />
6 Sul tono epico di tutto il passo cfr. SUSANETTI (1992) p. 25.<br />
7 G. R. F. FERRARI (1992), p. 255, parla in proposito di un «pious roll of cultural heroes».<br />
8 Un interessante passo delle Leggi compatta la prima e la seconda via all'immortalità. «In qualche misura il genere umano