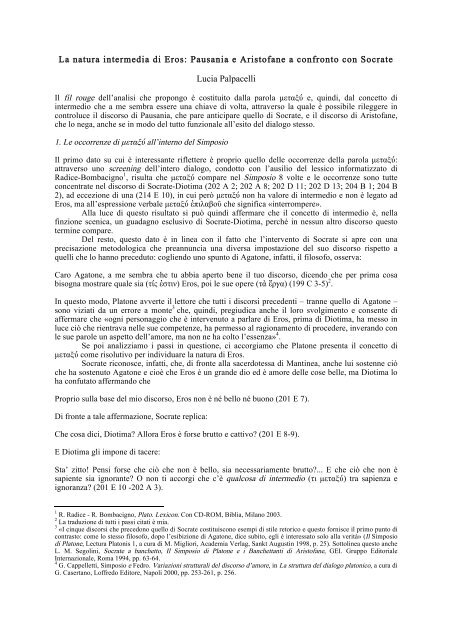Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La natura intermedia di Eros: Pausania e Aristofane a confronto con Socrate<br />
Lucia Palpacelli<br />
Il fil rouge dell’analisi che propongo è costituito dalla parola µεταξύ e, quindi, dal concetto di<br />
intermedio che a me sembra essere una chiave di volta, attraverso la quale è possibile rileggere in<br />
controluce il discorso di Pausania, che pare anticipare quello di Socrate, e il discorso di Aristofane,<br />
che lo nega, anche se in modo del tutto funzionale all’esito del dialogo stesso.<br />
1. Le occorrenze di µεταξύ all’interno del Simposio<br />
Il primo dato su cui è interessante riflettere è proprio quello delle occorrenze della parola µεταξύ:<br />
attraverso uno screening dell’intero dialogo, condotto con l’ausilio del lessico informatizzato di<br />
Radice-Bombacigno 1 , risulta che µεταξύ compare nel Simposio 8 volte e le occorrenze sono tutte<br />
concentrate nel discorso di Socrate-Diotima (202 A 2; 202 A 8; 202 D 11; 202 D 13; 204 B 1; 204 B<br />
2), ad eccezione di una (214 E 10), in cui però µεταξύ non ha valore di intermedio e non è legato ad<br />
Eros, ma all’espressione verbale µεταξύ ἐπιλαβοῦ che significa «interrompere».<br />
Alla luce di questo risultato si può quindi affermare che il concetto di intermedio è, nella<br />
finzione scenica, un guadagno esclusivo di Socrate-Diotima, perché in nessun altro discorso questo<br />
termine compare.<br />
Del resto, questo dato è in linea con il fatto che l’intervento di Socrate si apre con una<br />
precisazione metodologica che preannuncia una diversa impostazione del suo discorso rispetto a<br />
quelli che lo hanno preceduto: cogliendo uno spunto di Agatone, infatti, il filosofo, osserva:<br />
Caro Agatone, a me sembra che tu abbia aperto bene il tuo discorso, dicendo che per prima cosa<br />
bisogna mostrare quale sia (τίς ἐστιν) Eros, poi le sue opere (τὰ ἔργα) (199 C 3-5) 2 .<br />
In questo modo, Platone avverte il lettore che tutti i discorsi precedenti – tranne quello di Agatone –<br />
sono viziati da un errore a monte 3 che, quindi, pregiudica anche il loro svolgimento e consente di<br />
affermare che «ogni personaggio che è intervenuto a parlare di Eros, prima di Diotima, ha messo in<br />
luce ciò che rientrava nelle sue competenze, ha permesso al ragionamento di procedere, inverando con<br />
le sue parole un aspetto dell’amore, ma non ne ha colto l’essenza» 4 .<br />
Se poi analizziamo i passi in questione, ci accorgiamo che Platone presenta il concetto di<br />
µεταξύ come risolutivo per individuare la natura di Eros.<br />
Socrate riconosce, infatti, che, di fronte alla sacerdotessa di Mantinea, anche lui sostenne ciò<br />
che ha sostenuto Agatone e cioè che Eros è un grande dio ed è amore delle cose belle, ma Diotima lo<br />
ha confutato affermando che<br />
Proprio sulla base del mio discorso, Eros non è né bello né buono (201 E 7).<br />
Di fronte a tale affermazione, Socrate replica:<br />
Che cosa dici, Diotima? Allora Eros è forse brutto e cattivo? (201 E 8-9).<br />
E Diotima gli impone di tacere:<br />
Sta’ zitto! Pensi forse che ciò che non è bello, sia necessariamente brutto?... E che ciò che non è<br />
sapiente sia ignorante? O non ti accorgi che c’è qualcosa di intermedio (τι µεταξύ) tra sapienza e<br />
ignoranza? (201 E 10 -202 A 3).<br />
1 R. Radice - R. Bombacigno, Plato. Lexicon. Con CD-ROM, Biblia, Milano 2003.<br />
2 La traduzione di tutti i passi citati è mia.<br />
3 «I cinque discorsi che precedono quello di Socrate costituiscono esempi di stile retorico e questo fornisce il primo punto di<br />
contrasto: come lo stesso filosofo, dopo l’esibizione di Agatone, dice subito, egli è interessato solo alla verità» (Il Simposio<br />
di Platone, Lectura Platonis 1, a cura di M. Migliori, Academia Verlag, Sankt Augustin 1998, p. 25). Sottolinea questo anche<br />
L. M. Segolini, Socrate a banchetto, Il Simposio di Platone e i Banchettanti di Aristofane, GEI. Gruppo Editoriale<br />
Internazionale, Roma 1994, pp. 63-64.<br />
4 G. Cappelletti, Simposio e Fedro. Variazioni strutturali del discorso d’amore, in La struttura del dialogo platonico, a cura di<br />
G. Casertano, Loffredo Editore, Napoli 2000, pp. 253-261, p. 256.