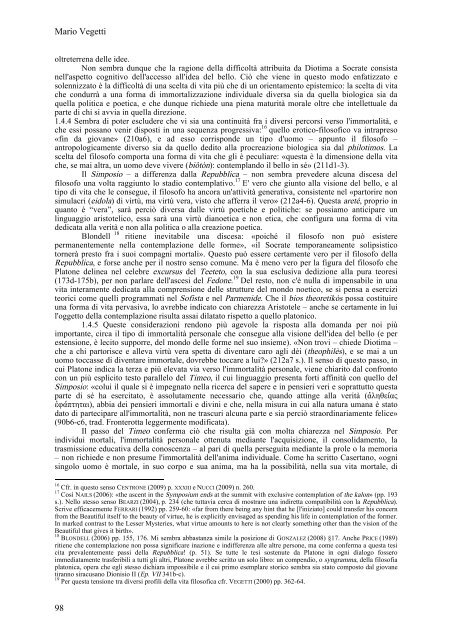You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mario Vegetti<br />
oltreterrena delle idee.<br />
Non sembra dunque che la ragione della difficoltà attribuita da Diotima a Socrate consista<br />
nell'aspetto cognitivo dell'accesso all'idea del bello. Ciò che viene in questo modo enfatizzato e<br />
solennizzato è la difficoltà di una scelta di vita più che di un orientamento epistemico: la scelta di vita<br />
che condurrà a una forma di immortalizzazione individuale diversa sia da quella biologica sia da<br />
quella politica e poetica, e che dunque richiede una piena maturità morale oltre che intellettuale da<br />
parte di chi si avvia in quella direzione.<br />
1.4.4 Sembra di poter escludere che vi sia una continuità fra i diversi percorsi verso l'immortalità, e<br />
che essi possano venir disposti in una sequenza progressiva: 16 quello erotico-filosofico va intrapreso<br />
«fin da giovane» (210a6), e ad esso corrisponde un tipo d'uomo – appunto il filosofo –<br />
antropologicamente diverso sia da quello dedito alla procreazione biologica sia dal philotimos. La<br />
scelta del filosofo comporta una forma di vita che gli è peculiare: «questa è la dimensione della vita<br />
che, se mai altra, un uomo deve vivere (biôtòn): contemplando il bello in sé» (211d1-3).<br />
Il Simposio – a differenza dalla Repubblica – non sembra prevedere alcuna discesa del<br />
filosofo una volta raggiunto lo stadio contemplativo. 17 E' vero che giunto alla visione del bello, e al<br />
tipo di vita che le consegue, il filosofo ha ancora un'attività generativa, consistente nel «partorire non<br />
simulacri (eidola) di virtù, ma virtù vera, visto che afferra il vero» (212a4-6). Questa areté, proprio in<br />
quanto è “vera”, sarà perciò diversa dalle virtù poetiche e politiche: se possiamo anticipare un<br />
linguaggio aristotelico, essa sarà una virtù dianoetica e non etica, che configura una forma di vita<br />
dedicata alla verità e non alla politica o alla creazione poetica.<br />
Blondell 18 ritiene inevitabile una discesa: «poiché il filosofo non può esistere<br />
permanentemente nella contemplazione delle forme», «il Socrate temporaneamente solipsistico<br />
tornerà presto fra i suoi compagni mortali». Questo può essere certamente vero per il filosofo della<br />
Repubblica, e forse anche per il nostro senso comune. Ma è meno vero per la figura del filosofo che<br />
Platone delinea nel celebre excursus del Teeteto, con la sua esclusiva dedizione alla pura teoresi<br />
(173d-175b), per non parlare dell'ascesi del Fedone. 19 Del resto, non c'è nulla di impensabile in una<br />
vita interamente dedicata alla comprensione delle strutture del mondo noetico, se si pensa a esercizi<br />
teorici come quelli programmati nel Sofista e nel Parmenide. Che il bios theoretikòs possa costituire<br />
una forma di vita pervasiva, lo avrebbe indicato con chiarezza Aristotele – anche se certamente in lui<br />
l'oggetto della contemplazione risulta assai dilatato rispetto a quello platonico.<br />
1.4.5 Queste considerazioni rendono più agevole la risposta alla domanda per noi più<br />
importante, circa il tipo di immortalità personale che consegue alla visione dell'idea del bello (e per<br />
estensione, è lecito supporre, del mondo delle forme nel suo insieme). «Non trovi – chiede Diotima –<br />
che a chi partorisce e alleva virtù vera spetta di diventare caro agli dèi (theophilès), e se mai a un<br />
uomo toccasse di diventare immortale, dovrebbe toccare a lui?» (212a7 s.). Il senso di questo passo, in<br />
cui Platone indica la terza e più elevata via verso l'immortalità personale, viene chiarito dal confronto<br />
con un più esplicito testo parallelo del Timeo, il cui linguaggio presenta forti affinità con quello del<br />
Simposio: «colui il quale si è impegnato nella ricerca del sapere e in pensieri veri e soprattutto questa<br />
parte di sé ha esercitato, è assolutamente necessario che, quando attinge alla verità (ἀληθείας<br />
ἐφάπτηται), abbia dei pensieri immortali e divini e che, nella misura in cui alla natura umana è stato<br />
dato di partecipare all'immortalità, non ne trascuri alcuna parte e sia perciò straordinariamente felice»<br />
(90b6-c6, trad. Fronterotta leggermente modificata).<br />
Il passo del Timeo conferma ciò che risulta già con molta chiarezza nel Simposio. Per<br />
individui mortali, l'immortalità personale ottenuta mediante l'acquisizione, il consolidamento, la<br />
trasmissione educativa della conoscenza – al pari di quella perseguita mediante la prole o la memoria<br />
– non richiede e non presume l'immortalità dell'anima individuale. Come ha scritto Casertano, «ogni<br />
singolo uomo è mortale, in suo corpo e sua anima, ma ha la possibilità, nella sua vita mortale, di<br />
16 Cfr. in questo senso CENTRONE (2009) p. XXXIII e NUCCI (2009) n. 260.<br />
17 Così NAILS (2006): «the ascent in the <strong>Symposium</strong> ends at the summit with exclusive contemplation of the kalon» (pp. 193<br />
s.). Nello stesso senso BEARZI (2004), p. 234 (che tuttavia cerca di mostrare una indiretta compatibilità con la Repubblica).<br />
Scrive efficacemente FERRARI (1992) pp. 259-60: «far from there being any hint that he [l'iniziato] could transfer his concern<br />
from the Beautiful itself to the beauty of virtue, he is explicitly envisaged as spending his life in contemplation of the former.<br />
In marked contrast to the Lesser Mysteries, what virtue amounts to here is not clearly something other than the vision of the<br />
Beautiful that gives it birth».<br />
18 BLONDELL (2006) pp. 155, 176. Mi sembra abbastanza simile la posizione di GONZALEZ (2008) §17. Anche PRICE (1989)<br />
ritiene che contemplazione non possa significare inazione e indifferenza alle altre persone, ma come conferma a questa tesi<br />
cita prevalentemente passi della Repubblica! (p. 51). Se tutte le tesi sostenute da Platone in ogni dialogo fossero<br />
immediatamente trasferibili a tutti gli altri, Platone avrebbe scritto un solo libro: un compendio, o syngramma, della filosofia<br />
platonica, opera che egli stesso dichiara impossibile e il cui primo esemplare storico sembra sia stato composto dal giovane<br />
tiranno siracusano Dionisio II (Ep. VII 341b-c).<br />
19 Per questa tensione tra diversi profili della vita filosofica cfr. VEGETTI (2000) pp. 362-64.<br />
98