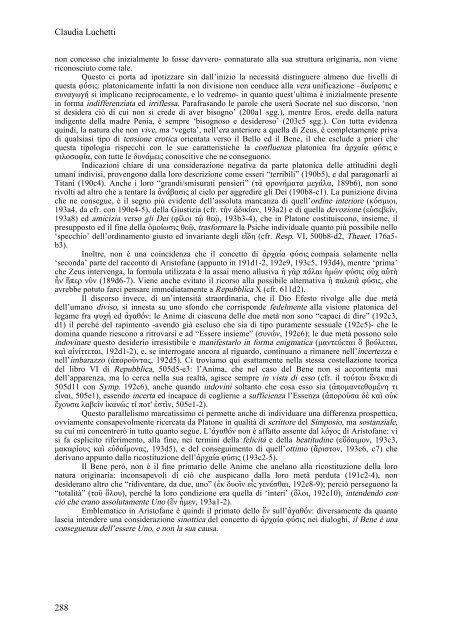You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Claudia Luchetti<br />
non concesso che inizialmente lo fosse davvero- connaturato alla sua struttura originaria, non viene<br />
riconosciuto come tale.<br />
Questo ci porta ad ipotizzare sin dall’inizio la necessità distinguere almeno due livelli di<br />
questa φύσις: platonicamente infatti la non divisione non conduce alla vera unificazione –διαίρεσις e<br />
συναγωγή si implicano reciprocamente, e lo vedremo- in quanto quest’ultima è inizialmente presente<br />
in forma indifferenziata ed irriflessa. Parafrasando le parole che userà Socrate nel suo discorso, ‘non<br />
si desidera ciò di cui non si crede di aver bisogno’ (200a1 sgg.), mentre Eros, erede della natura<br />
indigente della madre Penia, è sempre ‘bisognoso e desideroso’ (203c5 sgg.). Con tutta evidenza<br />
quindi, la natura che non vive, ma ‘vegeta’, nell’era anteriore a quella di Zeus, è completamente priva<br />
di qualsiasi tipo di tensione erotica orientata verso il Bello ed il Bene, il che esclude a priori che<br />
questa tipologia rispecchi con le sue caratteristiche la confluenza platonica fra ἀρχαία φύσις e<br />
φιλοσοφία, con tutte le δυνάµεις conoscitive che ne conseguono.<br />
Indicazioni chiare di una considerazione negativa da parte platonica delle attitudini degli<br />
umani indivisi, provengono dalla loro descrizione come esseri “terribili” (190b5), e dal paragonarli ai<br />
Titani (190c4). Anche i loro “grandi/smisurati pensieri” (τὰ φρονήµατα µεγάλα, 189b6), non sono<br />
rivolti ad altro che a tentare la ἀνάβασις al cielo per aggredire gli Dei (190b8-c1). La punizione divina<br />
che ne consegue, è il segno più evidente dell’assoluta mancanza di quell’ordine interiore (κόσµιοι,<br />
193a4, da cfr. con 190e4-5), della Giustizia (cfr. τὴν ἀδικίαν, 193a2) e di quella devozione (εὐσεβεῖν,<br />
193a8) ed amicizia verso gli Dei (φίλοι τῷ θεῷ, 193b3-4), che in Platone costituiscono, insieme, il<br />
presupposto ed il fine della ὁµοίωσις θεῷ, trasformare la Psiche individuale quanto più possibile nello<br />
‘specchio’ dell’ordinamento giusto ed invariante degli εἴδη (cfr. Resp. VI, 500b8-d2, Theaet. 176a5b3).<br />
Inoltre, non è una coincidenza che il concetto di ἀρχαία φύσις compaia solamente nella<br />
‘seconda’ parte del racconto di Aristofane (appunto in 191d1-2, 192e9, 193c5, 193d4), mentre ‘prima’<br />
che Zeus intervenga, la formula utilizzata è la assai meno allusiva ἡ γὰρ πάλαι ἡµῶν φύσις οὐχ αὑτὴ<br />
ἦν ἥπερ νῦν (189d6-7). Viene anche evitato il ricorso alla possibile alternativa ἡ παλαιὰ φύσις, che<br />
avrebbe potuto farci pensare immediatamente a Repubblica X (cfr. 611d2).<br />
Il discorso invece, di un’intensità straordinaria, che il Dio Efesto rivolge alle due metà<br />
dell’umano diviso, si innesta su uno sfondo che corrisponde fedelmente alla visione platonica del<br />
legame fra ψυχή ed ἀγαθόν: le Anime di ciascuna delle due metà non sono “capaci di dire” (192c3,<br />
d1) il perché del rapimento -avendo già escluso che sia di tipo puramente sessuale (192c5)- che le<br />
domina quando riescono a ritrovarsi e ad “Essere insieme” (συνών, 192c6); le due metà possono solo<br />
indovinare questo desiderio irresistibile e manifestarlo in forma enigmatica (µαντεύεται ὅ βούλεται,<br />
καὶ αἰνίττεται, 192d1-2), e, se interrogate ancora al riguardo, continuano a rimanere nell’incertezza e<br />
nell’imbarazzo (ἀποροῦντας, 192d5). Ci troviamo qui esattamente nella stessa costellazione teorica<br />
del libro VI di Repubblica, 505d5-e3: l’Anima, che nel caso del Bene non si accontenta mai<br />
dell’apparenza, ma lo cerca nella sua realtà, agisce sempre in vista di esso (cfr. il τούτου ἕνεκα di<br />
505d11 con Symp. 192c6), anche quando indovini soltanto che cosa esso sia (ἀποµαντεθοµένη τι<br />
εἶναι, 505e1), essendo incerta ed incapace di coglierne a sufficienza l’Essenza (ἀποροῦσα δὲ καὶ οὐκ<br />
ἔχουσα λαβεῖν ἱκανῶς τί ποτ' ἐστὶν, 505e1-2).<br />
Questo parallelismo marcatissimo ci permette anche di individuare una differenza prospettica,<br />
ovviamente consapevolmente ricercata da Platone in qualità di scrittore del Simposio, ma sostanziale,<br />
su cui mi concentrerò in tutto quanto segue. L’ἀγαθόν non è affatto assente dal λόγος di Aristofane: vi<br />
si fa esplicito riferimento, alla fine, nei termini della felicità e della beatitudine (εὔδαιµον, 193c3,<br />
µακαρίους καὶ εὐδαίµονας, 193d5), e del conseguimento di quell’ottimo (ἄριστον, 193c6, c7) che<br />
derivano appunto dalla ricostituzione dell’ἀρχαία φύσις (193c2-5).<br />
Il Bene però, non è il fine primario delle Anime che anelano alla ricostituzione della loro<br />
natura originaria: inconsapevoli di ciò che auspicano dalla loro metà perduta (191c2-4), non<br />
desiderano altro che “ridiventare, da due, uno” (ἐκ δυοῖν εἶς γενέσθαι, 192e8-9); perciò perseguono la<br />
“totalità” (τοῦ ὅλου), perché la loro condizione era quella di ‘interi’ (ὅλοι, 192e10), intendendo con<br />
ciò che erano assolutamente Uno (ἕν ἦµεν, 193a1-2).<br />
Emblematico in Aristofane è quindi il primato dello ἕν sull’ἀγαθόν: diversamente da quanto<br />
lascia intendere una considerazione sinottica del concetto di ἀρχαία φύσις nei dialoghi, il Bene è una<br />
conseguenza dell’essere Uno, e non la sua causa.<br />
288