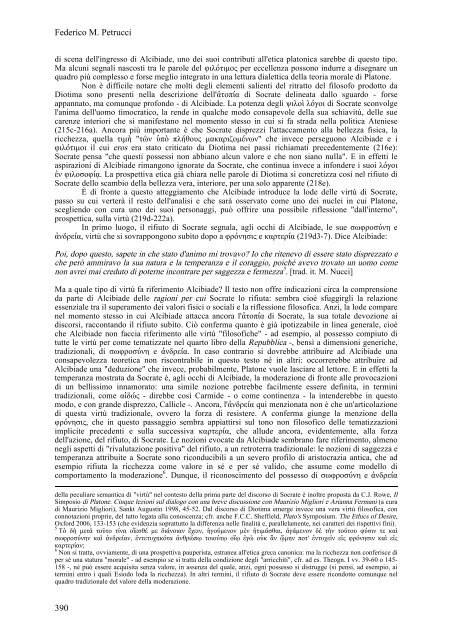Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Federico M. Petrucci<br />
di scena dell'ingresso di Alcibiade, uno dei suoi contributi all'etica platonica sarebbe di questo tipo.<br />
Ma alcuni segnali nascosti tra le parole del φιλότιµος per eccellenza possono indurre a disegnare un<br />
quadro più complesso e forse meglio integrato in una lettura dialettica della teoria morale di Platone.<br />
Non è difficile notare che molti degli elementi salienti del ritratto del filosofo prodotto da<br />
Diotima sono presenti nella descrizione dell'ἀτοπία di Socrate delineata dallo sguardo - forse<br />
appannato, ma comunque profondo - di Alcibiade. La potenza degli ψιλοὶ λόγοι di Socrate sconvolge<br />
l'anima dell'uomo timocratico, la rende in qualche modo consapevole della sua schiavitù, delle sue<br />
carenze interiori che si manifestano nel momento stesso in cui si fa strada nella politica Ateniese<br />
(215c-216a). Ancora più importante è che Socrate disprezzi l'attaccamento alla bellezza fisica, la<br />
ricchezza, quella τιµὴ "τῶν ὑπὸ πλήθους µακαριζοµένων" che invece perseguono Alcibiade e i<br />
φιλότιµοι il cui eros era stato criticato da Diotima nei passi richiamati precedentemente (216e):<br />
Socrate pensa "che questi possessi non abbiano alcun valore e che non siano nulla". E in effetti le<br />
aspirazioni di Alcibiade rimangono ignorate da Socrate, che continua invece a infondere i suoi λόγοι<br />
ἐν φιλοσοφίᾳ. La prospettiva etica già chiara nelle parole di Diotima si concretizza così nel rifiuto di<br />
Socrate dello scambio della bellezza vera, interiore, per una solo apparente (218e).<br />
È di fronte a questo atteggiamento che Alcibiade introduce la lode delle virtù di Socrate,<br />
passo su cui verterà il resto dell'analisi e che sarà osservato come uno dei nuclei in cui Platone,<br />
scegliendo con cura uno dei suoi personaggi, può offrire una possibile riflessione "dall'interno",<br />
prospettica, sulla virtù (219d-222a).<br />
In primo luogo, il rifiuto di Socrate segnala, agli occhi di Alcibiade, le sue σωφροσύνη e<br />
ἀνδρεία, virtù che si sovrappongono subito dopo a φρόνησις e καρτερία (219d3-7). Dice Alcibiade:<br />
Poi, dopo questo, sapete in che stato d'animo mi trovavo? Io che ritenevo di essere stato disprezzato e<br />
che però ammiravo la sua natura e la temperanza e il coraggio, poiché avevo trovato un uomo come<br />
non avrei mai creduto di poterne incontrare per saggezza e fermezza 5 . [trad. it. M. Nucci]<br />
Ma a quale tipo di virtù fa riferimento Alcibiade? Il testo non offre indicazioni circa la comprensione<br />
da parte di Alcibiade delle ragioni per cui Socrate lo rifiuta: sembra cioè sfuggirgli la relazione<br />
essenziale tra il superamento dei valori fisici o sociali e la riflessione filosofica. Anzi, la lode compare<br />
nel momento stesso in cui Alcibiade attacca ancora l'ἀτοπία di Socrate, la sua totale devozione ai<br />
discorsi, raccontando il rifiuto subìto. Ciò conferma quanto è già ipotizzabile in linea generale, cioè<br />
che Alcibiade non faccia riferimento alle virtù "filosofiche" - ad esempio, al possesso compiuto di<br />
tutte le virtù per come tematizzate nel quarto libro della Repubblica -, bensì a dimensioni generiche,<br />
tradizionali, di σωφροσύνη e ἀνδρεία. In caso contrario si dovrebbe attribuire ad Alcibiade una<br />
consapevolezza teoretica non riscontrabile in questo testo né in altri: occorrerebbe attribuire ad<br />
Alcibiade una "deduzione" che invece, probabilmente, Platone vuole lasciare al lettore. E in effetti la<br />
temperanza mostrata da Socrate è, agli occhi di Alcibiade, la moderazione di fronte alle provocazioni<br />
di un bellissimo innamorato: una simile nozione potrebbe facilmente essere definita, in termini<br />
tradizionali, come αἰδώς - direbbe così Carmide - o come continenza - la intenderebbe in questo<br />
modo, e con grande disprezzo, Callicle -. Ancora, l'ἀνδρεία qui menzionata non è che un'articolazione<br />
di questa virtù tradizionale, ovvero la forza di resistere. A conferma giunge la menzione della<br />
φρόνησις, che in questo passaggio sembra appiattirsi sul tono non filosofico delle tematizzazioni<br />
implicite precedenti e sulla successiva καρτερία, che allude ancora, evidentemente, alla forza<br />
dell'azione, del rifiuto, di Socrate. Le nozioni evocate da Alcibiade sembrano fare riferimento, almeno<br />
negli aspetti di "rivalutazione positiva" del rifiuto, a un retroterra tradizionale: le nozioni di saggezza e<br />
temperanza attribuite a Socrate sono riconducibili a un severo profilo di aristocrazia antica, che ad<br />
esempio rifiuta la ricchezza come valore in sé e per sé valido, che assume come modello di<br />
comportamento la moderazione 6 . Dunque, il riconoscimento del possesso di σωφροσύνη e ἀνδρεία<br />
della peculiare semantica di "virtù" nel contesto della prima parte del discorso di Socrate è inoltre proposta da C.J. Rowe, Il<br />
Simposio di Platone. Cinque lezioni sul dialogo con una breve discussione con Maurizio Migliori e Arianna Fermani (a cura<br />
di Maurizio Migliori), Sankt Augustin 1998, 45-52. Dal discorso di Diotima emerge invece una vera virtù filosofica, con<br />
connotazioni proprie, del tutto legata alla conoscenza; cfr. anche F.C.C. Sheffield, Plato's <strong>Symposium</strong>. The Ethics of Desire,<br />
Oxford 2006, 133-153 (che evidenzia soprattutto la differenza nelle finalità e, parallelamente, nei caratteri dei rispettivi fini).<br />
5 Τὸ δὴ µετὰ τοῦτο τίνα οἴεσθέ µε διάνοιαν ἔχειν, ἡγούµενον µὲν ἠτιµάσθαι, ἀγάµενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε καὶ<br />
σωφροσύνην καὶ ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾤµην ποτ' ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν καὶ εἰς<br />
καρτερίαν;<br />
6 Non si tratta, ovviamente, di una prospettiva pauperista, estranea all'etica greca canonica: ma la ricchezza non conferisce di<br />
per sé una statura "morale" - ad esempio se si tratta della condizione degli "arricchiti", cfr. ad es. Theogn. I vv. 39-60 o 145-<br />
158 -, né può essere acquisita senza valore, in assenza del quale, anzi, ogni possesso si distrugge (si pensi, ad esempio, ai<br />
termini entro i quali Esiodo loda la ricchezza). In altri termini, il rifiuto di Socrate deve essere ricondotto comunque nel<br />
quadro tradizionale del valore della moderazione.<br />
390