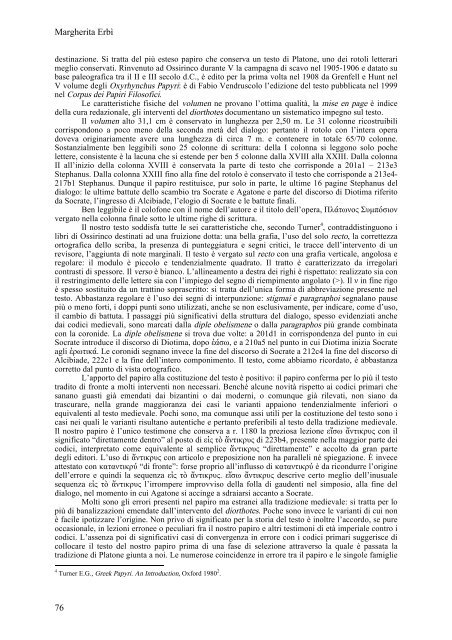Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Margherita Erbì<br />
destinazione. Si tratta del più esteso papiro che conserva un testo di Platone, uno dei rotoli letterari<br />
meglio conservati. Rinvenuto ad Ossirinco durante V la campagna di scavo nel 1905-1906 e datato su<br />
base paleografica tra il II e III secolo d.C., è edito per la prima volta nel 1908 da Grenfell e Hunt nel<br />
V volume degli Oxyrhynchus Papyri: è di Fabio Vendruscolo l’edizione del testo pubblicata nel 1999<br />
nel Corpus dei Papiri Filosofici.<br />
Le caratteristiche fisiche del volumen ne provano l’ottima qualità, la mise en page è indice<br />
della cura redazionale, gli interventi del diorthotes documentano un sistematico impegno sul testo.<br />
Il volumen alto 31,1 cm è conservato in lunghezza per 2,50 m. Le 31 colonne ricostruibili<br />
corrispondono a poco meno della seconda metà del dialogo: pertanto il rotolo con l’intera opera<br />
doveva originariamente avere una lunghezza di circa 7 m. e contenere in totale 65/70 colonne.<br />
Sostanzialmente ben leggibili sono 25 colonne di scrittura: della I colonna si leggono solo poche<br />
lettere, consistente è la lacuna che si estende per ben 5 colonne dalla XVIII alla XXIII. Dalla colonna<br />
II all’inizio della colonna XVIII è conservata la parte di testo che corrisponde a 201a1 – 213e3<br />
Stephanus. Dalla colonna XXIII fino alla fine del rotolo è conservato il testo che corrisponde a 213e4-<br />
217b1 Stephanus. Dunque il papiro restituisce, pur solo in parte, le ultime 16 pagine Stephanus del<br />
dialogo: le ultime battute dello scambio tra Socrate e Agatone e parte del discorso di Diotima riferito<br />
da Socrate, l’ingresso di Alcibiade, l’elogio di Socrate e le battute finali.<br />
Ben leggibile è il colofone con il nome dell’autore e il titolo dell’opera, Πλάτωνος Συµπόσιον<br />
vergato nella colonna finale sotto le ultime righe di scrittura.<br />
Il nostro testo soddisfa tutte le sei caratteristiche che, secondo Turner 4 , contraddistinguono i<br />
libri di Ossirinco destinati ad una fruizione dotta: una bella grafia, l’uso del solo recto, la correttezza<br />
ortografica dello scriba, la presenza di punteggiatura e segni critici, le tracce dell’intervento di un<br />
revisore, l’aggiunta di note marginali. Il testo è vergato sul recto con una grafia verticale, angolosa e<br />
regolare: il modulo è piccolo e tendenzialmente quadrato. Il tratto è caratterizzato da irregolari<br />
contrasti di spessore. Il verso è bianco. L’allineamento a destra dei righi è rispettato: realizzato sia con<br />
il restringimento delle lettere sia con l’impiego del segno di riempimento angolato (>). Il ν in fine rigo<br />
è spesso sostituito da un trattino soprascritto: si tratta dell’unica forma di abbreviazione presente nel<br />
testo. Abbastanza regolare è l’uso dei segni di interpunzione: stigmai e paragraphoi segnalano pause<br />
più o meno forti, i doppi punti sono utilizzati, anche se non esclusivamente, per indicare, come d’uso,<br />
il cambio di battuta. I passaggi più significativi della struttura del dialogo, spesso evidenziati anche<br />
dai codici medievali, sono marcati dalla diple obelismene o dalla paragraphos più grande combinata<br />
con la coronide. La diple obelismene si trova due volte: a 201d1 in corrispondenza del punto in cui<br />
Socrate introduce il discorso di Diotima, dopo ἐάσω, e a 210a5 nel punto in cui Diotima inizia Socrate<br />
agli ἐρωτικά. Le coronidi segnano invece la fine del discorso di Socrate a 212c4 la fine del discorso di<br />
Alcibiade, 222c1 e la fine dell’intero componimento. Il testo, come abbiamo ricordato, è abbastanza<br />
corretto dal punto di vista ortografico.<br />
L’apporto del papiro alla costituzione del testo è positivo: il papiro conferma per lo più il testo<br />
tradito di fronte a molti interventi non necessari. Benché alcune novità rispetto ai codici primari che<br />
sanano guasti già emendati dai bizantini o dai moderni, o comunque già rilevati, non siano da<br />
trascurare, nella grande maggioranza dei casi le varianti appaiono tendenzialmente inferiori o<br />
equivalenti al testo medievale. Pochi sono, ma comunque assi utili per la costituzione del testo sono i<br />
casi nei quali le varianti risultano autentiche e pertanto preferibili al testo della tradizione medievale.<br />
Il nostro papiro è l’unico testimone che conserva a r. 1180 la preziosa lezione εἴσω ἄντικρυς con il<br />
significato “direttamente dentro” al posto di εἰς τὸ ἄντικρυς di 223b4, presente nella maggior parte dei<br />
codici, interpretato come equivalente al semplice ἄντικρυς “direttamente” e accolto da gran parte<br />
degli editori. L’uso di ἄντικρυς con articolo e preposizione non ha paralleli né spiegazione. È invece<br />
attestato con καταντικρύ “di fronte”: forse proprio all’influsso di καταντικρύ è da ricondurre l’origine<br />
dell’errore e quindi la sequenza εἰς τὸ ἄντικρυς. εἴσω ἄντικρυς descrive certo meglio dell’inusuale<br />
sequenza εἰς τὸ ἄντικρυς l’irrompere improvviso della folla di gaudenti nel simposio, alla fine del<br />
dialogo, nel momento in cui Agatone si accinge a sdraiarsi accanto a Socrate.<br />
Molti sono gli errori presenti nel papiro ma estranei alla tradizione medievale: si tratta per lo<br />
più di banalizzazioni emendate dall’intervento del diorthotes. Poche sono invece le varianti di cui non<br />
è facile ipotizzare l’origine. Non privo di significato per la storia del testo è inoltre l’accordo, se pure<br />
occasionale, in lezioni erronee o peculiari fra il nostro papiro e altri testimoni di età imperiale contro i<br />
codici. L’assenza poi di significativi casi di convergenza in errore con i codici primari suggerisce di<br />
collocare il testo del nostro papiro prima di una fase di selezione attraverso la quale è passata la<br />
tradizione di Platone giunta a noi. Le numerose coincidenze in errore tra il papiro e le singole famiglie<br />
4 Turner E.G., Greek Papyri. An Introduction, Oxford 1980 2 .<br />
76